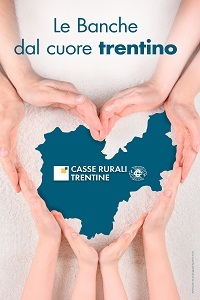«Autovoto 6+» – In mostra a Trento l’«arte come cura»
Le opere di pazienti psichiatrici di Villa San Pietro di Arco a Palazzo Trentini
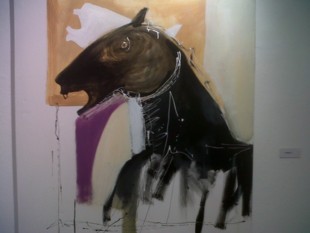
«L’estro è un attimo. Ho voglia di disegnare ma soprattutto di dipingere, tenere in mano i pennelli, dare il meglio di me in questa forma, in questo modo di esprimersi.»
Così Sara B., intervenuta a palazzo Trentini all’inaugurazione della mostra delle opere dei pazienti psichiatrici di villa San Pietro dal titolo «Autovoto 6+ Posso fare molto di più, impiego 30 minuti essendo Van Gogh», l’esposizione di un centinaio di opere realizzare da quattordici pazienti psichiatrici del Centro di riabilitazione psichiatrica di villa San Pietro di Arco.
Lo stesso titolo della mostra deriva da una nota che accompagna uno dei dipinti di un ospite della comunità.
La mostra, curata da Paolo Dolzan e Tommaso Decarli (della Galleria Argo di Trento) in collaborazione con Federica Santoni (responsabile dei laboratori artistici di Villa S. Pietro), si colloca nel solco di quella dello scorso anno – negli stessi spazi – dal titolo «Sanatorium» sul rapporto tra arte e malattia.
Nel corso dell’inaugurazione, alla quale ha partecipato una delegazione della Comunità San Pietro, è stato presentato il catalogo ed è stata messa in scena una performance sonora e poetica ideata da Massimo Arrigoni, Roberta Galbani (col monologo «Psicosi delle 4 e 48» della scrittrice inglese Sarah Kane), Sergio Decarli e Denis Fontanari.
Arrigoni (poeta sonoro e performer), accompagnato dal musicista Sergio Decarli (poliedrico artista che utilizza materiali riciclati dalle inedite possibilità sonore mescolandole con basi elettroniche) ha suonato quattro movimenti tratti da «Toy Piano» di John Cage, usando –come da spartito originale – un pianoforte giocattolo mignon (emulo di Schröder, l’amico di Charlie Brown).
Tra le varie opere (tempere o acrilici su carta o tela, penne, pennarelli e matite su carta, acquerelli, argille crude e smalti) segnaliamo almeno quelle di Vincenzo O., le ceramiche di Luca C. e, in particolare, gli acrilici e le raffinatissime matite colorate su carta di Loris P. (per il quale speriamo di vedere un giorno una mostra personale).
I lavori dei pazienti di villa S.Pietro sono affiancati (nel piano seminterrato) da quelli del duo Bruno&Pruno Ludke (Dolzan e Decarli) dedicate ad una condanna giudiziaria avvenuta in Germania ai primi del 900 in base ad elementi pseudo scientifici di origine lombrosiana.
Il catalogo contiene testi del filosofo Fabio Sergio Berardini, di Paolo Dolzan sul rapporto, nella storia dell’arte, tra disturbo psichico, psichiatria e creatività e di Federica Santoni.
Nella presentazione il Presidente Dorigatti scrive che «da rappresentante delle istituzioni democratiche, mi limito a fare ciò di cui sempre più ci sarebbe bisogno: aprire le porte al dubbio, concedere cittadinanza anche ai temi più faticosi da affrontare, dare valore civile a ciò che, comunemente, si confina negli angoli».


Paolo Dolzan, ringraziando il Consiglio che ha messo a disposizione le sale e contribuito all’inaugurazione, ha affermato che questa mostra è un segno importante di apertura delle istituzioni verso forme di libera espressione.
Approfonditi e illuminanti i saggi del catalogo: per Fabio Sergio Berardini (ordinario di Filosofia all’Università di Trento) il «dire no» è l’inizio del distacco dal quotidiano con le sue luci, le sue regole, le sue «banalità» rassicuranti e l’inizio della discesa agli inferi: è un farmaco che, come nell’etimologia greca, è veleno ma anche rimedio.
A deciderlo sarà la misura, il metron dei greci: c’è una misura anche nel «dire no», nel distacco, nell’alienazione.
La radicalità del «no» può causare una permanenza definitiva nel sottosuolo, lontano dagli altri e da sé.
L’arte può dunque rispondere a tale misura, può essere un «dire sì» dal mondo degli inferi, una rinascenza, un atto sorgivo di comunicazione che vince la solitudine e il ritorno all’umanità attraverso un gesto significativo.
Paolo Dolzan, artista tra i più significativi -e colti- del panorama speleologico del fare artistico contemporaneo, nel suo approfondito saggio, analizza il rapporto tra arte e follia: a partire dall’800 «assistiamo al congiungersi di due sentieri all’origine paralleli, quello dell’arte e quello della follia».
«Se nelle società tribali il folle era considerato un veggente ed aveva un ruolo di ponte molto simile a quello dell’artista-sciamano, la follia nel mondo occidentale ha invece una storia che è fatta di punizioni e di emarginazione.»

E qui Dolzan cita le tappe elencate dal filosofo francese Foucault nella sua «storia della follia», iniziando da quella nave dei folli (da Bosch in avanti) che conserva ancora un’idea diabolica della pazzia e che sembrano prefigurare, nel loro essere prive di timoni, remi e vele la «Zattera della Medusa» di Gericault.
Se il folle è nel medioevo una creatura indemoniata e sola, ma tuttavia temuta e rispettata, nei secoli successivi diventa un errante imbarcato sulle navi e dal ‘600 inizia ad essere internato (con l’invenzione dei manicomi).
Da un lato si afferma il pensiero chiaro e distinto e il lume della ragione, dall’altro le tenebre della deviazione irrazionale e sociale.
L’eugenetica, la frenologia, i piani religiosi e politici di supremazia di un certo popolo e razza, la moderna farmacopea psichiatrica diventano così armi per debellare l’individuo irrazionale, «socialmente deviato», sintomi del «grado di paura endemico» del potere.
Sfogliando le biografie dei grandi artisti Ottocenteschi internati –anche per brevi periodi- oltre a quello di Van Gogh, Dolzan, fa i nomi di Munch, Kirchner, Kokoschka, Lautrec.
Ma tuttavia, rispetto agli internati non creativi, gli artisti-letterati-pensatori funsero da cerniera tra il mondo di fuori e quello di dentro.
La loro esperienza fu spesso un’arma di resistenza e contestazione del sistema del potere permettendo anche l’evoluzione dello stesso pensiero positivista della psichiatria, ad esempio portando lo psichiatra tedesco Prinzhorn a interessarsi delle espressioni artistiche dei suoi pazienti quali rinforzo terapeutico dell’alienazione mentale.
Il suo lavoro superò i limiti della psichiatria innovando la terapia ipotizzando che la follia si potesse curare «dando libero sfogo all’impulso creativo del malato», considerando il folle artista tuttavia come uno psicotico che «non vuole ristabilire il contatto» con l’umanità individuando nei suoi quadri «il totale isolamento artistico», rifiutando la comunicazione sociale a favore, invece, di una semplice soddisfazione nel piacere ludico.


Di fatto egli può essere considerato l’iniziatore della pratica dell’arte terapia. Ma per Dolzan questo concetto è oggi desueto e superato.
«Nella pratica di arte-terapia ciò che impedisce allo psicotico di essere un artista non è da ricercarsi nell’autoreferenzialità e neppure nella ricerca esclusiva del piacere ludico: nella malattia psichica, un handicap è spesso rappresentato dalla mancanza di disciplina nell’esercitare una duplice vigilanza – all’esterno e verso la propria coscienza – questa è la condizione necessaria per progredire in una ricerca.» In un mondo, come quello attuale, in cui l’artista deve creare da sé le regole, l’arte non può più per Dolzan aiutare nella terapia di guarigione del disagio psichico ma addirittura aggravarlo, aumentando le inquietudini, rafforzando la personalità alienata rendendola immune agli alti dosaggi di morale, religione che sedano la quotidianità dell’uomo comune.
Insomma, un parte di arte può essere un «tonificante», troppa un rischio di accentuazione dell’alienazione-distacco.
La mostra «Autovoto 6+» rimarrà aperta fino al 6 luglio con orario 10.00-18.00 (da lunedì a sabato). Domenica chiuso.
Massimo Parolini