Lectio Degasperiana/ 1 – Di Maurizio Cau
«Silenzio delle patrie e fedeltà trentina – De Gasperi nella prima guerra mondiale»
> La genesi del nostro mondo
La Grande Guerra italiana tra Europa e Trentino
di Marco Mondini
È stato George Kennan, un intelligente diplomatico e poi accademico statunitense, a definire negli anni Cinquanta la prima guerra mondiale come la «catastrofe originaria del Novecento». Si tratta di una definizione molto fortunata, altrettanto abusata e ampiamente ambigua.
Kennan gettava uno sguardo scettico sul significato della Grande Guerra, per lui un esempio di inefficienza: cinque anni di battaglie avevano comportato un buon risultato giusto (liberare l’Europa dall’ingombrante peso politico degli Hohenzollern e dal militarismo prussiano) ma pagato a troppo caro prezzo. E’ un giudizio condivisibile? In che senso la guerra del 1914-18 è stato il tornante della storia contemporanea? Come ha plasmato il mondo in cui viviamo?
Per cercare di rispondere a tali questioni vorrei focalizzare il mio intervento su tre punti che possono aiutarci a comprendere il significato profondo della Grande Guerra. Il primo: il 1914 fu senza dubbio una svolta radicale nella storia europea, ma più che di catastrofe si dovrebbe parlare di un’apocalisse dai molteplici aspetti.
Il secondo: la guerra fu un evento travolgente e uno spartiacque per tutti gli italiani, i cittadini del Regno d’Italia così come per gli italiani d’Austria, ma lo fu in termini assai differenti dal resto dell’Europa.
La guerra italiana è fondamentalmente irriducibile a ciò che francesi, tedeschi o inglesi vissero (e soprattutto ricordarono) del grande conflitto. Il terzo: esistono poche comunità in Europa che siano state provate e sconvolte così radicalmente dalla guerra come i Trentini. Terra di frontiera, politica e culturale, il Trentino subì tutto ciò che un conflitto moderno poteva portare con sé, dalla sparizione sui campi di battaglia di una generazione di giovani maschi alla deportazione di massa delle popolazione civile.
Il Trentino fu fronte di battaglia, territorio occupato, simbolo ideale della guerra e i suoi abitanti combatterono, sotto le bandiere di tutti i contendenti, tre guerre diverse, alla fine delle quali, in modo alquanto paradossale, a segnare la memoria collettiva non furono le migliaia di morti con la divisa dell’armata regia e imperiale ma alcune centinaia di volontari arruolatisi con l’esercito italiano.
Non meno apparentemente bizzarro è il fatto che tra i Trentini, una comunità umana relativamente piccola, si trovassero alcuni dei protagonisti principali della tormentata neutralità italiana: Cesare Battisti e Alcide De Gasperi furono attori di primo piano, con ruoli diversi, di quel periodo lacerante.
Definire la guerra un’apocalisse significa in primo luogo riportare alla luce il suo carattere germinale oltre che semplicemente distruttivo: non fu semplicemente la fine, ma anche la rivelazione, la scoperta e in definitiva l’inizio di un nuovo mondo. Naturalmente, in primo luogo il conflitto fu un’ecatombe.
Benché le cifre dei caduti sul campo di battaglia siano ancora oggi del tutto approssimative, tra nove e undici milioni di combattenti morirono al fronte o per le ferite riportate (o furono dichiarati dispersi), una cifra a cui andrebbero sommati almeno altri sei milioni di civili, tra vittime delle occupazioni, della fame e dell’epidemia di spagnola (su queste ultime i dati sono ancora più vaghi).
ia pure con notevoli differenza tra paese e paese, nel corso dei cinque anni di guerra venne chiamato alle armi un maschio adulto su due (dai 18 ai 45 anni), e di questi in media uno su sette non fece più ritorno a casa. Negli anni successivi, ad una società europea priva di giovani uomini il lutto di massa sarebbe sembrato una ferita destinata a non rimarginarsi mai. Il sacrificio degli eroi in uniforme venne immortalato dai monumenti ai caduti, che tendevano a sottolineare la bellezza della morte per la patria, ma milioni di mutilati resi permanentemente invalidi (in Italia furono quasi mezzo milione) che la guerra aveva risparmiato spesso solo per restituirli ad una vita di sofferenze e privazioni popolavano le strade ricordando a tutti, come avrebbe scritto trent’anni dopo Blaise Cendrars, che «Dio era scomparso dai campi di battaglia».
Queste cifre sono talmente alte (i morti in uniforme furono proporzionalmente molti di più di quelli della seconda guerra mondiale) da spingere la nostra sensibilità odierna, di nati dopo il 1945, a etichettare la guerra come uno straordinario massacro senza alcuna ragione possibile.
La popolarità della categoria di inutile strage, secondo la famosa definizione di Benedetto XV nella sua lettera ai capi dei popoli belligeranti dell’agosto 1917, deve essere ricondotta soprattutto al fatto che, per quanto ci riguarda, nulla può giustificare una carneficina di tali proporzioni.
Eppure, a molti contemporanei (che per la verità spesso non avevano una piena comprensione del costo umano di ciò che stava succedendo) questa strage poté sembrare, soprattutto all’inizio, tutt’altro che inutile. Tra le élites politiche, gli intellettuali, gli studenti, i giovani e in generale le persone colte, erano in molti nel 1914 a pensare che la guerra fosse uno strumento legittimo e persino sano, una «catastrofe necessaria» per la risoluzione delle controversie e per il raggiungimento degli scopi nazionali.
Per costoro, il sacrificio di molti (e anche di se stessi) sul campo di battaglia pareva un prezzo ragionevole se avesse portato alla sconfitta dei nemici tradizionali della propria patria, alla liberazione dei compatrioti asserviti allo straniero oppressore (una formula che a noi suona bizzarra, ma che descrive bene i sentimenti di molti milioni di francesi, per esempio), alla sconfitta delle autocrazie militariste o alla liberazione e all’indipendenza della propria comunità nazionale.
Naturalmente, questo pensiero non era così articolato né pacato tra i molti milioni di coscritti che provenivano dagli strati più bassi e meno colti delle popolazioni rurali, arruolati e mandati al fronte in obbedienza alle leggi, non certo per proprio desiderio. Ma non va dimenticato che la Grande Guerra fu anche (e in certi casi, come quello britannico e tedesco, soprattutto) uno scontro di volontari consapevoli.
E, del resto, anche il rapporto con la morte tra i molti umili (una definizione alquanto generica e fuorviante) che affollavano le trincee del 1914-1918 era ben diverso dal nostro: la morte era, per molte ragioni, parte integrante dell’esperienza quotidiana di popolazioni la cui esistenza era molto più malcerta e difficile della nostra (basti pensare ai tassi, per noi assolutamente inaccettabili, di mortalità infantile – il 15,6% nell’Italia del 1911 – e l’età media alla morte, di 30 anni).
Morire per qualcosa (o qualcuno) poteva sembrare alla generazione del 1914 (e del 1915) molto meno intollerabile di quanto oggi si possa essere portati a pensare: l’appello al dovere delle armi venne accettato con disciplina e rassegnazione dalla grande maggioranza dei maschi combattenti e delle loro famiglie.
Abbastanza paradossalmente (per noi) il consenso delle popolazioni coinvolte continuò a essere tendenzialmente costante per tutta la durata del conflitto. Ciò non significa che la guerra sia stata intrapresa e vissuta a cuor leggero o come una bella avventura (c’erano anche coloro che lo facevano, ma erano una sparuta minoranza di ingenui). Il mito dell’«entusiasmo di guerra» fu coniato frettolosamente a guerra in corso e le stesse manifestazioni di massa di devozione nei confronti delle case regnanti e dei capi di stato, che si verificarono nelle capitali del 1914, furono limitate a qualche decine di migliaia di giovani borghesi e studenti delle grandi città.
La gran parte dei maschi in uniforme marciò verso la battaglia con risolutezza e senza proteste, ma certo non con il sorriso sulle labbra. Eppure marciarono. E continuarono a marciare anche quando cominciarono a giungere le notizie sulle prime carneficine e sulla fine della guerra di movimento che era stata immaginata (e idealizzata) per tanti anni. Il dissenso nei confronti del conflitto (proteste collettive, diserzioni di massa, renitenza, fuga) fu un fenomeno talmente limitato da sorprendere le stesse autorità: in Francia, in Germania, e persino nell’Italia del 1915.
Non si trattava di un’adesione emotiva alle ragioni della guerra, ma di un rapporto radicato con il senso del dovere connaturato alla cittadinanza (o all’appartenenza alla comunità dei sudditi, a seconda). Senza cogliere le radici profonde di questa devozione profonda è difficile capire come sia stato possibile che l’“inutile strage” possa essere durata così tanto (il contro esempio russo dimostra bene come sarebbe stato possibile rovesciare la situazione).
Il 1914 fu l’apogeo di questa identificazione del cittadino europeo con il sacrificio come intrinseca qualità del suo rapporto con il potere, ma fu anche il tornante di questo rapporto. Dopo il 1918 (e a maggior ragione dopo il 1945) i rapporti tra singolo e Stato sarebbero cambiati radicalmente.
Ma per capire gli europei della grande Guerra è a quel sentimento che dobbiamo guardare, non alla nostra sensibilità, e dobbiamo rifuggire da facili vittimismi anacronistici. La convinzione che sui campi di battaglia si stesse combattendo per un nuovo (e migliore) ordine mondiale sopravvisse al disincanto dei primi mesi e al riconoscimento (ampiamente diffuso anche tra i testimoni più militanti) che la guerra moderna si era rivelata un orrore industriale molto lontano dai sogni di prodezze eroiche coltivate sui banchi di scuola dalla generazione dei volontari.
È forse uno degli aspetti più difficili da comprendere della grande conflagrazione del 1914-18, ma è un fatto che la maggioranza dei testimoni che diedero alle stampe i propri diari e le proprie memorie riconobbero senza esitazione la tragica realtà della trincea, la stupidità dei generali e il cinismo indifferente dei leader politici, senza tuttavia mai rinnegare la convinzione che la guerra fosse necessaria.
In questo contesto generale, che riguardò con elementi comuni molto forti tutta la cultura e la società europee dell’epoca, la guerra italiana rivestì un ruolo del tutto particolare, e per molte ragioni.
La prima, è che a differenza di tutti gli altri contendenti, entrati in guerra come “sonnambuli”, il Regno d’Italia entrò in guerra sapendo esattamente cosa stava succedendo (il che non significa che militari e politici fossero più preparati) ma soprattutto lo fece alla fine di dieci mesi di scontri, sommosse, guerriglia urbana, stati d’assedio, omicidi politici che ampliarono le fratture sociali e ideologiche della giovane nazione. Nei dieci mesi della neutralità e della contesa neutralisti-interventisti si raggiunsero livelli di violenza tali da poter parlare tranquillamente di una guerra civile non dichiarata.
Per molti versi, l’intervento, ancora prima di essere la decisione di una ristrettissima minoranza politica e un’imposizione dell’esecutivo sul parlamento (per quanto all’interno della correttezza statutaria) fu una vittoria ideologica di una parte del Paese (fondamentalmente, le élites colte delle città settentrionali) sull’altra, una frattura che sarebbe sopravvissuta alla conclusione vittoriosa del conflitto.
In Italia non ci fu nessuna Burgfrieden, nessuna pace sociale in nome dei più alti destini dello stato-nazionale. Il primo nemico da battere, molto prima dell’austriaco e del tedesco sul campo di battaglia, rimase, nelle retoriche pubbliche, nei discorsi e nella memoria di molti testimoni dell’epoca, il nemico interno, disfattista, neutralista, traditore; dall’altra parte, l’odio per il borghese guerrafondaio che mandava a morire contadini e operai divenne un’immagine diffusa.
Entrambe queste icone della conflittualità avrebbero giocato un ruolo importante nel primo dopoguerra.
Ciò non significa che gli italiani del 1915-18 non abbiano dimostrato una compattezza insospettabile. Le proteste che erano divampate nei mesi della neutralità (ai primi richiami alle armi vennero occupate stazioni e piazze urbane che vennero sgomberate con la cavalleria e l’artiglieria) cessarono improvvisamente dopo il 23 maggio. I tassi di diserzione e renitenza calarono drasticamente e in alcune ragioni si registrarono fino al 120% di arruolati rispetto agli uomini che teoricamente dovevano andare sotto le armi, a causa del rientro degli emigrati all’estero, volontari de facto se non di diritto (altre decine di migliaia rimasti all’estero non furono mai perseguiti).
Il comportamento delle truppe al fronte e dei civili mobilitati, con l’eccezione di alcuni scoppi di protesta rapidamente rientrati, fu tendenzialmente improntato ad una rigorosa disciplina, tanto da stupire per primi i generali e i prefetti che si aspettavano ammutinamenti di massa e incontrollabili sommosse socialiste nei centri urbani. Pur tenendo presente che la mobilitazione totale aveva portato con sé il dispiegamento di una capillare legislazione repressiva, la sospensione di diverse garanzie statutarie e un inasprimento dei meccanismi di disciplinamento e controllo, il giudizio complessivo non può non sottolineare che l’Italia liberale affrontò la guerra molto più efficacemente, sotto tutti i punti di vista, di quella teoricamente molto più preparata e marziale del 1940.
La guerra del Regno d’Italia fu in differita da un punto di vista strettamente diplomatico e militare, ma non lo fu da un punto di vista culturale, e questo è un altro elemento che la rende l’esperienza italiana unica rispetto al resto d’Europa. Fin dall’estate 1914, gli italiani che abitavano nella penisola vissero la guerra, che divenne una presenza quotidiana. Da un lato, gli italiani vennero bombardati dal più grande racconto bellico per immagini che l’industria dell’informazione europea era riuscita fino a quel punto ad orchestrare.
Si trattava, naturalmente, di immagini fotografiche e pittoriche estremamente edulcorate, ma non diverse da quelle che circolavano (e venivano censurate) nelle retrovie francesi, tedesche, britanniche. Nella penisola si parlava di guerra, si discuteva di battaglie, si respirava l’attesa spasmodica per un evento che sembrava inevitabile. Sull’inevitabilità politica dell’intervento si sono spese lungo tutto un secolo pagine e pagine di dibattito.
Le estenuanti trattative tra Italia e Austria, con la mediazione della Germania, e tra Italia e Intesa, sono state ricostruite analiticamente, e del resto non erano esattamente un segreto nemmeno all’epoca (le vignette satiriche su un basso e baffuto Vittorio Emanuele III che assiste impassibile al tiro alla fune tra i due contendenti meditando su quale partito scegliere testimoniano efficacemente cosa l’opinione pubblica internazionale pensasse della coerenza diplomatica del Regno d’Italia già nel 1914).
Le dettagliata cronache dei negoziati e le molte memorie date alle stampe restituiscono con una certa efficacia i sottili equilibri, le molte incertezze, le pressioni diverse e le previsioni invariabilmente sbagliate tra cui si districò il governo Salandra. Le trattative degli ex alleati per tenere fuori l’Italia dalla guerra naufragarono infine, all’inizio del 1915, e in parte non piccola per la rigidità e la malafede dell’atteggiamento austriaco. Ma ciò che più importa è ricordare come, molto prima, la guerra venisse percepita come confusamente «inevitabile» in larghi segmenti sociali. Non si sapeva bene né quanto sarebbe durata, né come la si sarebbe fatta (e per alcuni neanche contro chi), ma a tutti pareva evidente che il paese avrebbe partecipato in qualche modo al conflitto europeo, se non altro perché da decenni era previsto che solo una grande guerra avrebbe permesso di portare a termine il programma risorgimentale e (soprattutto) di legittimare la promozione dell’Italia nel novero delle grandi potenze. Come avrebbe detto Ugo Ojetti, ascoltato opinionista dell’epoca e futuro regista degli uffici di propaganda, la guerra per gli italiani era diventata come una febbre che non voleva finire, e molti aspettavano solo che si mettesse la parola fine alla lunga attesa. Anche in questo caso, l’apocalisse fu ricca di disincanti. La guerra che avrebbe segnato la prova della maturità per il giovane stato e la fine del suo tribolato programma nazionale, con l’ingresso di tutti gli italiani nei confini del Regno, portò con sé alla fine più problemi che soluzioni: l’Italia vinse la guerra, ma al contrario di quello che sarebbe successo trent’anni più tardi, perse clamorosamente la pace.
Fu alla sua fine che la Grande Guerra rivelò più chiaramente la sua dimensione di fucina di un nuovo mondo. La sua conseguenza più visibile e ovvia fu che segnò il tramonto di imperi secolari, la fine degli agglomerati multinazionali e l’affermazione definitiva degli stati nazionali (non senza qualche contraddizione). A Versailles nel 1919 si disegnò una carta politica che la seconda guerra mondiale avrebbe per molti versi stabilizzato e definito, ma non più rivoluzionato. Soprattutto (anche se non solo) in questa prospettiva, il caso del Trentino è ancora oggi un osservatorio straordinario per comprendere l’impatto e le eredità della Grande Guerra sugli europei.
Comunità di frontiera, politicamente e culturalmente, i Trentini, come tutti gli altri italiani d’Austria, iniziarono il grande conflitto senza alcuna rottura traumatica con la propria tradizione di lealismo alla casa regnante di Vienna. Nell’estate 1914, la disciplina delle operazioni di arruolamento stupì prima di tutto le autorità locali e i comandi militari, che si aspettavano qualche resistenza in più e un tasso di renitenza ben superiore da parte dei molti emigrati fuori confine. Eppure, almeno 55.000 trentini italofoni obbedirono alla chiamata alle armi, mentre meno di un migliaio preferirono rifugiarsi in Italia, ritenendo la guerra con la divisa asburgica contraria alla propria coscienza e alle proprie idealità.
Un altro aspetto straordinario del ruolo del Trentino e dei Trentini fu l’importanza che questa piccola comunità ebbe sulla genesi dell’entrata in guerra dell’Italia. E’ ben noto che, tra i vari obiettivi politici e simbolici dell’intervento del Regno d’Italia, il destino di Trento era, rispetto a Trieste, relativamente meno spinoso nell’ambito delle trattative italo-austriache che vennero ben presto intavolate quando fu chiaro non solo che l’Italia non si sarebbe allineata alla guerra austro-tedesca ma avrebbe potuto denunciare la vecchia Triplice Alleanza.
Il Trentino non era (a differenza dell’antica contea del Tirolo) parte integrante del nucleo storico degli Erbländer e l’Austria l’avrebbe ceduto volentieri in cambio della garanzia italiana di una neutralità benevola (i delegati austriaci e i vertici militari, del resto, pensavano che si sarebbero potuti rimangiare la promessa a guerra finita e vinta). D’altra parte, il governo italiano riconosceva in Trento un obiettivo economicamente e politicamente meno rilevante di Trieste, e l’ostinazione nel rendere inscindibili al tavolo dei negoziati le due città irredente fu uno dei motivi del fallimento di ogni margine di trattativa.
Al contrario, pur non godendo di una gran tradizione in questo senso, i Trentini furono attivissimi nella campagna interventista e il piccolo nucleo dei fuoriusciti militanti (tra i quali Cesare Battisti e il nucleo degli studenti trentini a Rovereto, di cui faceva parte Damiano Chiesa). Ancora prima di divenire il protomartire della nazione in guerra, segnando con il suo “consapevole sacrificio” (come venne subito etichettato) uno dei punti più alti della rappresentazione eroica della guerra, Battisti fu un rivoluzionario delle tecnica di comunicazione. Proprio a Torino, il 12 ottobre 1914, Battisti inaugurò il lungo tour di comizi e interventi pubblici che l’avrebbe portato in tutta la penisola a sostenere la causa dell’intervento contro il paese di cui era anche parlamentare: “io vengo in nome dei figli di Trento e di Trieste a chiedervi che voi completiate l’opera dei vostri padri” fu l’esordio del suo appello agli Italiani.
Questi comizi disegnarono la prima campagna mediatica su scala nazionale della storia politica unitaria, e una delle occasioni in cui si delineò più violentemente il conflitto interno tra interventisti e neutralisti. Iniziata dal Regno d’Italia come una crociata per la liberazione dei “fratelli irredenti” – o almeno così recitavano gli slogan più in voga delle retoriche pubbliche interventiste – la guerra provocò trasformazioni radicali non solo nelle strutture demografiche, sociali ed economiche delle terre coinvolte, ma anche (e per certi versi soprattutto) nei panorami mentali. Forse il caso più eclatante fu proprio il legame psicologico e la percezione del senso di fedeltà politica che legava Trento alla dinastia imperiale di Vienna (Kaisertreue). Come proprio Alcide De Gasperi (un efficace testimone oltre che un instancabile mediatore della politica di guerra come dirà Maurizio Cau fra poco) avrebbe notato, ancora nel 1914 i legami di fedeltà politica tra italiani d’Austria e capitale erano tutto sommato solidi, e soprattutto nelle comunità rurali.
Nella primavera 1915, l’intervento dell’Italia provocò una isterica e per molti versi estremamente stupida ventata di politiche repressive nei confronti della popolazione italofona. Da queste comunità provenivano molte migliaia di combattenti che da quasi un anno stavano morendo sul fronte galiziano in nome dell’Imperatore (oltre 11.000 soldati, circa un quinto dei trentini mobilitati furono uccisi durante la guerra vestendo l’uniforme imperiale, con uno dei tassi di mortalità più alti mai registrati nelle guerre del Novecento), il che non impedì ai comandi militari, che avevano assunto il controllo della provincia, di varare misure di deportazione in massa e di internamento politico senza precedenti.
Quasi 80.000 sudditi austro-ungarici di lingua italiana vennero costretti ad evacuare e coattivamente trasferiti nei territori dell’interno dell’impero, senza nessun’altra ragione se non il sospetto che potessero simpatizzare per il “nemico italiano”. 35.000, più o meno tutti i deportati abili al lavoro, vennero sparpagliati nei villaggi e avviati al lavoro, risultando di fatto un’utile manodopera a basso costo che contribuì a sostenere la traballante economia di guerra austriaca.
25.000 inabili vennero rinchiusi in grandi campi di raccolta (come Mitterndorf o Braunau), altri duemila (più o meno tutta l’élite dirigente trentina) venne internata come prigioniera in campi di concentramento, tra cui soprattutto il famigerato lager di Katzenau. Fu una delle più sistematiche operazioni di sradicamento etnico e di guerra punitiva ai civili che la grande Guerra ricordi, e non sorprende se, ancora più dei massacri in Galizia, è a questa aggressiva pulizia etnica che si deve attribuire il collasso dell’autorità asburgica nelle sue province di confine.
D’altra parte, il trattamento riservato a molti trentini dall’esercito italiano «liberatore» non fu a volte molto migliore. Quasi 30.000 residenti dei territori occupati dagli italiani nel 1915 vennero evacuati più o meno volontariamente dopo la controffensiva di primavera austriaca nel 1916 e soprattutto dopo il collasso del fronte in seguito alla disfatta di Caporetto del 1917. Tra questi, poco meno di duemila, etichettati come «austriacanti» in base a volte a prove a volte a semplici denunce non circostanziate, vennero deportati nei campi di prigionia dell’Italia meridionale (o nel famigerato campo dell’Asinara) e sottoposti al duro trattamento riservato ai prigionieri di guerra.
I Trentini ebbero così il discutibile privilegio di venire perseguitati da tutti e due le autorità militari in campo, sia coloro che teoricamente li avrebbero dovuti tutelare in quanto concittadini e fedeli sudditi (l’armata imperial-regia) sia coloro che sempre teoricamente li avrebbero dovuti liberare come fratelli irredenti (il regio esercito italiano). Questo regime di doppia militarizzazione e doppia persecuzione ne farebbe già un caso unico nella guerra europea, se non si ricordasse che, oltre ad aver combattuto nelle fila di due eserciti differenti, alcune migliaia di Trentini ebbero il non particolarmente ambito onore di combattere due (o tre) guerre differenti.
Mi riferisco alla vicenda per certi aspetti paradossale ma significativa degli ex prigionieri dell’esercito austro-ungarico in Russia, liberati in quanto considerati italiani a partire dal 1915, riorganizzati da una missione militare inviata da Roma ed evacuati nel caso della rivoluzione russa, per ritrovarsi a combattere (senza particolare entusiasmo) al comando di ufficiali italiani nella guerra civile russa.
L’anabasi di queste migliaia di ex prigionieri, il cui «lungo ritorno» in patria terminò solo negli anni Venti (non senza transitare in alcuni casi da altri campi di prigionia), è uno degli episodi più emblematici di una guerra vissuta sotto più bandiere, sotto diverse identità e vissuta molto al di là dei confini temporali e spaziali canonici.
Fu soprattutto per la popolazione civile e i deportati che la fine della guerra e l’occupazione da parte dell’esercito italiano rappresentarono una liberazione, se non altro dalla durissima militarizzazione imposta dalle autorità imperiali, caratterizzata da un’economia di rapina non dissimile da quella imposta ai territori stranieri occupati.
Che, poi, il passaggio all’Italia abbia rappresentato, rispetto ai vagheggiamenti di regimi d’autonomia del tutto assenti negli ordinamenti del Regno, una delusione, è un fatto, benché questa abbia paradossalmente caratterizzato più gli irredentisti militanti che la maggioranza della popolazione. In effetti, il trattamento riservato agli ex nemici (ai combattenti k.u.k oltre alla popolazione civile) fu comparativamente molto intelligente, anche grazie ad un’amministrazione transitoria, quella affidata al generale Pecori Giraldi, improntata a grande sensibilità.
Rispetto ai suoi stessi precedenti (il trattamento riservato ai civili trentini dei territori occupati nel 1915 e 1016 non era stato esattamente encomiabile), l’autorità italiana rivelò doti di notevole acume e diplomazia.
Non ci fu alcuna epurazione del personale amministrativo, i funzionari furono lasciati perlopiù al loro posto e soprattutto il governo del Regno prese in carico il trattamento dei prigionieri, dei caduti e delle famiglie degli ex soldati asburgici con una generosità (vennero parificati a combattenti italiani in tutto e per tutto) sconosciuta ad altri governi alleati.
Anche grazie a questi provvedimenti, la transizione negli aspetti pratici della vita fu molto più morbida di quello che ci si sarebbe potuti aspettare. A ciò corrisposero, d’altra parte, politiche assai più rigide nei confronti dell’elaborazione della memoria, che il fascismo avrebbe rafforzato: la guerra dei Trentini divenne una guerra solo italiana, e tale sarebbe rimasta per molti decenni.








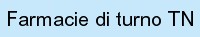














































Invia il tuo commento