Dora, quando la vita vince la morte – Di Gherardo Del Nista
Nel Giorno della Memoria, il memoriale di un uomo (deceduto nel 2010) che era sopravvissuto al campo di concentramento KZ di Dora Mittelbau - Nordhausen

>
Qualche anno fa avevamo pubblicato la storia di Oscar Zannini (vedi), un medico italiano che era stato deportato in Germania per aver curato dei partigiani.
Zannini, dopo una lunga peripezia da un campo di concentramento all’altro, era finito nel campo di Dora.
Oggi pubblichiamo la storia di un altro sventurato, che però riuscì a sopravvivere e tornare a casa.
È impressionante quello che racconta della sua odissea, ma ci pare complementare alla storia di Oscar Zannini, uno dei tanti dimenticati nel vento.
Visto che il racconto è lungo 12 pagine, lo dividiamo in tre parti: oggi, domani e l'ultima dopodomani.
1. L’inizio
Eravamo ai primi di marzo del 1940, quando mi fu notificata la cartolina di precetto per il servizio militare di leva. Partii il giorno 10 dello stesso mese (avevo ventuno anni non ancora compiuti) e fui assegnato al 35° Reggimento Artiglieria Someggiata, in stanza a Livorno, la mia città. Alla notizia seguì il mio entusiasmo, poiché mi trovavo vicino a casa, ma fu solo un’illusione di breve durata.
Successivamente all’entrata in guerra dell’Italia (10 giugno 1940), alleata con la Germania nazista, ben presto partimmo da Livorno; dopo pochi mesi fui trasferito con tutto il battaglione in Piemonte, esattamente a Cavallermaggiore, in provincia di Cuneo, in attesa di recarci al fronte per combattere contro l’esercito francese, che avanzava rapidamente verso l’Italia.
Ma, per volere di Dio e della fortuna, i francesi chiesero la resa: lo scontro fu quindi evitato. Dopo alcuni mesi ancora, la Jugoslavia entrò in guerra contro l’Italia: questo avveniva mentre negli altri paesi europei i combattimenti erano già molto accesi. In quel periodo e per causa degli avvenimenti, le truppe che si trovavano in Piemonte furono dislocate nel Veneto, a San Pietro del Carso, pronte a scontrarsi con l’esercito slavo, che a sua volta marciava verso i confini italiani.
Una doverosa precisazione. L’esercito cui appartenevo, non era adeguatamente equipaggiato per fronteggiare un qualsivoglia assalto: basti pensare che come strumenti bellici avevamo degli obici 75/13, che riuscivano a sparare solo fino a sei chilometri di distanza. Eravamo già preparati al peggio quando ci giunse, tanto gradita quanto inaspettata, un’altra buona notizia: l’esercito slavo, stremato, chiese anch’esso la resa, così tutto finì ancora prima di cominciare.
Dopo questo ulteriore evento continuammo la nostra marcia verso Zagabria dove, dopo un solo giorno di riposo e nonostante fossimo sfiniti dalla fatica, dovemmo ritornare – sempre a piedi - a Postumia, allora italiana. Come se ciò non fosse stato sufficiente, ci condussero a fare il campo a San Quirico d’Orcia, in provincia di Siena, non lontano da Montepulciano.
In questo periodo ebbi un diverbio con un mio superiore, un sergente maggiore che ancora ricordo: Giacomo Agricola, nativo di Ispica, in provincia di Ragusa. A quel punto, stufo di tutto, decisi di presentare domanda nei Carabinieri ausiliari, con obbligo di permanenza nell’Arma per ulteriori sei mesi una volta che fossero terminate le ostilità belliche.
La domanda ottenne positivo riscontro e per tre mesi frequentai la Scuola Allievi di Roma, assegnato alla prima Compagnia, primo plotone. Successivamente fui trasferito nella città di Massa Carrara, dove condussi «vita buona» per poco più di due mesi finché, nel dicembre del 1941, fui mobilitato e trasferito in Albania.
L’imbarco avvenne la sera della vigilia di Natale: incolonnati per tre, stavamo per raggiungere il porto di Bari quando, nei pressi del Policlinico all’epoca ancora in costruzione, mi staccai dalla fila ed entrai in una pasticceria per comprare un panforte, pensando di potermelo gustare sulla nave, durante il tragitto; in quel modo festeggiai il mio Natale 1941.
Mentre la nave incrociava verso la costa slava, pensai che quella poteva essere l’ultima leccornia che avrei assaporato, perché quel modo di festeggiare il Natale poteva essere anche l’ultimo. Pieno di nervosismo, con il timore che la nave potesse essere silurata dal nemico e affondata, non chiusi occhio per tutta la notte, ma andavo continuamente dal ponte di coperta alla stiva, scavalcando altri miei commilitoni che dormivano e seguivano il mio stesso destino.
Finalmente, all’alba del 25 dicembre 1941, da lontano riuscivamo a scorgere, seppure a malapena, la costa albanese. Alle ore 9 il battello, stracarico di persone, materiali, armi, muli e cavalli, approdò al porto di Durazzo. Provai un grande sollievo nel toccare nuovamente la terraferma, al punto che giurai di non tornare più in Italia via mare.
2. L’Albania
Dopo un giorno di viaggio sul camion militare, attraversando valli e monti ricoperti di neve, soffrendo un freddo pungente, inimmaginabile, raggiunsi Prizren, dove si trovava il Comando Battaglione Carabinieri. Il giorno seguente, dopo aver dormito per terra, su un improvvisato giaciglio di paglia, ripresi il cammino per altri due giorni, finché raggiunsi il villaggio di Delevo, in mezzo alle campagne albanesi. Benché la località non fosse molto amena, per circa un anno e mezzo condussi vita da «gran pascià»: tutto era calmo, all’infuori di qualche scaramuccia tra civili albanesi, montenegrini e serbi; l’inferno della guerra, che contemporaneamente infiammava l’Europa, sembrava per noi appartenere ad un altro pianeta.
Dopo quel periodo fui nuovamente trasferito, questa volta ad un posto di blocco: esattamente a Pec, sul confine della Jugoslavia; anche durante quella breve permanenza, la mia vita militare poteva definirsi «passabile».
In questa apparente monotonia giunse il fatidico 8 settembre 1943. Rientrai in caserma per l’ora di cena e, mentre con gli altri carabinieri stavamo consumando il pasto serale, il bollettino radio delle ore 20 comunicò che l’Italia aveva chiesto l’armistizio: così la guerra, almeno per il nostro Paese, sembrava finita.
È difficile esprimere la gioia che esplose, improvvisa e corale in tutti noi dopo aver ascoltato la notizia: facemmo una gran festa, sicuri che ben presto saremmo tornati alle nostre case; in realtà si trattava di una breve ed effimera illusione.
Non sapevamo ancora che il peggio doveva arrivare, poiché da alleati come eravamo con i tedeschi, improvvisamente ne diventammo i nemici da combattere.
Infatti, il primo ordine che ci pervenne dal nostro comando battaglione fu quello di abbandonare tutto e recarci prima possibile al comando stesso, che si trovava nei pressi di Gojakovici, distante da noi circa venti chilometri.
Caricammo su un camion tutto quanto ci fu possibile reperire nell’immediato e ci mettemmo in viaggio. Ricordo molto bene che quel giorno era immerso in un’atmosfera particolare: nell’aria regnava una strana e sinistra calma, tanto insolita quanto presaga di sventure.
Giunti a metà di quella strada tortuosa, che si snodava in mezzo ad un fitto bosco, la strada ci fu improvvisamente sbarrata da una pattuglia di soldati tedeschi, che avanzando verso di noi con i mitra spianati ci intimò l’«Alt!»: con l’eloquente linguaggio delle armi, ci fecero segno di seguirli.
A quel punto, non potendo reagire, obbedimmo senza opporre resistenza. Ci condussero fino alla città sopra ricordata e ci rinchiusero in un recinto, dove arrivavano continuamente soldati di tutte le armi i quali, come noi, erano stati rastrellati nelle altre località albanesi.
Dopo averci tolto tutte le armi, ci trattennero diversi giorni senza cibo, con la promessa (falsa) che ci avrebbero rimpatriato in Italia attraverso la città di Fiume, perché per gli italiani la guerra era finita. Ancora un lampo di gioia si accese dentro di noi, alimentato dal fatto di ritornare nella nostra Italia, ma non finì così.
3. L’arresto
9 settembre 1943: da quel giorno fummo preda degli artigli nazisti, privati delle armi e della libertà.
Il neonato governo Badoglio, tramite un bollettino radiotrasmesso, raccomandò di non molestare chi non ci molestava: anche volendo, come avremmo potuto reagire?
Dopo circa venti giorni ci radunarono tutti in un piazzale, naturalmente ben recintato da filo spinato, annunciandoci: È arrivata l’ora della vostra partenza per l’Italia, però dovrete affrontare una lunga marcia a piedi per raggiungere la città bulgara Skopje; naturalmente questo annuncio risollevò il morale di tutti noi. Senza cibo, sfiniti dalla stanchezza, con tutto il fardello dello zaino da portare in spalla, giungemmo finalmente alla stazione ferroviaria di Skopje.
Dopo alcune ore di attesa, arrivò in stazione un treno interamente composto da carri-bestiame, sui quali i soldati tedeschi ci fecero salire in ragione di sessanta uomini per ogni vagone, tanto che sembrava di essere come le classiche acciughe nel barile; ad un’ora imprecisata il convoglio partì.
Tutti i vagoni erano completamente aperti, senza nessuna guardia, sentinella, o altro segno di costrizione o impedimento di movimenti, tanto che ad ogni stazione in cui il treno si fermava, potevamo scendere tranquillamente dai vagoni; nonostante questa pseudo-libertà, il tempo sembrava non trascorrere mai. Pensavamo comunque che, maggiore fosse stata la distanza percorsa, minore sarebbe stata quella che ci separava dal confine italiano.
Durante quelle brevi soste barattavamo il contenuto dei nostri zaini con prodotti alimentari della popolazione locale; i nostri oggetti scambiati per un po’ di cibarie erano cose personali, oppure oggetti militari. Con questo scambio raggiungevamo un duplice scopo: quello di cibarsi e alleggerirsi del peso dello zaino.
Il viaggio fino a Zagabria continuò per alcuni giorni, poiché il treno poteva muoversi solo quando la linea ferroviaria era libera, dato che la precedenza assoluta spettava ai convogli militari (tradotte) che trasportavano i rifornimenti per le truppe che si trovavano a combattere sui vari fronti.
4. La Repubblica di Salò
Adesso vorrei aprire una piccola parentesi che potrà spiegare i fatti politici accaduti in Italia mentre noi ci trovavamo in terra albanese. Dopo l’annuncio dell’armistizio dell’8 settembre 1943 comunicato da Badoglio, nel nostro Paese si costituì la Repubblica di Salò, cioè i fascisti italiani rimasti fedeli agli ideali di Hitler e Mussolini si schierarono a fianco dei nazisti e combattevano contro i propri fratelli italiani stessi ma che erano di idee opposte, contro la guerra e qualsiasi forma di dittatura.
Così i tedeschi ci odiavano a morte perché li avevamo traditi alleandoci con gli americani; anche i repubblichini ci odiavano solo perché di ideali contrari ai loro nonostante fossimo connazionali. In alcuni casi la ferocia di questi italiani si rivelò ben più crudele di quella dei tedeschi.
Contemporaneamente si erano formate le truppe partigiane, per combattere i nazifascisti.
In quel periodo l’esercito italiano, quasi completamente allo sbando, era diviso in due parti: una distaccata al Suditalia, già occupato dagli americani dopo lo sbarco in Sicilia; l’altra parte si trovava al Nord: man mano che i tedeschi arretravano verso la Germania, uccidevano civili, saccheggiavano case e paesi e deportavano in Germania, nei campi, quanta più gente potevano.
A fianco dei tedeschi operavano coloro i quali avevano aderito alla Repubblica di Salò, effettuando arresti, torture e fucilazioni di massa o singole. Si divertivano sadicamente contro le persone innocenti come donne incinte, bimbi, vecchi.
Con le teste mozzate ai bimbi, le SS ci giocavano a pallone; alle donne incinte era squartata la pancia per estrarne il feto ed usato come successivo bersaglio per il loro macabro tiro a segno. Ancora oggi ricorderemo i luoghi testimoni di quegli episodi, come S. Anna di Stazzema, Marzabotto, le Fosse Ardeatine, tanto per citarne alcuni tra i più famosi, dove in eterno saranno ricordate quelle stragi compiute senza pietà e senza alcun motivo, ma per pura ed innata cattiveria.
Mi sia ora consentito di aprire una piccola parentesi su alcuni termini, che ricorreranno spesso nel mio racconto, ma che possono non essere ben compresi.
Un primo esempio è quello delle SS, sigla di «SchutzStaffeln», cioè «squadre di protezione». Era la polizia del partito nazista e la guardia personale di Hitler (1925). Successivamente divenne un corpo militarizzato che controllava i settori amministrativi dello Stato, gli altri servizi di polizia ed alcune imprese economiche tedesche come la DAW, DEST, DWB, OSTI e altre.
Le SS erano in stretto rapporto con la gestione dei KZ (altra terribile sigla, come vedremo in seguito). Capo supremo delle SS era Heinrich Himmler (1900-1945). Tra le varie suddivisioni organizzative interne, vi erano poi le SS Totenkopf (teste di morto): a loro era affidata l'intera organizzazione dei KZ; altri generi erano invece i reparti combattenti Waffen SS (SS armate) e le Germanische SS, queste ultime composte da non tedeschi ed alle quali apparteneva anche un’unità di SS italiane.
Questi fatti e significati li apprendemmo solo al nostro ritorno in Italia, non avendo la possibilità in quel momento di ricevere notizie dalla nostra terra. Anche se le avessimo sapute, non immaginavamo certo che un destino, forse ben più crudele, ci attendeva di lì a poco.
5. L’inganno
Dopo molti giorni di viaggio, sempre secondo i nostri calcoli, ci svegliammo felici e contenti credendo di trovarci già in territorio italiano. Ma quando ci affacciammo fuori del vagone, la lettura di un cartello indicatore causò un tuffo al cuore a tutti: Vienna!. Eravamo alla stazione ferroviaria di Vienna! L’Italia era ormai lontana, alle nostre spalle.
Un turbinio di pensieri, immagini, ricordi, preoccupazioni si trovarono improvvisamente a circolarmi vorticosamente in testa. Beffarda ironia della sorte: anche la mia povera mamma si chiamava Italia. Non è facile descrivere la nostalgica malinconia bivalente che mi suscitava in quel momento la parola Italia. Credetti di vivere in un incubo da cui mi volevo svegliare, ma non ci riuscivo semplicemente perché quell’incubo derivava dalla realtà e non da un sogno. Adesso sotto le pensiline transitavano le SS, armate fino ai denti. Adesso non era più possibile scendere dai vagoni: quella vista, l’atmosfera pesante e minacciosa, fu come un trauma collettivo per tutti, pur non sapendo che il peggio doveva ancora arrivare. Le SS da quel momento divennero i nostri diavoli custodi: salirono con arroganza e prepotenza sui vagoni, depredando ciascuno di noi delle poche cose che avevamo, senza risparmiare nulla, nemmeno i ricordi personali. Macchine fotografiche, rasoi, candele, orologi; le fotografie ed i piccoli ritratti dei nostri famigliari furono trattati con beffardo disprezzo: i volti di madri, mogli, fidanzate, figli, divennero improvviso oggetto del peggiore e crudele schernimento immaginabile da parte dei tedeschi, che ci rubarono persino anelli di fidanzamento e fedi nuziali.
Da Vienna il treno si mosse dopo un giorno di sosta. Per altri giorni successivi continuò il suo lento e mesto viaggio verso una destinazione a noi ignota. Attraversammo boschi, e pianure sconfinate, brulicanti di vegetazioni d’ogni specie.
Fine della prima delle tre parti.
(Continua)








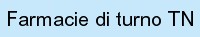














































Invia il tuo commento