Dora, quando la vita vince la morte/ 3 – Di Gherardo Del Nista
La terza parte del memoriale di un uomo che era sopravvissuto al campo di concentramento KZ di Dora Mittelbau - Nordhausen

>
9. Altri sventurati.
Nella baracca (Block) 18, durante quella triste ed interminabile permanenza, conobbi altri italiani: Eugenio Canzutti, un mio commilitone di Trieste, arrestato insieme a me in Albania e deceduto per fame e stenti. Povero Canzutti: a me stesso toccò di lanciare le sue povere ossa scarnite sul mucchio dei cadaveri ammassati sul carretto che li portava alla cremazione. La stessa tristissima fine fece Gino Tonini, di Pistoia, che si lasciò consumare dal pianto, nel dolore del ricordo di sua moglie e delle sue due figlie piccole che non rivide più. Conobbi anche Mario Lamberti, di Pietrasanta, in provincia di Lucca, che scampò per puro miracolo ad una fucilazione che ora racconterò.
10. I crimini
A causa del nostro durissimo lavoro, della malnutrizione e delle angherie cui dovevamo sottostare, ogni giorno che trascorreva eravamo sempre più deboli, per cui rendevamo sempre meno. Per questi motivi anche gli uomini appartenenti alla squadra dove era assegnato il Lamberti non rendevano come i tedeschi avrebbero voluto, per cui un aguzzino SS li minacciò fortemente, notando la scarsità di rendimento rispetto ai giorni precedenti. Essi risposero che rendevano poco perché privi di forze: se avessero ricevuto almeno un litro in più di “sboba” ed un poco più di pane, avrebbero sicuramente lavorato di più… A siffatta richiesta Quel carnefice inveì maggiormente contro di loro, minacciandoli di morte e dicendo che «chiunque non avesse lavorato per la grande Germania non avrebbe avuto il diritto di vivere».
Il giorno seguente, probabilmente verso la metà del dicembre 1944, raccolsero tutti gli italiani sul piazzale del campo, chiamarono il caposquadra e la squadra da lui incriminata, mentre noi altri eravamo completamente ignari di quanto stesse accadendo.
Fecero disporre i venti uomini di questa squadra in riga e ne scelsero, a decimazione, sette per essere fucilati, comunicando a tutti noi che quei sette erano uccisi perché avevano reclamato per il poco vitto ricevuto.
Le menti perverse degli SS e del comandante del campo, avevano intravisto in quella richiesta di carità un atto di ammutinamento e di sabotaggio che meritava la morte. Se i folli tedeschi avessero scelto otto condannati invece di sette, il mio caro amico Lamberti avrebbe lasciato le sue ossa e le sue ceneri nel campo di Dora: infatti egli era il numero otto.
Tutti insieme, incolonnati per cinque, ci portarono sul luogo dell’esecuzione per assistere collettivamente all’esecuzione di quei poveri innocenti, rei solo di aver mendicato qualche briciola di pane in più.
Quel giorno ho assistito, insieme ad altri connazionali, alla spietata esecuzione di sette italiani, che ancora indossavano la divisa militare perché giunti in quel campo solo da pochi giorni, rastrellati in Italia dalle truppe tedesche in ritirata.
L’esecuzione criminale fu compiuta da un plotone di SS comandati da un ufficiale; era presente anche un cappellano militare, che ascoltò – a chi l’avesse desiderata – la confessione religiosa dei condannati, chiedendo loro se avessero avuto qualcosa da dire.
Nessuno rispose.
L’assassinio fu reso ancora più perverso dal modo di procedere dei tedeschi: quei poveretti non furono fucilati tutti insieme, ma a gruppi di tre. A quelli del primo gruppo bendarono gli occhi e fecero fuoco contro di loro; nel secondo gruppo – ricordo perfettamente – ci fu un giovane militare che si trovava al centro e che rifiutò la benda: quando si accorse che il plotone stava per aprire il fuoco per la seconda volta, si aprì la giacca sul petto ed esclamò ad alta voce, udito chiaramente da tutti noi, «Mamma, non ti rivedrò più!», mentre il piombo tedesco lo raggiungeva facendolo stramazzare al suolo insieme agli altri due.
L’ultimo fu ucciso in barella, perché era ammalato di tifo ed aveva la febbre alta: fu assassinato freddamente con due colpi di pistola sparatigli alla fronte dall’ufficiale comandante il plotone. Non ho mai saputo come si chiamassero quegli sfortunati ragazzi, colpevoli solo di essere affamati ed italiani, se non a fine conflitto, dopo la liberazione.
Dopo aver compiuto quegli atti, l’ufficiale tedesco si rivolse a tutti noi, che avevamo assistito inorriditi, sbigottiti ed impotenti, dicendo testualmente: «Questo servirà come esempio per voi tutti italiani!»
In quello stesso inverno, rigido come la disciplina del campo, ho assistito nuovamente, insieme a tutti gli altri come nel caso precedente, all’impiccagione di altri due prigionieri, dei quali non ricordo la nazionalità né ho mai saputo cosa avessero commesso.
La nuova esecuzione fu eseguita al centro del piazzale del campo, dove erano montate le forche, non lontano dai cancelli d’ingresso. Anche in questa occasione il comandante del campo, tramite gli altoparlanti, urlò a circa quattordicimila persone di ogni nazionalità la frase di rito:
«Questo è ancora un esempio per tutti quanti facessero del sabotaggio, o non volessero lavorare per la grande Germania ».
La teoria nazista nei nostri confronti era chiara per tutti: la Germania ci dava da mangiare e noi dovevamo guadagnarci il cibo con il lavoro; chi non lavorava era considerato traditore o sabotatore, perciò ucciso senza alcun riguardo.
Con il passare del tempo, quando la Germania stava per soccombere, i tedeschi decisero di risparmiare le loro ultime risorse, per cui si accorsero che il piombo delle pallottole aveva un costo: allora per ucciderci, o per finire quelli mezzi morti che non avevano neppure la forza di alzarsi da terra, usavano il bastone, la pala per scavare, la frusta, la forca; oppure assassinavano in massa nelle camere a gas. Per le SS una vita umana, la nostra vita, valeva assai meno di una cartuccia.

11. I cadaveri
I prigionieri che per qualsiasi ragione non potevano lavorare, ad esempio perché allo stremo delle forze o perché ammalati, erano inviati prima alle camere a gas del campo di Buchenwald, perché a Mittelbau-Dora non esisteva questo strumento di morte, poi i loro corpi bruciati nei forni crematori.
Queste larve umane, ombra di loro stessi, una volta lasciato il campo non vi facevano più ritorno, poiché passati sotto forma di cenere attraverso i camini dei forni.
So che sembrerà impossibile credere a quanto narrato, ma i forni crematori, nonostante fossero accesi ventiquattrore su ventiquattro e lavorando a pieno ritmo, non riuscivano ad incenerire tutti i cadaveri che vi giungevano.
Spesso, per accelerare la distruzione dei cadaveri, nella bocca dei forni venivano infilati due corpi simultaneamente, tenendo conto che una persona di media statura, dopo gli stenti e la fame, non poteva pesare più di trenta-trentacinque chili; alcuni erano bruciati ancora vivi.
I cadaveri erano accatastati qua e là, come immondizia; prima della cremazione, erano completamente denudati e i loro vestiti consegnati ai nuovi arrivati. Invece, coloro che morivano sul loro misero giaciglio, erano raccolti da un’apposita squadra, che faceva ininterrottamente il giro del lager con dei carrelli in ferro, usati per trasportare i poveri corpi senza vita destinati ad ingrossare i mucchi di cadaveri.
Nel nostro campo esistevano due forni crematori, posti in una costruzione in muratura su una collinetta. In una delle stanze adiacenti quella dove si trovavano i forni veri e propri, in una parete erano infissi dei ganci: su questi erano appesi, come bestie prima del macello, i corpi dei prigionieri non ancora deceduti, che spesso venivano bruciati ancora vivi.
Gli addetti ai forni, cioè coloro destinati ad alimentare le fiamme con carne umana, erano altri prigionieri come noi. I morti quotidiani che i due forni non riuscivano a bruciare, erano caricati su dei camion da una benna meccanica e portati in un bosco non lontano dal campo; qui erano gettati in una grande fosse, cosparsi con benzina e incendiati, ciò che restava era poi ricoperto con la calce viva: questo il rito di sepoltura per chi non riusciva a sopravvivere.
Rare volte, quando potevamo usufruire di alcune ore «libere», ma rimanendo sempre all’interno del campo, ci radunavamo in gruppetti, ognuno dei quali raccoglieva elementi della stessa nazionalità; mentre parlottavamo tra noi su come riuscire a racimolare qualsiasi elemento necessario a nutrirci, pensando a quando sarebbe finita quella maledetta tortura quotidiana ed al giorno in cui saremmo tornati a casa, ci cadevano addosso le ceneri di quei miseri corpi che già erano passati per il camino e che il vento spandeva da ogni parte.
Vedendo questo, ci guardavamo tutti in faccia, sgomenti nello scoprire che i nostri volti avevano assunto sembianze cadaveriche, pensando che tra breve avremmo seguito la stessa sorte dei nostri più sfortunati compagni di lager.
Il nostro morale, come il nostro fisico, era ormai a terra. Ogni giorno che passava era sempre così: cercando ogni mezzo che potesse darci un po’ più di forza per fronteggiare quel destino avverso e crudele, per uscire vincitori su quelle torture e sperando di tornare presto in Italia, alle nostre case.
Ma subito lo sconforto ci riassaliva, quando pensavamo, vedendo cadere le ceneri dei cadaveri cremati, che tante migliaia, milioni, di poveretti come noi non avrebbero più rivisto i loro cari.

12. I pensieri
Qualche volta mi è successo di svegliarmi la mattina, oppure durante la notte, ed accorgermi che i miei vicini di “letto” erano morti durante il sonno. Non mi vergogno a dirlo, ma il primo pensiero che mi assaliva, era quello di andare a vedere nelle loro “ciotole” se, prima di morire, avessero lasciato qualche cosa da mangiare, se fossero rimasti anche solo pochi frammenti della misera razione quotidiana e facendo sempre molta attenzione per non farmi notare da qualcuno.
Nel conoscere simili comportamenti leggendo quanto raccontato, non si pensi che quei gesti istintivi fossero dettati da un cinismo inumano: era solo una disperata lotta contro la morte per sfinimento.
Anche poche briciole di pane ammuffito significavano un giorno in più di vita, una speranza in più di riassaporare la libertà. Bisogna aver vissuto quei momenti per far scattare l’istinto inimmaginabile della sopravvivenza.
Più volte, nelle notti di plenilunio, guardavo la luna nel cielo, sperando che se in quello stesso istante i miei genitori avessero rivolto gli occhi verso di essa, i nostri sguardi si sarebbero incontrati ed incrociati nello stesso punto focale, l’uno all’insaputa degli altri: brevi istanti di pura fantasia, che generavano gioia e commozione.
Una sera in cui ero col morale più a terra del solito, mi coricai febbricitante su quel lurido giaciglio, pieno di terra, sporcizia e pidocchi, credendo di essere davvero giunto alla fine. Piansi, ricordando il viso di mamma e papà. Desiderai ardentemente, prima di morire, rivederli per una sola volta, solo per un attimo e poi arrendermi alla morte.
Ma il destino mi aveva riservato un’altra strada, perché accadde una specie di miracolo. Un mio vicino, vedendomi in quello stato e con la febbre alta, mi cedette parte della sua razione ancora calda: ancora oggi ho la netta sensazione che in quella specie di minestra doveva trovarsi un ingrediente magico. Appena mangiata mi addormentai subito, per svegliarmi il mattino successivo senza più febbre, ma con nuova e rinata voglia di vivere.
Il mio calvario durò per circa due anni, per altri meno, per altri ancora di più. Il mio pensiero serale, prima di dormire, era sempre lo stesso: «Anche oggi è passato. E domani? Chissà se vedrò ancora il giorno e la sera di domani».
Tra pianti e qualche sorriso forzato, trovai il coraggio di non farmi mai assalire completamente dalla disperazione, altrimenti sarei finito sul serio; anche quando ricevevo, frequentemente, ceffoni e staffilate, cercavo di darmi forza e coraggio pensando che oltre il cancello ed i reticolati la vita libera scorreva ancora.
Non mi sembrava possibile che la mia pacifica esistenza fosse improvvisamente divenuta oggetto di così tanta sofferenza, causata esclusivamente dalla inspiegabile barbarie altrui: quante volte ho invocato la morte come liberatrice da quei mali, e sempre chiedendomi “Perché?”.
È incredibile scoprire di essere condannati a vivere; scoprire nella sopravvivenza quotidiana per la quale io, e tutti noi lottavamo, una tortura in più, una costante tortura psichica aggiunta a quella fisica.
Come si delinea quel filo sottile che separa la voglia di continuare a vivere dall’abbandonarsi con rassegnazione ai voleri altrui? Cosa ci fa vivere anche quando ci sentiamo già morti? Forse una briciola di pane secco ed ammuffito, od un avanzo di cibo rifiutato dai cani...
O forse la speranza di essere ancora, il credere nell’impossibile, il desiderio di vivere domani, poi domani e domani ancora.
Un altro giorno, uno di quelli in cui il mio morale e le forze erano davvero bassi e in più non stavo molto bene: mi mancavano le forze sempre di più e lavoravo con ritmo assai lento. Mi fermai un attimo per riprendere fiato: in quell’atteggiamento inoperoso fui subito notato da un SS che stava passando di lì per caso.
Questi cominciò ad inveire contro di me senza che io capissi una parola di ciò che andava sbraitando, anzi, cercai di spiegare le mie ragioni in uno stentato francese, ma egli non volle sentire ragione alcuna e riuscì solo a strillare «Sciaisi italiano Badoglio macaroni» [Sciaisi = Scheise: merda, sic], continuando a ripetere quelle parole incomprensibili mentre scriveva su un taccuino.
Mi rilevò il numero di matricola, che ognuno di noi portava esposto ben visibile sulla casacca e non se ne andò finché non ebbi terminato il mio lavoro. Quando si allontanò, senza aver infierito fisicamente su di me, dalla contentezza mi sembrò che mi fossero tornate tutte le energie di un tempo: mi sentivo un gigante.
Ma la mia illusione fu solo temporanea, perché la cosa non finì lì.
Premetto che la domenica pomeriggio era l’unico momento della settimana in cui non lavoravamo perché nelle gallerie veniva tolta l’energia elettrica, ma era anche il giorno in cui, come consuetudine, venivano inflitte pubblicamente le punizioni a chi aveva commesso qualcosa di irregolare.
Gli accusati dovevano presentarsi sul piazzale, davanti a tutti i presenti erano fatti inginocchiare in terra, con la pancia appoggiata su uno sgabello, il cavalletto, e la schiena rivolta verso l’alto. La punizione consisteva in venticinque frustate se la mancanza compiuta era considerata lieve, qualora questa fosse stata più grave, il numero dei colpi inferti era aumentato finché il malcapitato non moriva sotto le bastonate.
La domenica successiva al fatto prima narrato, ci radunarono tutti sul piazzale per l’appello; poi, tramite altoparlante, cominciarono a chiamare alcuni numeri che corrispondevano alle nostre matricole, specificando anche la nazionalità cui i chiamati appartenevano.
Quel giorno anche il mio numero di matricola figurava nell’elenco. La mancanza contestatami alcuni giorni prima dal nazista SS fu giudicata di lieve entità: per questa “piccola leggerezza” ricevetti venticinque nerbate sulla schiena, inferte con una violenza tale che sin dai primi colpi credetti me l’avessero spezzata.
Quando ebbero finito ero tutto un livido, tanto che portai i dolori per diversi giorni successivi; quei dolori erano così forti che a malapena riuscivo a camminare: appena potevo mi soffermavo un poco per alleviare anche per un solo attimo le sofferenze, ma stando bene attento a non farmi sorprendere nuovamente dai guardiani in tale atteggiamento.
Se mi avessero scoperto ancora e inflitto un’altra punizione del genere, sarei sicuramente morto. Di quella punizione, oggi, a distanza di cinquantasei anni, porto ancora i segni tangibili.
Come potevamo nel campo facevamo piccole azioni di sabotaggio, oppure cercavamo un modo di contattare il mondo esterno: la Croce Rossa, gli americani o chiunque altro potesse aiutarci. C’erano persone di ogni grado d’istruzione, compreso ingegneri, medici, insegnanti.
Alcuni che in vita civile erano tecnici specializzati, riuscirono a costruire una rudimentale radio trasmittente con materiale sottratto alle officine all’interno dei tunnel, cercando di comunicare con gli americani.
Purtroppo l’intento non fu portato a termine, perché le SS scoprirono la piccola radio, facendo carneficina di prigionieri. Quando avvennero questi fatti, io mi trovavo a lavorare in un mulino, nei pressi di Magdeburgo.

13. Liberi
Trascorsero quasi due anni. La speranza di rivedere le nostre case si era del tutto affievolita, anche perché non ricevevamo notizia alcuna dal mondo esterno, in quanto i tedeschi non lasciavano trapelare nulla. Tuttavia eravamo riusciti a sapere che già dall’inizio del 1945 per i tedeschi le sorti della guerra cominciavano a precipitare.
Improvvisamente accadde l’incredibile, l’insperato miracolo.
Durante la primavera del 1945, insieme ad altri prigionieri mi trovavo nelle vicinanze di Magdeburgo, dove dovevamo svolgere dei lavori nelle campagne, e dormivamo in un vecchio mulino ad acqua. Come “guardiani” avevamo due SS, uno dei quali, tenendo la pistola in mano, ci urlava sempre come un dannato, in un italiano stentato ma per noi fin troppo chiaro: «Io avere moglie e due figlie. Se Hitler perde guerra, io prima uccidere moglie, figlie e poi uccidere me!», agitando la pistola e mimando con i gesti ciò che diceva con le parole. Però, ad onor del vero, quel carceriere non ci ha mai toccato con un dito, né fatto alcun male fisico. Chissà, se dopo la liberazione americana, avrà mantenuta la sua promessa.
Il mattino del 13 aprile 1945 non sentimmo gridare “Aufstehn!”, l’odiata sveglia quotidiana strillata dai tedeschi che venivano a prelevarci per portarci al lavoro. Non si sentiva neppure nessun rumore fuori, nemmeno l’abbaiare del cane-lupo che le SS avevano sempre con loro.
Aleggiava una strana calma ed un insolito silenzio: qualsiasi cosa ci spaventava dopo quella permanenza, ma ancor più facevano paura gli avvenimenti insoliti. In particolare quel silenzio mi ricordava il giorno in cui i tedeschi ci arrestarono in Albania.
Ma stavolta quella calma, un tempo presaga di sventure, adesso era portatrice di un sogno: non ci rendemmo subito conto di cosa era successo, ma finalmente eravamo liberi.
I tedeschi, appresa la notizia che gli americani erano ormai alle porte della città, nottetempo ci avevano silenziosamente abbandonati, fortunatamente senza ucciderci.
Eravamo liberi!
Ci dirigemmo incontro alle truppe americane, distanti da noi circa quattro chilometri.
In un attimo, vedendo tutta la zona senza più tedeschi, la gioia esplose fulminea e collettiva.
Non sapevamo più che fare: chi correva a destra e sinistra, chi piangeva e rideva, chi saltava nonostante le ultime forze rimaste... Sembravamo un branco di scheletri ammattiti, cadaveriche larve umane inspiegabilmente gioiose per chi ci avesse visto dall’esterno e fosse stato inconsapevole della nostra sorte trascorsa.
La tanto agognata ora della liberazione era scoccata, per noi sopravvissuti.
Dopo quattro giorni di caos, giunsero gli americani a occupare completamente la zona: non credettero ai loro occhi quando si trovarono di fronte a quello spettacolo. Fu uno sbigottimento generale anche per loro la vista di noi, barcollanti e scheletriti.
Ma gli oggetti erano ancora lì, macabri testimoni delle malefatte naziste: i forni crematori ancora fumanti, i mucchi dei cadaveri accatastati e tutto quanto documentato dalle numerose foto scattate dagli alleati al loro ingresso.
Tra l’altro avevamo saputo di cosa stese per succedere al campo di Dora. Quando iniziarono i primi bombardamenti su Nordhausen ed i tedeschi seppero dell’avanzata degli americani, in un primo momento decisero di rinchiudere tutti i prigionieri dentro i tunnel, minarli e poi farli esplodere con tutte le testimonianze ancora viventi del loro vergognoso e criminale comportamento.
Ma la popolazione civile di Nordhausen, che non aveva rifugi anti-bomba dove ripararsi, si precipitò tutta insieme all’interno delle gallerie proprio per proteggersi dai bombardamenti. A quel punto, non potendo uccidere insieme ai prigionieri anche i loro connazionali, i tedeschi preferirono abbandonare tutto e in fretta.
Da allora il sospiro di sollievo che tirammo, aveva davvero il sapore dell’aria odorosa di libertà: la schiavitù tedesca era un ricordo al passato prossimo, ma sembrava distante da noi anni luce.
Dal 15 aprile, fino al 9 settembre 1945, i soldati americani ci accolsero e considerarono come loro commilitoni, trattandoci come loro stessi in tutto e per tutto.
Dopo averci rifocillati, vestiti e sottoposti a cure mediche, stilarono un elenco dei nostri nominativi; poi ci trasferirono a Osnabruck, a circa duecento chilometri da Dusseldorf, e ci sistemarono in una villetta dopo aver cacciato i suoi abitanti.
Lì trascorremmo circa quattro mesi in piena libertà, finché il 9 settembre 1945, ci imbarcarono su alcune tradotte dirette in Italia.
Il 17 settembre 1945, con indescrivibile gioia, riabbracciai i miei cari: i sogni e i desideri espressi nel lager tra nostalgici pianti, si erano incredibilmente realizzati.
Fine
Gherardo Del Nista
ex internato al campo di Dora Mittelbau (Nordhausen)
matr. 0342- IMI, Baracca 18,
dal novembre 1943 all’aprile 1945.
Deceduto nel 2010.
(Precedente)








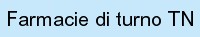














































Invia il tuo commento