Giorno della memoria, 27 gennaio 2019
Riportiamo l’intervento del sindaco di Trento Alessandro Andreatta pronunciato questo pomeriggio nella sala delle cerimonie del Municipio
Il Giorno della memoria è diventato in questi anni uno degli eventi che scandisce il nostro calendario civile.
Parliamo di «memoria», e dunque di passato, per una ragione ben precisa: perché siamo convinti che i fatti da ricordare, da tramandare, non possano che appartenere alla storia.
Riteniamo che quell'orrore indicibile non possa tornare mai più.
È stato un errore, un inciampo troppo grande nel cammino dell'umanità: come sarebbe mai possibile ripeterlo?
Questa è una domanda che, fino a ieri, avremmo definito retorica. Oggi però sono molte le persone preoccupate: preoccupate dalle parole d'odio che sui social diventano virali, allarmate quando personaggi pubblici, anche autorevoli, attribuiscono valori diversi alle persone, cento ai «nostri», zero a chi arriva da fuori, da lontano, numeri di una contabilità che non vale neppure la pena di essere tenuta in ordine.
Non a caso la senatrice a vita Liliana Segre, matricola 7 5 1 9 0 del campo di concentramento di Auschwitz, ha ammonito recentemente: «Le parole d’odio sono l’anticamera della fine della democrazia. L’imbarbarimento del linguaggio è arrivato a livelli intollerabili».
E ancora: «Ho paura di perdere la democrazia, perché io so cos’è la non democrazia. La democrazia si perde pian piano, nell’indifferenza generale, perché fa comodo non schierarsi, e c’è chi grida più forte e tutti dicono: ci pensa lui».
Ecco quest'anno, forse per la prima volta, ho la sgradevole sensazione che il Giorno della memoria faccia incursione nella nostra quotidianità con un monito non solo importante e necessario, ma anche più che mai attuale.
Ho l'impressione che non stiamo commemorando un capitolo chiuso della nostra storia: stiamo piuttosto ricordando i sintomi iniziali, il decorso spaventoso, l'esito finale di una malattia che sì, è stata sconfitta, ma potrebbe ancora tornare.
Come forse saprete, alcuni giovani di Trento racconteranno, nel corso di questa cerimonia, della loro visita a Dachau, primo campo di concentramento nazista a poche centinaia di chilometri da qui, a due passi da Monaco di Baviera.
Ebbene, andando a rileggermi la storia di quel luogo, un fatto mi ha colpito: il suo aspetto rispettabile, l'attenzione all'estetica e alla simmetria.
Per dire: i deportati che arrivavano al campo percorrevano la Lagerstrasse, un lungo viale molto curato. Entravano da un cancello su cui si stagliava la scritta motivazionale «Il lavoro rende liberi».
Ne uscivano a migliaia dal camino del crematorio: e il primo forno costruito all'interno del campo era camuffato all'interno di una villetta in stile bavarese.
Quel che salta agli occhi è la completa dissociazione tra la parola e la realtà, tra l'apparenza e la sostanza.
Il bel viale alberato è una strada della morte, il lavoro che rende liberi è niente altro che tortura, sfruttamento disumano, sadismo.
E la villetta bavarese, che evoca la normale vita di una famiglia benestante tedesca, è una spaventosa macchina di sterminio.
Del resto, come ci ha spiegato Victor Klemperer, filologo tedesco, ebreo convertito, scampato alla morte fortunosamente, uno dei pilastri attorno a cui fu costruito il regime nazista fu proprio quello del linguaggio: un linguaggio deformato, corrotto, manipolato, che non serviva più ad esprimere ragioni o sentimenti, non era utile al dialogo, alla preghiera, al dubbio.
Le parole dovevano manifestare solo la fede religiosa nel capo e l'esecrazione nei confronti dei nemici.
Dunque ogni singolo vocabolo della lingua di Goethe e Freud veniva deviato dal suo significato originario, costretto ad assumere un valore diverso, a mascherare la violenza sotto le sembianze dell'ordine e della rispettabilità oppure a coprire d'infamia intere categorie di incolpevoli cittadini.
Come non pensare alle parole che anche oggi, in questo inizio di secolo, improvvisamente diventano sospette? Solidarietà, per esempio. O fratellanza.
Come non riflettere sulla mancata corrispondenza tra significante e significato quando abbiamo a che fare con una retorica discriminatoria che definisce «nemici» persone inermi e senza patria?
Se il razzismo e la xenofobia diventano accettabili, se il termine buonista è considerato un insulto e se si ritiene che i diritti umani non debbano più essere garantiti per tutti, allora significa che è in atto uno scivolamento pericoloso. Sul piano del linguaggio e non solo.
Del resto l'esasperata violenza verbale ha già prodotto i suoi martiri: l'ultimo, nella Polonia che ha vissuto l'orrore del ghetto di Varsavia e del lager di Auschwitz, è stato il sindaco di Danzica, Pawel Adamowicz, europeista convinto, uomo del dialogo, della cooperazione e della pace sociale. Prima di lui, a giugno 2016, abbiamo pianto la deputata inglese Jo Cox: anche lei, come Adamowicz, era il simbolo di una politica diversa, aperta e tollerante, vicina alle persone più fragili.
Come ha commentato qualche giorno fa Lech Walesa, premio Nobel per la pace, i media, i politici, le persone che diffondono parole violente devono capire che soffiare sul fuoco dei conflitti non è senza conseguenze: perché prima o poi l'aggressività troverà la mano di un pazzo, di un invasato, di un mitomane. E allora la tragedia sarà inevitabile.
Il campo di concentramento di Dachau all'inizio era stato pensato per rieducare gli oppositori politici, i comunisti, i sindacalisti, i socialdemocratici, i cattolici.
Poi, progressivamente, si popolò di mendicanti, senzatetto (definiti dalla propaganda «fannulloni»), di preti dissenzienti (qualche migliaio), di zingari, di omosessuali, disabili e naturalmente di ebrei.
E dalla rieducazione si passò in breve alla catena di montaggio dello sterminio, all'efferatezza programmata e quotidiana.
Dachau con i suoi forni, con gli esperimenti medici su cavie umane, con la violenza elevata a legge, è riuscito a distruggere, in pochi anni, secoli e secoli di civiltà.
È il volto oscuro della nostra storia, il limite da cui tenersi ben lontani.
A questo dunque deve servire il Giorno della memoria: a riconoscere in anticipo la disumanità, ad aiutarci a individuare segnali e campanelli d'allarme. Scriveva nel suo diario Anna Frank, nascosta nel suo rifugio segreto: «Vedo il mondo che si trasforma gradualmente in una terra inospitale; sento avvicinarsi il tuono che distruggerà anche noi; posso percepire le sofferenze di milioni di persone...»
Memoria significa oggi non assuefarsi all'aria di tempesta né pensare che tanto prima o poi passerà. Memoria è il passato che si fa presente e non finisce mai di passare.
Non per appesantire il nostro fardello, ma per renderci vigili, guardinghi, reattivi di fronte alla minima violazione dei diritti fondamentali.
Auguro a tutti noi di riuscire a portare la memoria della Shoah al di fuori dei riti e delle commemorazioni ufficiali per farla vivere e consentirle di orientare i nostri passi verso una società più umana, definitivamente affrancata dalla paura, dalla violenza e dall'odio per il diverso.
Nella consapevolezza che dividere il mondo in amici e nemici significa inibire la capacità di includere, che è poi il fine ultimo della democrazia.
Buon Giorno della memoria a tutti voi.








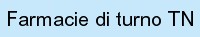













































Invia il tuo commento