Dora, quando la vita vince la morte/ 2 – Di Gherardo Del Nista
La seconda parte del memoriale di un uomo che era sopravvissuto al campo di concentramento KZ di Dora Mittelbau - Nordhausen

>
6. I lager
Dopo sedici giorni e diciassette notti di viaggio, il convoglio si fermò in aperta campagna, in mezzo ad un bosco fittissimo. Tutti ci guardammo in faccia, sbigottiti: le nostre sembianze erano già cadaveriche, a causa della mancanza di cibo. Dopo alcuni minuti di sosta, udimmo un grande baccagliare di voci, ma non ne capimmo il significato perché in lingua tedesca.
Ci fecero scendere con i nostri miseri bagagli, ormai alleggeriti di tutto dopo l’episodio occorso a Vienna e, incolonnati per cinque, ci fecero marciare lungo una strada. Dopo una curva vedemmo pronunciarsi la nostra sentenza: cancelli dietro cancelli, recinti di filo spinato e molte, molte baracche di legno, alcuna delle quali, ancora vuota, attendeva il nostro arrivo.
Era l’imbrunire. In lontananza si sentivano sparare raffiche di mitra. Non sapendo cosa fossero quegli spari, domandammo ad alcuni nostri compagni che già si trovavano lì da qualche giorno, anch’essi prigionieri. Ci risposero che quelle raffiche stavano uccidendo altri nostri compagni di sventura e di ogni nazionalità.
I soldati tedeschi ci fecero sistemare in una di quelle maledette baracche e ci mandarono a dormire: il nostro materasso era costituito da un duro lettino di legno a castello; ognuno di quei castelli era composto da quattro letti sovrapposti.
Avevamo perduto quasi completamente l’esatta cognizione del tempo, ma secondo i nostri calcoli basati su quello trascorso, doveva essere il 28 ottobre del 1943.
Il giorno successivo venimmo a sapere che quel luogo era il campo di concentramento e smistamento prigionieri 11/B di Fallingbostel, tra Brema e Berlino.
Nei giorni che seguirono, ogni mattina, venivano delle SS e ci prelevavano in un certo numero per condurci a sbrigare vari lavori fuori del campo; stavamo fuori a lavorare fino a sera.
Durante la giornata di lavoro ci tenevano senza cibo e ci facevano sorvegliare, oltre che dalle guardie armate, da feroci cani-lupo ben addestrati per impedirci la fuga. Fuga che, peraltro, sarebbe stata impossibile: anche al solo tentativo ci avrebbero immediatamente fucilati o fatti sbranare dai cani.
Dopo circa un mese di permanenza in questo campo, ci radunarono tutti disponendoci in fila per cinque.
Uno ad uno fummo interpellati dalle SS: ci chiesero se volevamo arruolarci come volontari a prestare servizio per il Reich o per la Repubblica di Salò; in caso affermativo ci avrebbero fatto frequentare un corso di addestramento per apprendere l’uso delle loro armi.
A questa richiesta, alcuni di noi accettarono: non si sa perché se di idee filogermaniche o perché ingannati dalla promessa che fecero loro le SS, cioè quella di rimpatriarli in Italia dove avrebbero svolto il loro nuovo servizio.
Il giorno seguente queste persone furono trasferite: non so dove, né le ho più rivedute o avuto loro notizie. Io e quelli come me che rifiutammo il collaborazionismo (settantacinque uomini), fummo obbligati per alcuni giorni a svolgere vari lavori; dopo quei giorni «noi settantacinque», compreso un certo Gino Natalini, di Pistoia, fummo trasferiti di nuovo per ignota destinazione.
Il trasferimento avvenne di buon mattino: svegliati di soprassalto, fummo radunati nel cortile dove ci attendevano tre camion, sui quali ci fecero salire naturalmente sempre ben vigilati da guardie armate.
Durante il viaggio effettuammo qualche breve sosta in aperta campagna, per soddisfare le nostre necessità fisiologiche di qualsiasi natura: tutto sempre sotto lo sguardo vigile ed inflessibile dei tedeschi che ci vietarono tassativamente di allontanarci più di tanto, altrimenti ci avrebbero immediatamente sparato.
Le prime umiliazioni, anche di questa natura, erano già iniziate.
7. Dora
Nel tardo pomeriggio di inizio dicembre giungemmo al campo «KZ» di concentramento e sterminio politico di Dora-Mittelbau, nei pressi della cittadina tedesca di Nordhausen, in Turingia. KZ significa «Konzentrazionlager», cioè campo di concentramento.
Ancora oggi è indimenticabile la sequenza di orribili, incredibili, immagini che apparvero ai nostri occhi: uomini scheletriti, con le sembianze già di cadaveri, gli occhi infossati nelle orbite e la pelle gialla come lo zafferano…
Il giorno successivo, ci portarono in una baracca adibita a barbiere e bagno; non sapevamo le loro intenzioni. Fuori della baracca ci fecero spogliare completamente e ci tolsero la divisa militare italiana. Era di buon mattino, nevicava fitto e il freddo ci mordeva la carne.
Ci tennero in quelle condizioni per più di mezz’ora, finché ci fecero entrare nella baracca, dove c’era un modesto tepore.
Appena entrati vedemmo i barbieri (anch’essi prigionieri come noi) con in mano gli utensili per rasarci. Tutti questi fatti avvenivano sempre sotto la stretta vigilanza delle SS. Giunse il mio turno: per iniziare rasatura con una lama che, senza dubbio, un semplice coltello da cucina sarebbe paragonabile al più affilato dei rasoi; se mi avessero strappato pelo per pelo con le pinzette, sicuramente avrei sofferto meno.
Dopo averci depilato in ogni parte del corpo, ci tagliarono i capelli a forma di croce, cioè da orecchio ad orecchio e dalla nuca alla fronte; dopo, in segno di spregio, ci chiamavano gli «italiani di Badoglio». Portammo quella acconciatura per tre mesi.
Finita la rasatura entrammo in sala bagno, dove era sistemata una vasca di cemento grezzo piena di acqua putrida e giallastra definita disinfettante, dentro alla quale erano stati immersi migliaia di prigionieri prima di noi, senza che l’acqua fosse mai stata cambiata.
Uno ad uno dovevamo entrare in questa vasca e, con scatto fulmineo, immergerci completamente nel liquido, sotto anche con la testa.
Per chi non riusciva a compiere l’operazione, era pronto il solito aguzzino SS, che con lo scudiscio vibrava una tremenda staffilata al malcapitato, costretto a quel punto ad immergersi per forza. Dopo la disinfezione ci mandarono nelle docce a cinquanta per volta sotto soli dieci spruzzatori; naturalmente senza sapone né asciugamani.
I getti dell’acqua venivano regolati dai nostri guardiani che, per divertirsi, ne variavano la temperatura a loro piacimento: quando normale, poi bollente e infine gelida, facendoci patire le pene dell’inferno.
Non resistendo a quella tortura, cercavamo di uscire da sotto i getti, ma i nazisti, a forza di scudisciate, ci rimandavano sotto le docce.
Questo fu il primo segno di benvenuto ricevuto dai tedeschi.
Usciti dalle docce, in un’altra baracca ci furono consegnate le nostre nuove divise a zebra, che già indossavano gli altri prigionieri; il nostro nuovo vestito, a strisce verticali blu e grigie, era costituito da una giacca, pantaloni e berretto.
Insieme alla divisa un numero impresso su un triangolo di stoffa di colore rosso cucito all’altezza del cuore: a me assegnarono la matricola 0342 – I.
Per i tedeschi nomi e cognomi non esistevano più: da quel momento la vita di un qualsiasi essere umano come me, valeva meno di un numero.
8. Vita nel lager
Dopo alcuni giorni di presenza nel campo di Dora, radunarono solo noi italiani sul piazzale; eravamo circa ottocento connazionali, tra deportati civili e militari. Il comandante del campo pronunciò, in un perfetto italiano, il saluto di benvenuto: «Avete raggiunto il numero di ottocento italiani: non basta per pagare lo sbaglio che ha commesso Badoglio.
«Lo pagherete voi, con la disciplina ferrea, con un lavoro estenuante e, se fosse necessario, anche con la vita!
«Non avrete mai corrispondenza con i vostri congiunti, ma se ci fosse qualcuno tra voi che vuole andare volontario nelle SS, è ancora in tempo per varcare la soglia di quel cancello», indicando quest’ultimo con il dito.
Nei giorni successivi, dopo che i tedeschi ebbero compiuti i loro accertamenti su ciascuno di noi e ci ebbero registrati, ci assegnarono a vari e durissimi lavori. Io fui destinato ad una squadra di lavoro composta da venti unità: dovevamo svolgere lavori per conto della ditta «Ammoniak»; io ebbi mansioni di minatore. Non avevo mai fatto quel mestiere, ma per forza dovetti obbedire.
Come caposquadra avevo un tedesco di cui ricordo ancora il nome, ma del quale non ho mai saputo il cognome: Hans, un «triangolo verde» e delinquente nato, condannato ai lavori forzati dal Tribunale Civile tedesco per aver commesso reati comuni.
Hans era feroce come una belva: ci bastonava a più non posso se andavamo lenti nel lavorare; malmenava, fustigava e ci faceva dare la razione del vitto ridotta solo per compiacersi e soddisfare i suoi capricci personali, mutevoli come il suo umore di demonio.
Nelle punizioni ufficiali e pubbliche, i colpi di frusta o scudiscio, quando ci toccavano, erano minimo venticinque.

Il mio lavoro di minatore consisteva in questo: poiché le volte dei tunnel dovevano essere ampliati sia in altezza sia in lunghezza, noi dovevamo perforare le pareti e la volta delle caverne col martello pneumatico per una profondità di circa tre-quattro metri; successivamente i tedeschi riempivano i fori da noi praticati con esplosivo: ci facevano allontanare e poi provocavano le esplosioni che ampliavano di qualche decina di metri i tunnel.
Le macerie ed i detriti prodotti dovevano poi essere portate fuori dalle caverne con degli appositi vagoncini su rotaie a scartamento ridotto trainati da una piccola locomotiva: due di questi mezzi, tutti rugginosi, sono oggi sistemati sul piazzale d’appello, vicino all’ingresso del campo.
Il pietrame fuoriuscito era venduto dalle SS a ditte private e serviva per altri lavori esterni; così le SS lucravano con il lavoro forzato dei prigionieri: altro che ideale patriottico per la loro grande Germania!
Poiché, ripeto, non sapevo fare quel lavoro, come istruttore avevo un operaio di origine italiana emigrato in Germania prima dell’inizio della guerra. Egli stava con noi per tutto il turno del nostro lavoro, al termine era libero di andare a dormire fuori del campo.
Naturalmente scambiavamo insieme qualche parola, ma sempre con la dovuta cautela per non farci sorprendere dalle SS: poiché egli era libero di uscire e di recarsi anche in città, gli chiesi se avesse notizie dei suoi famigliari in Italia.
Mi rispose di sì, che poteva avere una corrispondenza molto limitata, perché i tedeschi leggevano tutta la sua posta e censuravano tutte le informazioni relative al campo ed a cosa succedeva là dentro.
Le SS controllavano strettamente anche la popolazione civile, in mezzo alla quale infiltravano anche delle spie.
Mentre parlavamo di queste cose, ci trovavamo su un ponteggio in legno, ad una certa altezza dal suolo: approfittai di quella posizione per chiedergli se, comunicandogli l’indirizzo di casa mia, in Italia, avesse scritto per me una semplice cartolina con la frase «Sto bene. Saluti. Gherardo» e niente altro. In cambio di questo favore gli avrei regalato un anello d’oro che portavo al dito e che, miracolosamente, ero fino allora riuscito a sottrarre all’avidità tedesca.
Nonostante la mia offerta, quell’operaio, dispiaciutissimo, rifiutò di scrivere, perché se lo avessero scoperto si sarebbe immediatamente ritrovato anch’egli prigioniero insieme a me e sottoposto agli stessi crudeli trattamenti.
Barattai poi l’anello per un pezzo di pane.
Così, con il martello pneumatico fui messo a forare i duri macigni della montagna, per scavare le gallerie sotto le quali erano state ricavate le officine meccaniche per la fabbricazione delle micidiali bombe V1 e V2.
Mentre il nostro lavoro si svolgeva nelle viscere delle colline di Kohnstein, una montagnola non distante dal campo, altri sventurati prigionieri operavano fuori, all’esterno della galleria, impegnati a preparare i nostri nuovi alloggi: le baracche-dormitorio in legno; in esse ci fecero trasferire non appena furono ultimate.
Prima del loro completamento, i tedeschi ci costringevano a dormire e persino a soddisfare i nostri bisogni fisiologici sempre e solo dentro quelle dannate gallerie, dove l’aria era irrespirabile, l’umidità e il freddo elevati e dove era assai facile ammalarsi di polmonite e tubercolosi, come accadde a molti di noi.
Sotto le gallerie dormivamo in terra o letti di legno a castello, formati da cinque piani verticali; ogni piano orizzontale era predisposto per farci dormire in quindici persone, ma spesso ci ammassavano in venti, uno appiccicato all’altro.
Le gallerie si estendevano per molti chilometri sotto la montagna, per cui non dormivamo mai nel solito posto. In breve tempo ci riempimmo di tutte le specie di parassiti, pulci, pidocchi, che possono trovare sede sul corpo di una persona.
Per ripararci meglio dal freddo, poiché indossavamo solo la divisa da prigionieri, utilizzavamo i sacchi vuoti del cemento, che ci sistemavamo sulla carne, sotto la casacca, ma badando sempre di non farci scoprire dai tedeschi, che avrebbero giudicato questa azione come sabotaggio e spreco del materiale germanico e ci avrebbero puniti di conseguenza o anche uccisi.

Quando, infine, le baracche-dormitorio in legno furono approntate, ci portavano a dormire in questi «alloggi»… In ogni baracca (Block) eravamo in circa trecento persone, ammassate nei giacigli a castello nello stesso modo di come dormivamo nei tunnel: quindici corpi scheletriti uno accanto l’altro. Il mio nuovo alloggio fisso era contrassegnato come «Block 18».
Dai primi di dicembre del 1943, i giorni in cui fui portato in quel campo, racconterò ora il mio diario, cioè quello che ho subìto personalmente e veduto con i miei occhi di testimone oculare.
«Vita» giornaliera: lavoro forzato per dodici ed anche più ore consecutive, da mezzanotte a mezzogiorno o viceversa; un solo, insufficiente «pasto», a fine turno.
Le dodici ore destinate al riposo erano così suddivise: appello prima e dopo il turno, l’appello durava mediamente dalle due ore alle due ore e mezza.
Tutto ciò avveniva, lo ricordo, sempre sotto la stretta sorveglianza delle SS, che spesso ci distribuivano sonori ceffoni, staffilate ed anche badilate senza alcun motivo, per il loro semplice divertimento e passatempo.
Molto spesso il turno di lavoro si protraeva ben oltre le dodici ore, finché non interveniva l’altra squadra operaia a darci il cambio. Ero, ed eravamo, trattati peggio che bestie o schiavi; come se ciò non fosse stato sufficiente, spesso l’unico pasto saltava.
Non era possibile lavarsi: per tre mesi siamo rimasti così, sporchi, sbrindellati, affamati, deperiti e torturati in maniera tale da non poter augurare un simile trattamento neppure al peggiore dei nostri nemici.
Il pasto quotidiano (quando c’era) era così composto: un litro di minestra detta sboba, un filo di pane nero da suddividerci fra quattro persone, cinquanta grammi di margarina ed un piccolo rotolino da cinquanta grammi di una specie di salame.
Questo era tutto il nostro vitto in ventiquattrore! Non siamo mai riusciti a capire con che cosa fosse fatto quel pane, ma era talmente poco che il problema diveniva la suddivisione in quattro parti uguali.
Per ottenere quindi la stessa quantità per ciascuno, inventammo una specie di bilancia pesa-briciole, il cui funzionamento si spiega press’a poco così.
Prendemmo un’asticella di legno, la forammo alla sua metà legando alle estremità due pezzi di spago che penzolavano; ai capi delle due cordicelle legammo due legnetti rozzamente appuntiti, tipo stuzzicadenti, sui quali infilavamo i pezzetti di pane e persino le briciole.
Finché l’asticella a forma di T non stava in equilibrio, continuavamo a tagliuzzare il pane, aggiungendo o togliendo quei minuscoli frammenti e spostandoli da uno stuzzicadenti all’altro. La condizione di equilibrio, finalmente raggiunta dopo innumerevoli ripartizioni, ci rendeva tutti assai contenti, perché sapevamo di aver suddiviso equamente la nostra misera razione.
Chi, per sua fortuna, non ha mai provato questo, chi non ha mai sofferto la fame vera, difficilmente potrà capire appieno il significato della parola pane, o che una briciola in più o in meno per noi voleva dire sopravvivere o morire!
I servizi igienici erano stati improvvisati sempre dentro le gallerie dove lavoravamo; come water erano stati utilizzati dei fusti vuoti di benzina tagliati a metà, con un’asta di legno appoggiata sui bordi e sulla quale dovevamo sederci.
Solo una volta al giorno, al mattino, ci era concessa una breve sosta per questo tipo di necessità.. Molto spesso accadeva che quei bidoni non fossero svuotati del loro contenuto, e noi eravamo talmente magri per cui, andando a soddisfare le nostre necessità fisiologiche, ci capitava (è successo anche a me) di scivolare su quell’asse ed andare ad inzuppare il sedere negli escrementi di tutti, che emanavano un fetore tale da prendere la peste.
Quante, quante volte, nel buio della galleria, respirando quell’aria umida e maleodorante, mi tornò alla mente il sole e l’aria di casa mia, dell’Italia!
Un giorno mi trovavo fuori della galleria, perché dovevamo costruire uno stradello in mezzo alla campagna; sotto un melo era stato sistemato uno di quei water sopra descritti. In verità, non perché ne avessi bisogno, ma per concedermi un po’ di respiro ed un attimo di riposo dal duro lavoro, chiesi ed ottenni il permesso di recarmi al cesso.
Nell’aria tiepida di maggio e sotto l’ombra dell’albero di melo, reggendomi seduto in equilibrio precario sull’asse di legno del water, mi capitò di appisolarmi.
Non l’avessi mai fatto! Da poco lontano mi notarono due SS che avevano a fianco il loro cane-lupo: me lo sguinzagliarono contro e la bestia, trascinata dalla sua foga, mi balzò addosso appoggiandomi le zampe anteriori sulle spalle; poco ci mancò che, per la spinta ricevuta, cadessi dentro quel putridume di liquami.
Per fortuna il cane aveva la museruola, altrimenti mi avrebbe azzannato la gola.
Fuggii a gambe levate, e mentre correvo notai i due SS che se la ridevano a crepapelle per lo scherzetto giocatomi.
La paura provata fu tale e tanta che, in seguito, mi guardai bene dall’andare al cesso se non fosse stato indispensabile.
Vorrei sottolineare che questi servizi igienici erano sottoposti allo sguardo di tutti, senza protezione né riparo alcuno, per poter permettere alle SS di controllare sempre ed in qualsiasi momento ogni nostro movimento.
Quante volte pensai che se i miei genitori mi avessero visto così, ridotto in quello stato, difficilmente mi avrebbero riconosciuto, ma senz’altro avrebbero pianto.
Ma le sofferenze, la lotta per la sopravvivenza, l’egoismo che giorno dopo giorno aumentava dentro ciascuno di noi, lasciavano ben poco spazio ai ricordi ed ai sentimentalismi.
Un giorno, mentre lavoravo un po’ lentamente perché al limite delle forze, non mi accorsi che un ingegnere tedesco mi stava osservando: me lo vidi arrivare vicino all’improvviso e, senza dire una parola, mi dette un violento ceffone come punizione per la mia lentezza.
Un’altra volta un caposquadra, sempre tedesco ma civile (nel senso di non militare), mi sferrò un violento colpo con la parte tagliente di un badile, che se non mi fossi scansato in tempo per evitarlo mi avrebbe sicuramente staccato un braccio.
Continuò così tutti i giorni la solita vita: lavoro durissimo, fame, fustigazioni a sangue ed anche a morte. Ci infliggevano le punizioni più atroci ed inimmaginabili, come il farci stare in piedi od in ginocchio sopra il tetto di una baracca mentre cadeva la neve.
A volte pensavo «non è possibile che degli esseri umani sottopongano ad altri loro simili sofferenze così atroci ed alle quali è molto difficile sopravvivere».
Pensavo anche che i tedeschi avessero il cuore più crudele e sanguinario di quello di una belva, o che il cuore e i sentimenti non li avessero affatto. In altri momenti mi sembrava di vivere in un triste, interminabile incubo, ma le sofferenze fisiche mi confermavano invece che vivevo la realtà.
Una volta mi svegliai con una erisipela (o risipola) al naso, ma non marcai visita perché temevo mi avrebbero ucciso.
Mentre ero in riga per l’appello, una SS si accorse di quel gonfiore e fu lui stesso che mi costrinse ad andare in infermeria.
Il medico mi tenne a riposo per undici giorni, curandomi con una pomata da applicare sulla parte infetta: per prolungare quella fortunosa ed inaspettata degenza, quando rimanevo solo mi toglievo tutta la pomata dal naso e la mettevo da una parte, per riapplicarla il giorno successivo prima della visita del medico.
Così pensavo che, più lunga fosse stata la guarigione, maggiormente sarei stato senza lavorare e avrei ripreso un po’ di forze, anche se la razione del cibo era uguale a quella che ci davano quando si lavorava.
Ma la degenza non durò più di undici giorni.
Quando fui dimesso, speravo in qualche giorno di riposo in baracca, ma non fu così: subito al lavoro!
A periodi alternativi venivamo portati a lavorare fuori del campo (sempre sorvegliati a vista dalle SS) al paese vicino chiamato Salza.
I lavori erano vari: d’inverno spalare la neve, oppure riparazioni di strade sconnesse. Mentre si lavorava, con il freddo e la fame che ci logoravano, c’erano dei bambini dall’apparente età di 9 – 10 anni, che con le loro madri accanto ci guardavano lavorare; proprio questi bimbi ci schernivano dicendoci: Italiano: molta fame!»
E poi ci sputavano addosso, senza che nessuna delle loro madri li richiamasse o li sgridasse per un tale comportamento.
Ricordo che solo una volta, forse per caso o perché troppo impietosita dal vederci in quelle condizioni, una madre dette uno schiaffo al proprio figlio per punirlo di quei gesti umilianti che ci aveva rivolto.
Anche nel campo noi italiani eravamo odiati: dai russi, perché ci consideravano tutti fascisti; dai tedeschi perché li avevamo traditi alleandoci con gli americani.
Fine della seconda di tre parti.
(Prima parte)
(Continua)








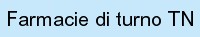














































Invia il tuo commento