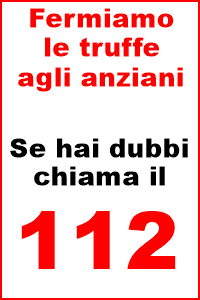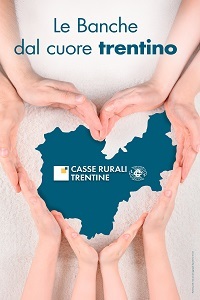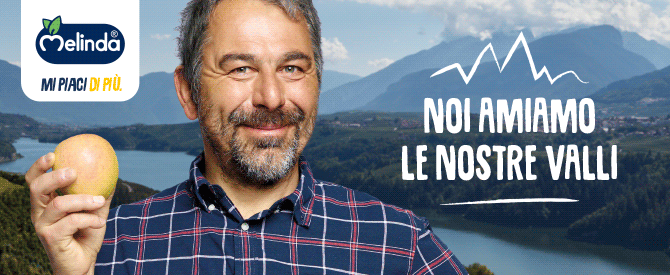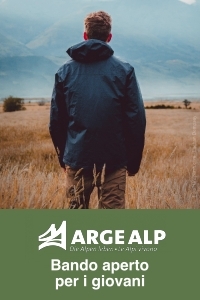Presentiamo Matera, Capitale europea della Cultura 2019
La scelta della «Città dei Sassi» è stata accolta con una vera e propria ovazione dalla gente del web

>
Sarà Matera la città italiana designata a ricoprire l'ambito ruolo di «Capitale Europea della Cultura» per il 2019.
Il titolo, oltre all'Italia, sarà assegnato anche a Plovdiv in Bulgaria.
Il sindaco di Matera Salvatore Adduce, emozionato, ha definito la designazione di Matera come esempio di civiltà e riscatto che da Matera e dal Sud arriva all'Europa.
«Non stiamo più a pietire – ha commentato, – ma a dare un contributo su come la cultura possa trasformare un territorio.»
L'annuncio della designazione ha fatto esplodere la festa in piazza San Giovanni, nel pieno centro storico della Città dei Sassi, dove in migliaia si erano ritrovati davanti al maxischermo per assistere in diretta al verdetto.
Quello che vale la pena aggiungere è che poco dopo la proclamazione, la maggior parte dei giornalisti trentini ha plaudito alla scelta.

Signore e signori, ecco a voi Matera, la «Città dei Sassi»
Matera si trova nella parte orientale della Basilicata a 401 m s.l.m., al confine con la parte sud-occidentale della provincia di Bari e l'estrema parte nord-occidentale della provincia di Taranto.
Sorge proprio al confine tra l'altopiano delle Murge ad est e la fossa Bradanica ad ovest, solcata dal fiume Bradano.
Il corso di questo fiume è sbarrato da una diga, costruita alla fine degli anni cinquanta per scopi irrigui, ed il lago artificiale creato dallo sbarramento, chiamato Lago di San Giuliano, fa parte di una riserva naturale regionale denominata Riserva Naturale di San Giuliano.
Il torrente Gravina di Matera, affluente di sinistra del Bradano, scorre nella profonda fossa naturale che delimita i due antichi rioni della città: Sasso Barisano e Sasso Caveoso.
Sull'altra sponda c'è la Murgia, protetta dal Parco Regionale Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri, più semplicemente detto Parco della Murgia Materana.
Gli antichi rioni chiamati «Sassi», assieme con le cisterne ed i sistemi di raccolta delle acque, sono la caratteristica peculiare di Matera. Si tratta di originali e antichi aggregati di case scavate nella calcarenite, a ridosso di un profondo burrone, la Gravina.
Alla fine del 1993 l'UNESCO ha dichiarato i rioni Sassi Patrimonio Mondiale dell'Umanità.
Foto Matera e la vallata
La «Civita»
Le origini sono molto remote e ne è testimonianza il ritrovamento nel territorio circostante di alcuni insediamenti senza soluzione di continuità sin dall'età paleolitica. Infatti nelle grotte sparse lungo le Gravine materane sono stati ritrovati diversi oggetti risalenti a quell'epoca, testimonianti la presenza di gruppi di cacciatori.
Nel periodo Neolitico gli insediamenti diventarono più stabili, tanto che sono presenti tracce evidenti di diversi villaggi trincerati, in particolare sulla Murgia Timone.
Con l'Età dei metalli nacque il primo nucleo urbano, quello dell'attuale Civita, sulla sponda destra della Gravina. Sorta su un preistorico villaggio trincerato, la città che si sviluppò successivamente ha probabili origini greche. Ciò sarebbe confermato dall'emblema della città, il bue con le spighe di grano, che sarebbe un simbolo tipico della Magna Grecia.
Nel periodo della Magna Grecia, Matera ebbe stretti rapporti con le colonie situate sulla costa metapontina, e successivamente in età romana fu solo centro di passaggio ed approvvigionamento.
Nel 664 d.C. Matera passò sotto il dominio longobardo e venne annessa al Ducato di Benevento. I secoli IX e X furono caratterizzati da aspre lotte fra gli stessi Longobardi, i Saraceni ed i Bizantini, che tentarono più volte di impadronirsi del territorio, e la città fu distrutta dalle truppe di Ludovico II, imperatore dei Franchi, proprio nel tentativo di cacciare i Saraceni.
Nel frattempo, a partire dall'VIII secolo, il territorio materano fu teatro di una notevole immigrazione di monaci benedettini e bizantini, che si stabilirono lungo le grotte della Gravina trasformandole in Chiese rupestri. Dopo l'insediamento dei Normanni avvenuto nel 1043 la città conobbe un periodo di pace.
Nei secoli seguenti, fra carestie e terremoti, Matera fu a lungo città Regia, in quanto si liberava dal dominio feudale riscattandosi più volte, ma sotto gli Aragonesi la città fu ceduta al Conte Giovan Carlo Tramontano, che nel 1514 venne ucciso dalla popolazione oppressa dalle tasse.
Nel 1663, in epoca spagnola, Matera uscì dalla provincia di Terra d'Otranto, di cui fino ad allora era parte integrante, diventando capoluogo della Basilicata. Tale titolo le rimase fino al 1806, quando Giuseppe Bonaparte trasferì le competenze a Potenza. Nel 1927 la città divenne capoluogo di provincia.

Matera fu la prima città del Mezzogiorno ad insorgere contro i nazisti; infatti il 21 settembre 1943, giorno della strage di Matera, il popolo materano insorse contro l'oppressione esercitata dall'occupazione nazista.
Undici persone trovarono la morte a seguito dei mitragliamenti tedeschi in ritirata.
La giornata raggiunse il suo culmine con la feroce rappresaglia nazista che costò la vita ad altri 11 cittadini fatti saltare in aria nel «palazzo della milizia».
Nel 1948 nacque la questione dei Sassi di Matera, sollevata da Palmiro Togliatti prima, e da Alcide De Gasperi dopo.
Nel 1952 una legge nazionale stabilì lo sgombero dei Sassi e la costruzione di nuovi quartieri residenziali che svilupparono la città nuova nella quale confluirono i 15.000 abitanti dei Sassi.
Nel 1980 Matera, che sorge in un’area scarsamente sismica, fu parzialmente danneggiata dal terremoto dell'Irpinia e dalle scosse che seguirono.
Nel 1986 una nuova legge nazionale finanziò il recupero degli antichi rioni materani, ormai degradati da oltre trent'anni di abbandono.
Nel 1993 infine i Sassi di Matera furono dichiarati dall'UNESCO Patrimonio mondiale dell'umanità.
Matera è tra le Città decorate al Valor Militare per la Guerra di Liberazione per la quale le è stato insignito il premio della Medaglia d'Argento al Valor Militare per i sacrifici delle sue popolazioni durante la seconda guerra mondiale.
Tale onorificenza venne conferita il 1º settembre 1966 e consegnata tre anni dopo dal Ministro della Difesa, il quale decorò della medaglia il gonfalone della città e scoprì una lapide con la seguente iscrizione:
«Matera prima città del Mezzogiorno insorta in armi contro il nazifascismo addita l'epico sacrificio del 21 settembre 1943 alle generazioni presenti e future perché ricordino e sappiano con pari dignità e fermezza difendere la libertà e la dignità della coscienza contro tutte le prevaricazioni e le offese.»
La Medaglia d'argento al Valor Militare è stata attribuita con la seguente motivazione:
«Indignati dai molteplici soprusi perpetrati dal nemico, gruppi di cittadini insorsero contro l'oppressore e combatterono con accanimento, pur con poche armi e munizioni, per più ore, senza smarrimenti e noncuranti delle perdite. Sorretti da ardente amor di Patria, con coraggio ed ardimento, costrinsero l'avversario, con aiuto di elementi militari, ad abbandonare la Città prima dell'arrivo delle truppe alleate. Città di Matera, 21 settembre 1943.»

I «Sassi», cisterne e i sistemi di raccolta delle acque
Matera è nota anche come «Città dei Sassi», proprio per la peculiarità e l'unicità del suo centro storico.
Scavati e costruiti a ridosso della Gravina di Matera, una profonda gola che divide il territorio in due, i Sassi di Matera, rioni che costituiscono la parte antica della città, si distendono in due vallette, che guardano ad est, leggermente sottoposte rispetto ai territori circostanti, separate tra loro dallo sperone roccioso della Civita.
Questa posizione invidiabile, ha reso di fatto la città invisibile agli occhi dei suoi nemici per millenni, permettendole di passare pressoché indenne attraverso secoli di storia.
Il Sasso Barisano, girato a nord-ovest sull'orlo della rupe, se si prende come riferimento la Civita, fulcro della città vecchia, è il più ricco di portali scolpiti e fregi che ne nascondono il cuore sotterraneo.
Il Sasso Caveoso, che guarda invece a sud, è disposto come un anfiteatro romano, con le case-grotte che scendono a gradoni, e prende forse il nome dalle cave e dai teatri classici.
Al centro la Civita, sperone roccioso che separa i due Sassi, sulla cui sommità si trovano la Cattedrale ed i palazzi nobiliari. Insieme formano l'antico nucleo urbano di Matera, dichiarato dall'UNESCO paesaggio culturale.
I Sassi di Matera sono un insediamento urbano derivante dalle varie forme di civilizzazione e antropizzazione succedutesi nel tempo.
Da quelle preistoriche dei villaggi trincerati del periodo neolitico, all'habitat della civiltà rupestre di matrice orientale (IX-XI secolo), che costituisce il sostrato urbanistico dei Sassi, con i suoi camminamenti, canalizzazioni, cisterne. Dalla civitas di matrice occidentale normanno-sveva (XI-XIII secolo), con le sue fortificazioni, alle successive espansioni rinascimentali (XV-XVI secolo) e sistemazioni urbane barocche (XVII-XVIII secolo). Ed infine dal degrado igienico-sociale del XIX e della prima metà del XX secolo allo sfollamento disposto con legge nazionale negli anni cinquanta, fino all'attuale recupero iniziato a partire dalla legge del 1986.
La scelta di questo sito, sebbene abbia garantito una estrema sicurezza all'abitato, ha comportato ai suoi abitanti enormi difficoltà nell'approvvigionamento delle acque.
Di fatto i Sassi si trovano su di un enorme banco calcarenitico a circa 150 metri dal livello del torrente, mentre le colline d'argilla che li circondano ad ovest risultano essere troppo lontane, per una città che costruita nell'ottica dell'assedio, doveva garantirsi l'autonomia al suo interno.
Sin dai primi giorni, quindi, i suoi abitanti concentrarono le loro energie non tanto sulla costruzione delle case, quanto sullo scavo di cisterne e palombari e dei relativi sistemi di canalizzazione delle acque.
Vista in quest'ottica Matera risulta essere uno dei più antichi e meglio conservati esempi di bio-architettura al mondo. Una breve analisi dei sistemi insediativi costruiti intorno all'acqua, ci mostra come di fatto tutte le civiltà e le tradizioni costruttive più antiche del mondo, abbiano numerosi punti in comune, sebbene secoli e chilometri le vedano come elementi distinti.
Ad un occhio attento, strutture apparentemente semplici e rudimentali si rivelano come dei prodigi di efficienza tecnica. Le umili tecniche arcaiche, dimenticate dagli stessi abitanti, acquistano un fascino ed un valore un tempo inimmaginabile. I trogloditi che scavano canali e cisterne, costruiscono giardini pensili, ed attorno agli spazi collettivi, oggi chiamati vicinati condividono le proprie risorse, appaiono d'un tratto degli esseri geniali.
Tutto questo è ancora presente e vivo, sotto i nostri occhi in una città, Matera, che ha del magico.
Si ringrazia Wikipedia per le note e per le fotografie.