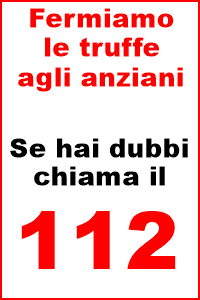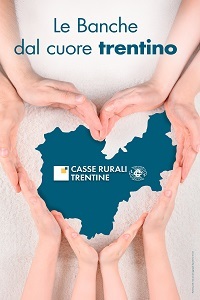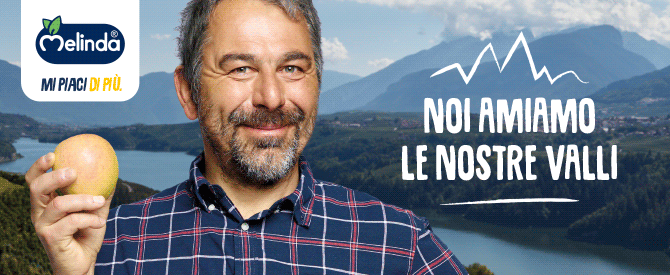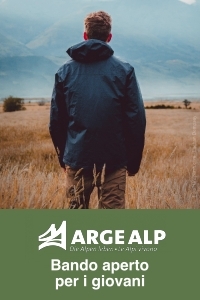Guardia Sanframondi: storia, arte, riti – Di Luciana Grillo
Questo luogo, abitato da Osci, Sanniti, Romani, dominato da Longobardi, Normanni, Svevi, Angioini e Aragonesi, deve il nome ai Longobardi che lo chiamarono «Warda»

La matitona.
Una bella strada, affiancata da vigneti, uliveti e frutteti, ci porta a Guardia Sanframondi, piccola gemma del Sannio, paese di 6.000 anime che sembra avvitarsi – come un’elica – intorno al monte sovrastato dal severo Castello Sanframondo.
Questo luogo, abitato da Osci, Sanniti, Romani, dominato da Longobardi, Normanni, Svevi, Angioini e Aragonesi, deve il suo nome ai Longobardi che lo chiamarono «Warda» e ai feudatari di Ruggiero il Normanno che appartenevano alla famiglia dei Sanframondo.
Era il 1151.
Il Castello passò nel 1469 dai Sanframondo ai Carafa che lo utilizzarono, ora come deposito, ora come abitazione dei coloni, fino al 1806, quando i francesi abolirono ufficialmente il feudalesimo.
Oggi il Castello è uno splendido «palatium», restaurato con cura e dotato anche di un ascensore che conduce al terrazzo da cui si gode uno splendido panorama.
Durante i mesi estivi, è anche sede di spettacoli e concerti.
Ma non c’è solo il Castello a richiamare visitatori e nuovi residenti (come gli statunitensi che in tanti hanno comprato e restaurato case e palazzi); alle ricche chiese, ai suggestivi vicoli, alle ripide scale si accostano fontane monumentali e palazzi signorili, come il Palazzo Marotta - Romano che, restaurato in modo assolutamente innovativo, è diventato un luogo di aggregazione sociale e comunicazione tra parti urbane prima separate.
Sicuramente a Guardia Sanframondi l’interesse per l’arte è diffuso, apprezzato, coltivato: ne sono prova le tante Mostre presenti sul territorio comunale, soprattutto in estate, quando insieme ai visitatori tornano a casa i tanti lavoratori impegnati in Italia e all’estero.
E la prima Mostra da citare è quella allestita nel Palazzo Comunale, che già ospita pregiate tele di Paolo De Matteis, restaurate e in attesa di tornare nelle Chiese a cui appartengono (San Rocco, San Sebastiano, Ave Gratia Plena, Santuario dell’Assunta).
Si tratta dell’audace accostamento alle tele succitate di opere di scultura contemporanea, colorate e dissacranti, segno dei tempi che cambiano e dell’utilizzo di tecniche moderne, realizzate dal maestro Ernesto Pengue.

Palazzo Marotta Romano.
Non lontano, ecco il Museo delle farfalle e della microfauna locale, che espone circa 1000 lepidotteri provenienti dalla collezione privata di un entomologo, donata al Comune dagli eredi.
Questo Museo si sviluppa su due piani, il secondo dei quali ospita un’ utile sala multimediale - didattica.
Se si scende ancora, si arriva alla sorprendente Domus Mata, Museo delle arti e delle tradizioni attive, interessante polo culturale regalato alla sua città d’origine dal maestro Giovanni Mancini: è uno splendido palazzo gentilizio, restaurato dal Mancini con lo scopo di renderlo luogo di incontro fra diverse generazioni di artisti, laboratorio per le scuole, sede di mostre.
Al palazzo si accede costeggiando uno splendido giardino roccioso e incontrando fontane, mascheroni, oggetti reinventati, come una lunga matita che sembra voler scrivere in cielo.
Ed è solo un tronco di palma, che invita a guardare in alto, come dicono i versi di Giuseppe Colangelo «Ero palma mite e rigogliosa… Mi nutrivo di fresca aria… Ora da mani gentili d’artista/plasmata a nuova vita/rinasco aguzza matita/e graffio il cielo più scuro/per segni e attese di miglior futuro».
Le opere esposte sono la dimostrazione evidente delle capacità e della versatilità dell’artista che è insieme pittore, scultore, restauratore, ambientalista ecc. ecc. e che sa usare la cartapaglia, la matita e la china, la resina, l’olio, l’acrilico e la tempera, pastelli, smalti e acquerelli, l’incisione, la serigrafia e la lineografia, il legno, la plastilina e il ferro,l’acciaio, il fil di ferro e il bronzo, il gesso, l’argilla, la terra cruda e la terracotta… Avrebbe avuto ancora molto da dirci questo artista, se una terribile malattia non lo avesse strappato ai suoi cari e all’arte.

Occhi di Ipazia.
Riprendiamo il cammino, tra scale e portoni: si possono vedere le ceramiche della bottega di Nicola Giustiniani, pezzi unici che mescolano con sapienza forme e colori e che trovano la più alta espressione in acquasantiere che collegano il nostro presente laico e frettoloso ad una religiosità profonda e sentita.
E poi ci sono le fotografie graffianti di Antonio Volpone che ci introduce, nella Mostra «De sanguine», all’essenza profonda dei riti che culminano, ogni sette anni in giornate intense ed emozionanti.
Luciana Grillo
De sanguine.