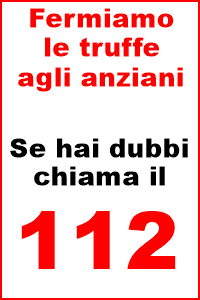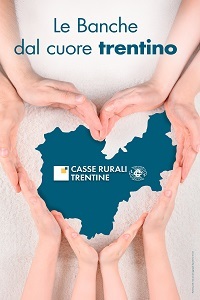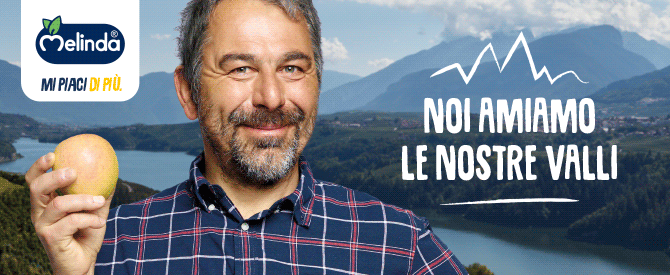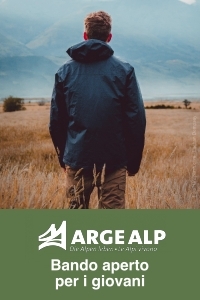Il 1° gennaio 1948 entrava in vigore la Costituzione Italiana
In un momento così buio e difficile per il nostro Paese, siamo riusciti ad approvare una delle più belle leggi costituzionali della storia dell'Umanità
La Costituzione della Repubblica
Italiana è la legge fondamentale e fondativa dello Stato italiano.
Fu approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947 e
promulgata dal Capo provvisorio dello Stato, Enrico De Nicola, il
27 dicembre 1947. Fu pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n. 298, edizione straordinaria, del 27 dicembre
1947.
È entrata in vigore l'1 gennaio 1948. Esattamente 60 anni fa.
Dopo venti anni di dittatura fascista, il 2 giugno 1946 si svolsero
contemporaneamente il referendum istituzionale e l'elezione
dell'Assemblea Costituente, con la partecipazione dell'89% degli
aventi diritto. Il 54% dei voti fu per lo stato repubblicano,
superando di 2 milioni i voti a favore dei monarchici.
L'Assemblea fu eletta con un sistema proporzionale e furono
assegnati 556 seggi, distribuiti in 32 collegi elettorali. Fu la
prima volta in cui i partiti che si erano coalizzati per la
liberazione del Paese cessarono di considerarsi uniti.
Dominarono le elezioni tre grandi formazioni. La Democrazia
Cristiana, che ottenne il 35,2% dei voti e 207 seggi; il Partito
socialista, 20,7% dei voti e 115 seggi; il Partito comunista, 18,9%
e 104 seggi. La coalizione Unione Democratica Nazionale (i
liberali), protagonista della politica italiana nel periodo
precedente la dittatura fascista, ottenne 41 deputati, con quindi
il solo 6,8% dei consensi. Il Partito repubblicano, anch'esso
d'ispirazione liberale ma con un approccio differente nei temi
sociali, ottenne 23 seggi, pari al 4,4%. Il Partito d'Azione,
nonostante un ruolo di primo piano che ebbe nella Resistenza,
ottenne solo l'1,5% corrispondente a 7 seggi.
L'intesa che permise la realizzazione della costituzione è stata
più volte definita «compromesso costituzionale», consistente in una
commistione di concezioni politiche diverse, risultato di
reciproche rinunce e successi. Le forze in seno all'assemblea,
infatti, tendenzialmente, non avendo sicure idee sul possibile
prosieguo della vita politica italiana, piuttosto che tentare di
ostacolare le altre parti politiche, spinsero per l'approvazione di
norme che rispecchiassero i rispettivi principi base.
I lavori sono terminati il 24 febbraio 1947 ma la Costituente verrà
sciolta solo il 31 dicembre 1947, dopo aver adottato la
Costituzione il 22 dicembre con 453 voti contro 62. La Costituzione
è entrata in vigore il primo gennaio 1948. Esattamente 60 anni
fa.
La costituzione era composta da 139 articoli, 5 dei quali sono poi
stati abrogati, divisi in una prima parte dedicata ai diritti e
doveri dei cittadini (art. 13-54), una seconda parte concernente
l'ordinamento della Repubblica (art 55-139) e 18 disposizioni
transitorie e finali, riguardanti situazioni relative al trapasso
dal vecchio al nuovo regime e destinate a non ripresentarsi.
Uscendo da una dittatura, inevitabilmente la Costituzione fu
precisa sui diritti economici e sociali e sulla loro garanzia
effettiva, ma si ispirò ad una concezione antiautoritaria dello
Stato con una chiara diffidenza verso un potere esecutivo forte e
una fiducia nel funzionamento del sistema parlamentare.
Venne riconosciuta importanza fondamentale alle libertà individuali
e sociali, rafforzate da una tendenza solidaristica di base. Fu
possibile anche ratificare parecchie conquiste ottenute nel corso
del Ventennio, come gli accordi lateranensi, e permettere di
accordare una autonomia regionale tanto più marcata quanto più le
minoranze erano radicate. Il Trentino, il Friuli Venezia Giulia, la
Sicilia, la Sardegna e la Val d'Aosta nacquero allora. L'Alto Adige
non faceva ancora parte dell'Italia, tanto vero che gli
Altoatesini, essendo apolidi al momento della Costituente, non
poterono votare per eleggerne i propri rappresentanti. Diventeranno
Italiani dopo il trattato di Parigi di quello stesso 1948 e
riconosceranno la Costituzione Italiana in quanto prevedeva la loro
Autonomia. Si consiglia in proposito di andare a consultare il
nostro articolo pucclicato in occasione del 50° anniversario del
«Los
von Trient».
La nostra Costituzione è caratterizzata da alcuni principi non
revisionabili fondamentali che ne hanno ispirato la redazione,
quali il testo dell'articolo 2, nel quale si dice che «la
Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo».
Tali diritti sono considerati diritti naturali, non creati
giuridicamente dallo Stato ma ad esso preesistenti. Tale
interpretazione è agevolmente rinvenibile nella parola
«riconoscere» che implica la preesistenza di un qualcosa.
Il Principio «pluralista» è quello tipico degli stati democratici.
Anche la Repubblica è dichiarata una e indivisibile, sono
riconosciuti i diritti dell'uomo nelle formazioni sociali (art. 2),
la libertà associativa (art. 18), la libertà delle confessioni
religiose (art. 8), dei partiti politici (art. 49) e dei sindacati
(art. 39). È riconosciuta altresì anche la libertà delle stesse
organizzazioni intermedie, e non solo degli individui che le
compongono, in quanto le formazioni sociali meritano un ambito di
tutela loro proprio.
Il Principio «del lavoro» precisa che non è solo un rapporto
economico, ma anche un valore sociale. Non serve ad identificare
una classe. È anche un dovere, ed eleva il singolo. Se nello stato
liberale la proprietà aveva più importanza, il lavoro ne aveva
meno. Ora i disoccupati non devono comunque essere
discriminati.
Le libertà individuali sono garantite dagli articoli che vanno dal
13 al 28, affermando che la libertà è un valore sacro, che il
domicilio è inviolabile, che ogni cittadino può soggiornare e
circolare liberamente.
Le libertà collettive sono garantite dagli articoli che vanno dal
17 al 21, affermando che i cittadini italiani hanno il diritto di
riunirsi e di associarsi liberamente, che ogni persona ha il
diritto di professare liberamente il proprio credo, che ogni
individuo è libero di professare il proprio pensiero, con la
parola, lo scritto e ogni altro mezzo di comunicazione.
Gli articoli dal 29 al 31 affermano che la repubblica italiana
riconosce la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio
e afferma anche che è di dovere e diritto dei genitori mantenere,
istruire ed educare i figli.
L'articolo 32 afferma che la repubblica tutela la salute come
fondamentale diritto dell'individuo.
L'arte e la cultura sono tutelate dall'articolo 33, che afferma che
l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.
La scuola trova tutela nell'articolo 34, che afferma che la scuola
è aperta a tutti.
Gli articoli dal 35 al 47 affermano che la Repubblica tutela il
lavoro, il lavoratore, e le organizzazioni sindacali.
L'articolo 48 afferma che sono elettori tutti i cittadini italiani;
e che il voto è personale, libero e segreto.
L'articolo 53 afferma che tutti i cittadini sono tenuti a
concorrere alle spese pubbliche (con le tasse) in ragione della
loro capacità contributiva.
La Costituzione è stata più volte modificata con appositi iter
legislativi. Le modifiche che più interessano la popolazione del
Trentino Alto Adige sono quelle che riguardano l'approvazione o la
modifica degli statuti delle Regioni autonome (statuto speciale),
di cui alcuni sono stati approvati nel febbraio 1948 dalla
Costituente. Si tratta delle leggi seguenti:
L.cost. 26 febbraio 1948, n. 2, Approvazione dello Statuto della
Regione siciliana;
L.cost. 26 febbraio 1948, n. 3, Statuto speciale per la
Sardegna;
L.cost. 26 febbraio 1948, n. 4, Statuto speciale per la Valle
d'Aosta;
L.cost. 26 febbraio 1948, n. 5, Statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige;
L.cost. 31 gennaio 1963, n. 1, Statuto speciale della Regione
Friuli-Venezia Giulia;
L.cost. 10 novembre 1971, n. 1, Modificazioni e integrazioni dello
Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige
L.cost. 23 febbraio 1972, n. 1, Modifica del termine stabilito per
la durata in carica dell'Assemblea regionale siciliana e dei
consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del
Trentino Alto Adige, del Friuli-Venezia Giulia;
L.cost. 9 maggio 1986, n. 1, Modifica dell'articolo 16 dello
statuto speciale per la Sardegna, approvato con la L.cost. 26
febbraio 1948, n. 3, concernente la definizione del numero dei
consiglieri regionali;
L.cost. 12 aprile 1989, n. 3, Modifiche ed integrazioni alla
L.cost. 23 febbraio 1972, n. 1, concernente la durata in carica
dell'Assemblea regionale siciliana e dei consigli regionali della
Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino Alto Adige e del
Friuli-Venezia Giulia. Modifica allo statuto speciale per la Valle
d'Aosta;
L.cost. 23 settembre 1993, n. 2, Modifiche ed integrazioni agli
statuti speciali per la Valle d'Aosta, per la Sardegna, per il
Friuli-Venezia Giulia e per il Trentino-Alto Adige;
L.cost. 31 gennaio 2001, n. 2, Disposizioni concernenti l'elezione
diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e Bolzano.