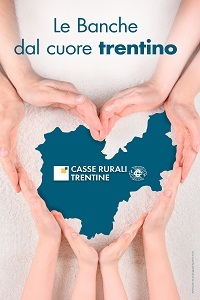Cento anni fa il terribile terremoto sullo stretto di Messina
Fu la più grande tragedia naturale dell'Italia moderna, ma anche il primo esempio di solidarietà internazionale
Stretto di Messina, 28 dicembre
1908. Erano le 5.17 di mattina, quando improvvisamente il cielo si
illuminò di bagliori spaventosi e silenziosi come la morte, che
vennero visti fino a Malta. Non accadde nulla per qualche minuto,
lasciando nell'angoscia i pochi che avevano assistito a
quell'incredibile fenomeno naturale. Poi, d'un tratto, un maestoso
e sordo boato si levò dalle viscere della terra, seguito - alle
5.21 precise - da una terribile scossa di terremoto che fece
tremare la terra per 32 lunghissimi secondi, con epicentro proprio
nello stretto di Messina.
Accadde così il più tragico evento sismico d'Italia.
Gli addetti all'Osservatorio Ximeniano* annotarono: «Stamani alle
5,21 negli strumenti dell'Osservatorio è incominciata una
impressionante, straordinaria registrazione. Le ampiezze dei
tracciati sono state così grandi che non sono entrate nei cilindri;
misurano oltre 40 centimetri!»
|
*L'Osservatorio Ximeniano è un ente autonomo di misure e ricerca specializzato in meteorologia e geofisica. Fondato dal gesuita trapanese Leonardo Ximenes nel 1756 è ancora oggi attivo negli stessi locali ove nacque, all'ultimo piano del Convento dei Padri Scolopi detto di San Giovannino a Firenze. Il laboratorio fa parte della Rete Sismica dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. |
La magnitudo, unità di misura che allora ancora non era stata codificata, fu di 7,1 gradi della scala Richter (quasi l'11° grado della scala Mercalli). In poche ore, ma molto probabilmente in pochi minuti, 100.000 persone persero la vita da Messina a Reggio Calabria.
Le cause principali ti tante vittime furono certamente l'ora e lo stato degli edifici secolari e strutturalmente fragili.

Numerosissime scosse di assestamento si ripeterono nelle giornate successive e fin quasi alla fine del mese di marzo 1909.
Solo a Messina per tale ragione il terremoto provocò il crollo del 90% degli edifici della città. Morirono 80.000 persone su una popolazione di 150.000.
L'entità dei danni al patrimonio edilizio è stata calcolata da Alberto Quadrio Curzio, docente di economia politica all'università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, in circa 100 miliardi di euro di oggi. Le case continuarono a crollare per ore dopo il sisma e molti sopravvissuti morirono anche durante la fuga per strada, sotto una pioggia che rendeva ancora più infernale la città, resa sinistra anche dai lampi che avevano preceduto la catastrofe causati dalle scariche elettromagnetiche emesse dalle rocce compresse della placca poco prima della scossa.
I pochi superstiti scomparvero nella nuvola di polvere che oscurò l'aria. Sotto una pioggia torrenziale e al buio, molti dei sopravissuti inebetiti dalla sventura e seminudi furono colti dalle esplosioni e dagli incendi causati dal gas che si sprigionò dalle tubature interrotte. Tra voragini e montagne di macerie gli incendi si estesero, andarono in fiamme case, edifici e palazzi ubicati nella zona di via Cavour, via Cardines, via della Riviera, corso dei Mille, via Monastero Sant'Agostino.
A Reggio Calabria ci furono circa 15.000 morti su una popolazione di 45.000 abitanti. Gravissimi anche i danni riportati a Reggio Calabria e da molteplici altri centri abitati della Calabria meridionale. Sconvolte le vie di comunicazione stradali e ferroviarie nonché le linee telegrafiche e telefoniche, divelti i cavi dell'energia elettrica e rotti i tubi del gas.
A Reggio andarono distrutte fra le altre, la villa Genoese-Zerbi e i palazzi Mantica, Ramirez e Rettano, nonché diversi edifici pubblici. Caserme ed ospedali subirono gravi danni, 600 le vittime del 22° fanteria dislocate nella caserma Mezzacapo, all'Ospedale civile, su 230 malati ricoverati se ne salvarono solo 29.

A Bagnara di Calabria crollarono numerose case. A Palmi andò distrutta la chiesa di San Rocco. A Trifase nei pressi di Catanzaro si ebbero molti danni ma fortunatamente pochi gli scomparsi data la modesta dimensione delle abitazioni.
In Sicilia si ebbero crolli a Maletto, Belpasso, Mineo, S. Giovanni di Giarre, Riposto e Noto. A Caltagirone crollò per metà il quartiere militare.
Ai danni provocati dalle scosse sismiche ed a quello degli incendi si aggiunsero quelli cagionati dal mare. Improvvisamente le acque si ritirarono e dopo pochi minuti almeno tre grandi ondate aggiunsero al già tragico bilancio altra distruzione e morte. Onde gigantesche, alte oltre 10 metri, raggiunsero il litorale spazzando e schiantando quanto esistente. Nel suo ritirarsi la marea risucchiò barche, cadaveri e feriti. Molte persone, uscite incolumi da crolli ed incendi, furono trascinate al largo e affogarono miseramente. Alcune navi alla fonda furono danneggiate, altre riuscirono a mantenere gli ormeggi entrando in collisione l'una con l'altra ma subendo danni limitati.
Il villaggio del Faro, a pochi chilometri da Messina, andò quasi integralmente distrutto. La furia delle onde, spazzò via le case situate nelle vicinanze della spiaggia anche in altre zone. Le località più duramente colpite furono Pellaro, Lazzaro e Gallico sulle coste calabresi; Riposto, S.Alessio, Briga e Paradiso su quelle siciliane.
 Il maremoto era avvenuto otto minuti dopo il sisma e
aveva fatto altri 2.000 morti, oltre quelli del sisma. Lo tsunami
fu causato da uno smottamento di materiale sottomarino
destabi-lizzato dal sisma al largo dei Giardini Naxos, a metà
strada tra Messina e Catania.
Il maremoto era avvenuto otto minuti dopo il sisma e
aveva fatto altri 2.000 morti, oltre quelli del sisma. Lo tsunami
fu causato da uno smottamento di materiale sottomarino
destabi-lizzato dal sisma al largo dei Giardini Naxos, a metà
strada tra Messina e Catania. Nella foto di fianco, Messina
La prima notizia ufficiale del disastro giunse al presidente del Consiglio Giolitti solo alle 17.25 di quello stesso giorno, col telegramma trasmesso dal comandante della torpediniera Spica che per poterlo inviare si era dovuta portare con la nave a Marina di Nicotera. Nella stessa serata del 28, riunito d'urgenza il Consiglio dei Ministri, il Presidente del Consiglio On. Giolitti esaminò la situazione emanando di concerto le prime direttive del Governo.
Il Comando di Stato Maggiore dell'esercito diffuse ordini operativi mobilitando gran parte delle unità presenti sul territorio nazionale. Il Ministro della marina fece comunicare alla divisione navale in navigazione nelle acque della Sardegna, composta dalle corazzate «Regina Margherita», «Regina Elena», «Vittorio Emanuele» e dall'incrociatore «Napoli», di cambiare rotta e dirigersi verso la zona disastrata.
Il Ministro dei Lavori Pubblici l'On. Piero Bertolini partì subito per Napoli da dove, imbarcatosi sull'incrociatore «Coatit», raggiunse Messina.
Anche il Re e la Regina partirono il 29 per Napoli. Saliti da lì sulla «Vittorio Emanuele», in sosta per caricare a bordo anche materiale sanitario e generi di conforto, raggiunsero la Sicilia nelle prime ore della giornata successiva.
La tragedia provocata dal cataclisma fece immediatamente il giro dell'Europa, scatenando quella che può essere chiamata la prima operazione di solidarietà internazionale.
I primi soccorritori giunti a Messina furono i marinai della flotta imperiale russa, che si trovava nel porto di Augusta, tappa quasi obbligata per la marina Russa quando usciva dal Mar Nero.
Appresa la notizia della terribile sciagura che aveva colpito la nostra città, l'Ammiraglio
 Livtinov salpò nella nottata del 28 dicembre e arrivò
a Messina la mattina del 29. Evitando relitti e detriti
galleggianti, la flotta - composta da due corazzate e due
incrociatori (uno di
questi nella foto di fianco) - riuscì in qualche modo
ad attraccare nel porto, dove già si era formata una folla di
superstiti disperati in cerca di aiuto.
Livtinov salpò nella nottata del 28 dicembre e arrivò
a Messina la mattina del 29. Evitando relitti e detriti
galleggianti, la flotta - composta da due corazzate e due
incrociatori (uno di
questi nella foto di fianco) - riuscì in qualche modo
ad attraccare nel porto, dove già si era formata una folla di
superstiti disperati in cerca di aiuto.Nella stessa giornata arrivò anche la flotta britannica, che coordinò con i russi la propria opera di soccorso.
Appena sbarcati, i russi dovettero fronteggiare l'emergenza. I superstiti avevano bisogno di vestiti e di cibo, mentre per i feriti erano necessarie cure e medicinali. Ma la prima esigenza era scavare sotto le macerie per trovare persone ancora in vita.
I russi si adoperarono con grande eroismo in quest'opera di salvataggio, scavando anche con le sole mani sotto le macerie, incuranti della fatica e del pericolo che le continue scosse di assestamento minacciavano alla loro stessa vita. Soltanto nel primo giorno salvarono un centinaio di persone e trasportarono circa 500 feriti sulle loro navi.
L'eroismo dei marinai russi fu sottolineato da tutti i giornali europei (con eccezione forse di quelli austriaci, come vedremo dopo), all'indomani di un terremoto che trovava un solo precedente nella Storia europea nel terremoto di Lisbona del 1755.
Nei vari giorni che seguirono, i russi da soli salvarono dalle macerie circa 800 persone e fin dal primo giorno trasportarono i feriti negli ospedali facendo la spola con le città di Palermo, Siracusa e Napoli, prestando soccorso a più di 2.500 vittime del disastro.
I primi soccorsi giunsero dal mare, quindi vanno ricordati anche i marinai delle navi inglesi, francesi e americane che si prodigarono nelle operazioni di salvataggio, ma un merito tutto particolare fu riconosciuto all'abnegazione ed all'eroico sacrificio dei marinai russi, tant'è che, già nel primo consiglio comunale dopo il terremoto, i Messinesi deliberarono di erigere un monumento a quei primi salvatori.
|
La solidarietà con Messina andò oltre
il primo e immediato soccorso: fu costituito un comitato
Pietroburgo - Messina che inviò generi di prima necessità e
raccolse fondi per la ricostruzione. Lo stesso Zar donò 50.000
franchi di tasca propria. Anche lo scrittore Gorkij volle
contribuire scrivendo un libro sul terremoto, i cui proventi furono
donati alla città. |
Il 9 gennaio arrivava da Berlino la notizia che l'imperatore tedesco aveva incaricato il medico personale dottore Niepnea di «procedere alla costruzione e alla organizzazione delle sei baracche donate ai profughi rifugiatasi a Palermo, le quali sono ognuna capace di quindici letti e di una cucina. Il dottor Niepnea arriverà domani a Roma per proseguire per Palermo».
Già il 31 dicembre veniva data la notizia che l'imperatore Guglielmo aveva «pregato» la società di Navigazione «Hamburg Amerika Linie» di imbarcare sul piroscafo Illiria in partenza il 5 gennaio sei «padiglioni del sistema Däcker».
Come abbiamo visto, il Re e la Regina d'Italia arrivarono all'alba del 30. Con una lancia a motore, accompagnati dai ministri Bertolini e Orlando, percorsero la costa per poi fare ritorno a bordo della loro nave. Data la gravità e le difficoltà della situazione, la regina era rimasta sulla
 corazzata e contribuì con grande impegno alla cura
degli inferm, mentre il Re raggiunse la terraferma per portare alle
truppe italiane e straniere, impegnate nelle difficili operazioni
di prima assistenza, i propri sentimenti di riconoscenza e di
elogio.
corazzata e contribuì con grande impegno alla cura
degli inferm, mentre il Re raggiunse la terraferma per portare alle
truppe italiane e straniere, impegnate nelle difficili operazioni
di prima assistenza, i propri sentimenti di riconoscenza e di
elogio. Di fianco, Reggio Calabria.
Le navi da guerra, trasformate ormai in ospedali e trasporti, caricati i feriti facevano poi la spola con Napoli e altre città costiere occupandosi anche di trasferire le truppe già concentrate nei porti ed in attesa di destinazione. Cominciò l'afflusso di uomini tra cui i Carabinieri delle legioni di Palermo e di Bari e molteplici reparti dell'esercito. A chi arrivò di notte la città di Messina apparve illuminata dagli incendi che continuarono ad ardere per parecchi giorni.
Fu inevitabilmente necessario applicare la legge marziale per affrontare il vergognoso fenomeno dello sciacallaggio. Per ordine dello stesso Re Vittorio Emanuele III gli sciacalli trovati in flagranza di reato venivano fucilati sul posto.
La stampa uscì con le prime edizioni dei giornali riportando dapprima dati sintetici e poi informazioni dettagliate con il sopraggiungere di notizie più certe e particolareggiate. L'Italia, sbalordita, seppe così che a Reggio e a Messina, interi quartieri erano crollati, che sotto le macerie di case, ospedali e caserme erano scomparsi interi nuclei familiari, malati, funzionari, guardie e soldati. Venne inoltre a conoscenza della meravigliosa gara di solidarietà internazionale apertasi tra navi straniere e italiane per portare aiuto ai superstiti e trasportare sui luoghi colpiti dal sisma i materiali e gli uomini necessari.
Il mondo intero si commosse. Capi di Stato e di Governo e il Papa Pio X, espressero il loro cordoglio e inviarono notevoli aiuti anche finanziari. Unità da guerra francesi, tedesche, spagnole, greche e di altre nazionalità lasciarono i loro ormeggi e, raggiunte le
 due sponde dello stretto, misero a disposizione anche
i propri equipaggi per provvedere a quanto si ritenesse necessario
distinguendosi sempre nel corso delle azioni cui presero parte.
due sponde dello stretto, misero a disposizione anche
i propri equipaggi per provvedere a quanto si ritenesse necessario
distinguendosi sempre nel corso delle azioni cui presero parte.Nella foto di fianco, Messina
In tutta l'Italia, oltre agli interventi organizzati dalla Croce Rossa e dall'Ordine dei Cavalieri di Malta, si formarono comitati di soccorso per la raccolta di denaro, viveri ed indumenti. Da molte province partirono squadre di volontari composte da medici, ingegneri, tecnici, operai, sacerdoti ed insegnanti per portare, malgrado le difficoltà di trasferimento esistenti, il loro fattivo sostegno alle zone terremotate.
Unico fenomeno controcorrente fu rappresentato dal generale austriaco Franz Conrad von Hazendorf, allora capo di stato maggiore dell'Imperial Regio esercito Austro Ungarico, che (contrariamente agli alleati Tedeschi) poco dopo la tragedia incitò il proprio governo alla guerra contro l'Italia per approfittarne dello stato di debolezza del nostro Paese. Richiesta che venne reiterata finché il ministro Ärenthal, esasperato e sconcertato, ne chiese e ottenne l'allontanamento dalla carica. Alla morte di Ärenthal, però, nel 1912, Conrad fu richiamato. Lo avremmo trovato alla guida della Strafe Expedition nel 1916, secondo anno della Grande Guerra.
Per completare il capoverso della ragion di stato, vale la pena ricordare che il progetto di Giolitti di colonizzare la Libia facendo guerra alla Turchia non venne accantonato neanche di fronte ai numeri della catastrofe di Messina. Lo sbarco a Tripoli avvenne regolarmente nel 1911 anche di fronte ad una ricostruzione delle zone terremotate che, per molti versi, non è ancora finita ai giorni nostri. Ovvero 100 anni dopo.
Sono trascorsi cento anni dalla tragedia del 1908, ma a Messina sono migliaia le persone che vivono ancora nelle baracche. Vecchie, fredde, fatiscenti, senza riscaldamento, con i tetti in eternit, il materiale composto da amianto. Se piove, entra l'acqua dappertutto. Un inferno disposto su una superficie di oltre 50.000 metri quadrati. Ci sono topi, ratti e animali di ogni genere che si intrufolano nelle baracche.
Qualcuno ha addobbato comunque un alberello natalizio un po' spoglio anche lì. Anche per loro è Natale.»
GdM
|
Si ringraziano le varie fonti Internet presso le quali abbiamo reperito le foto e verificato le informazioni che abbiano pubblicato, da Wikipedia ai vari comitati per le celebrazioni del terribile centenario. |

|
Elenco dei principali terremoti avvenuti in Italia (in ordine cronologico) |
|
- 62 (5 febbraio) - Pompei - danneggia
le città romane di Pompei ed Ercolano e diversi monumenti di
Neapolis fra cui il teatro romano. |