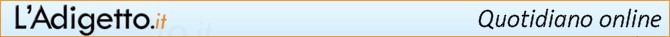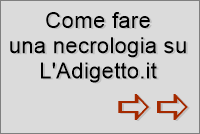Covid 19, la mia esperienza – Di Pietro Laino
Voglio ringraziare medici, infermiere e infermieri, inservienti, addetti alle pulizie, centralinisti e tutti coloro che si sono prodigati per alleviare le difficoltà del ricovero
Inizio a non sentirmi bene il 15 marzo. Ho tutte le ossa rotte, doloranti, la febbre di poco superiore ai 37 gradi e una tosse cavernosa di cui mi meraviglio, avendo da poco fatto il vaccino antipneumococco per la mia bronchite cronica.
A volte, la notte specialmente, perdo la cognizione dello spazio e dell'orientamento nella mia camera da letto dove, normalmente, riesco a camminare anche al buio, fino a non riuscire ad alzarmi dal letto se non aiutato da Luciana, mia moglie.
Una mattina lei telefona al 112, così come avevamo letto e sentito in televisione.
Le dicono che bisogna chiamare il numero dedicato indicandocelo. Luciana chiama e le rispondono che deve rivolgersi al medico curante («Noi ci occupiamo di chi non respira!»).
Lo avevamo fatto già ai primi sintomi e ci aveva consigliato di attendere e vedere come la situazione si sarebbe evoluta prima di considerare l’ipotesi del contagio dal covid-19.
A questo punto, però, il medico si attiva perché io potessi essere visitato dai medici del Pronto Soccorso per una diagnosi più precisa.
Il giorno 24 ci avvertono che sarebbero passati a prendermi con un'ambulanza per portarmi al Pronto Soccorso dell'Ospedale Santa Chiara, cosa che avviene dopo poco.
Arriva a casa un infermiere bardato con una tuta verde, provvisto di mascherina e visiera, con una cuffia sulla testa tal che è impossibile riconoscerlo.
È gentilissimo: mi aiuta ad alzarmi dal letto dove stavo aspettando e, dopo aver indossato una tuta da ginnastica sul pigiama e le scarpe, prendo uno zainetto dove Luciana aveva frattanto messo delle pantofole e altre cose che mi sarebbero potute servire per la visita al pronto soccorso, compreso il mio telefono cellulare con relativo caricabatteria.
Saluto Luciana sulla porta e mi infilo nell'ascensore da solo, mentre l'infermiere scende a piedi.
Arrivo al piano terra e mi caricano sull'ambulanza sistemandomi su di una poltroncina e non sul lettino.
Partiamo e non riconosco il tragitto fino all' ospedale perché è pressoché impossibile guardare attraverso i finestrini satinati del mezzo.
Arriviamo e mi fanno entrare nello speciale P.S., attraverso il vecchio ingresso adesso riservato ai malati di covid-19.
Mi fanno accomodare su di una sedia a rotelle e mi sottopongono ai primi accertamenti.
Poi mi spostano in un angolo più in là, in attesa non so di che cosa, forse, penso, del responso di un medico.
Tutti sono gentilissimi anche se non si sbottonano più di tanto.
In seguito mi fanno stendere su di un lettino e mi portano in una saletta per sottopormi prima ad un tampone poi a raggi al torace.
Continuano a non dirmi niente ed io, in verità, non chiedo nulla.
Dopo essere stato in attesa per altro tempo in una specie di box fatto di tende per un minimo di privacy, mi trasferiscono in una cameretta dove già c'è un altro paziente che dorme.
Intanto sono passate le ore e credo che fosse già buio fuori.
Credo ancora che sarò riportato a casa, ma di li a poco ricevo la notizia che sarei stato ricoverato perché affetto da covid-19 presso l'Ospedale di Rovereto.
Sono in uno stato di trance per cui non riesco neanche a telefonare a Luciana.
Mi prendono e mi caricano su di un'altra ambulanza per portarmi a Rovereto dove giungiamo a notte inoltrata.
Mi sistemano su di una sedia a rotelle e mi portano in una stanza al quinto piano nel reparto di medicina interna dove già ci sono altri tre malati e mi assegnano un letto vicino alla finestra.
Intanto il mio telefono inizia a fare i capricci e non riesco a parlare con Luciana.
Dormo abbastanza bene, sperando di poter tornare a casa al più presto.
La mattina seguente mi sveglio prestissimo, all'alba, e inizia il mio ricovero.
Tramite un infermiere riesco a far funzionare il telefono per poco tempo, poi si zittisce e non funziona più.
Frattanto Luciana via telefono ha saputo della mia situazione anche tramite l'interessamento di una buona amica, la Dr.ssa Daniela Cazzolli, che la rassicura e le dice che sarei stato trasferito a Rovereto.
Poi, mi raggiunge telefonicamente tramite l'interessamento del centralinista, di un infermiere e di un altro paziente che mi scatta anche una foto e che le fa avere il suo numero.
Peccato che non conosca i nomi del paziente e dell'infermiere che cerca ancora di riattivare il telefono.
Il giorno 28 mi comunicano che sarò trasferito al secondo piano, reparto chirurgia generale, dove sono ricoverati i malati di bassa gravità.
Così arrivo nella mia stanza. Mi sembra più ariosa.
Trovo già altri tre pazienti che mi accolgono con cordiali sorrisi.
Qui passerò undici giorni.
Frattanto il telefono non dà più segni di vita per cui Luciana riesce a farmi avere da un'amica di Rovereto, Bruna, un altro telefonino e, con l'aiuto prezioso di un copaziente, riesco a comunicare con l'esterno e liberare così un altro compagno di stanza che mi faceva da ponte con Luciana, dimostrando disponibilità e gentilezza squisite.
Durante i giorni di ricovero, ricordo con profonda riconoscenza il personale del reparto, e non solo, anche i centralinisti che parlano con Luciana e gli addetti all'ingresso che mi fanno recapitare qualche pacco con vestiario, telefonino, ipad e tante piccole cose che mi servono e che, pensando di stare solo poche ore, non avevo portato con me.
Man mano che i giorni passano, mi sento sempre più in gabbia e vorrei tornare a casa tra le mie comodità e con Luciana, ma non posso.
Quante volte mi sono abbattuto sperando nelle dimissioni che non arrivavano mai, specie quando i miei compagni di stanza venivano dimessi o spostati in altro luogo ed erano sostituiti da altri che uscivano prima di me.
Ma quel che mi pesa soprattutto è la mancanza della privacy.
Siamo in quattro in una stanza con le finestre aperte solo a vasistas, senza un bagno, con due soli divisori tra i letti contigui per cui, per chi come me è molto riservato, alcune operazioni riuscivano oltremodo umilianti.
Ogni volta che il personale deve entrare nella stanza, bussa, perché così possiamo metterci le mascherine.
Tutto il personale sanitario veste una tuta (blu per i medici e gli infermieri e bianca per gli inservienti) con mascherine, occhiali, visiera di plexiglass, doppi guanti.
Non si distinguono perché si vedono solo gli occhi e non sappiamo quali siano i medici e quali gli infermieri.
Ricordo solo tre tra questi: Giovanni, che cerca sempre di aiutarci anche in cose non specifiche, una infermiera alta e un'altra con due splendidi occhi neri.
Riescono, non so come, la sera tardi, mentre dormo, a mettermi la flebo senza quasi farsene accorgere: a volte mi sembrano due fantasmi accanto a me. In un angolo della stanza c'è un piccolo lavabo con uno specchio per potersi lavare e farsi la barba.
Non sono mai riuscito a radermi per cui, ancora adesso, ho una bella barba bianca.
Finalmente, dopo un po' di indecisione e dopo avermi fatto un primo tampone, mi dimettono.
Tra la comunicazione e le istruzioni impartitemi da una infermiera sulle procedure e le medicine da prendere, mi vesto e mi appronto per uscire.
Devo attendere fino al primo pomeriggio per poter finalmente uscire.
Così, in ambulanza, arrivo a casa accolto da Luciana… ma non possiamo scambiarci neanche un abbraccio.
Passerò altri giorni in isolamento, ma nel conforto di casa e, dopo altri due tamponi negativi come il primo fatto in ospedale al momento della dimissione, sono giudicato guarito.
Il mio incubo è così finito.
Voglio ringraziare tutti: medici, infermiere ed infermieri, le inservienti, le addette alle pulizie, i centralinisti e tutti coloro che si sono prodigati per alleviare le difficoltà del ricovero.
Grazie a tutti.
Pietro Laino