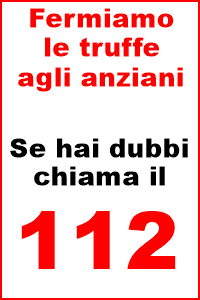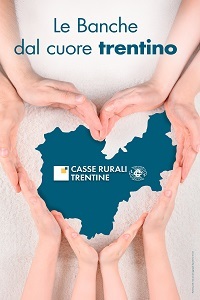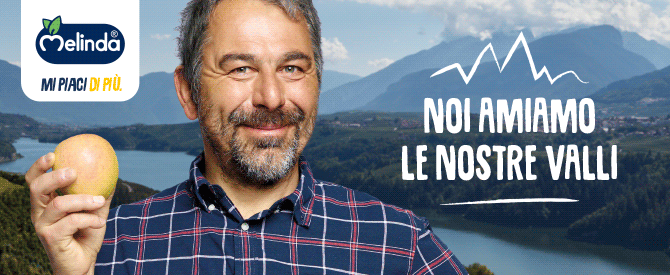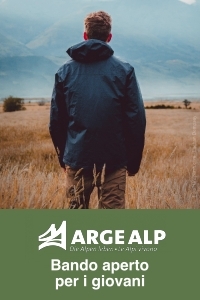Il premio Nobel Akerlof e la sua teoria degli «spiriti animali»
«Il capitalismo è un bambino nel box, quando esce va controllato» «Primo obiettivo dei governi in questa fase di crisi è puntare alla piena occupazione»

L'ottimismo, il senso della
giustizia, la corruzione e la malafede, l'illusione del denaro, le
bugie che raccontiamo a noi stessi e agli altri: secondo George
Akerlof, premio Nobel 2001, l'economia è tutta qui. Ruota attorno a
quelli che, rifacendosi a John Mainard Keynes, chiama gli «spiriti
animali», alle energie mentali di base (oggi riconosciute come
fattori economici) che muovono le azioni degli individui.
Sono gli «animal spirits» che costruiscono la psicologia degli
individui, le categorie da utilizzare per costruire una nuova
teoria economica, un nuovo manuale capace di spiegare perché
l'economia mondiale è precipitata dall'ottovolante, piombando in
una crisi senza precedenti.
A ventiquattro ore dall'uscita nelle edicole dell'edizione italiana
del suo ultimo libro «Spiriti animali - Come la natura umana può
salvare l'economia» (Rizzoli, scritto assieme a R. Shiller),
Akerlof irrompe al Festival decretando il fallimento dell'idea che
le persone, e dunque l'economia così come la sua crisi attuale,
siano mosse da motivazioni soltanto economiche perseguite
razionalmente.
«È soltanto analizzando il ruolo degli spiriti animali e la loro
influenza sulle decisioni economiche - spiega l'economista
californiano - che possiamo spiegarci perché le economie cadono in
recessione, le banche hanno potere sull'economia, le persone non
trovano lavoro, nel lungo periodo sussiste una relazione inversa
tra inflazione e disoccupazione, risparmiare per il futuro è così
arbitrario, i prezzi finanziari e gli investimenti societari sono
così volatili, i mercati immobiliari attraversano cicli e perché
nelle minoranze svantaggiate la povertà persiste per
generazioni.»
Domande alle quali la teoria di Akerlof fornisce risposte
«semplici, naturali e soddisfacenti», descrivendo con efficacia il
funzionamento dell'economia e, cosa assai più importante,
suggerendo cosa va fatto per uscire dalla crisi.
Una «visione» che Akerlof, introdotto da Tito Boeri, ha illustrato
alla Sala Depero, dialogando a distanza (ma lo aveva già fatto
direttamente in mattinata alla conferenza stampa di presentazione
del Festival) con il «collega Nobel» James Heckman, che pure
assegna alla psicologia un ruolo importante nella comprensione di
come si forma l'identità e la personalità di ognuno di noi, anche
se per l'economista di Chicago («la crisi attuale non è stata molto
influenzata dalla psicologia»).
Ma proprio la natura della crisi attuale riporta la palla nel campo
dell'immateriale, a quella stessa natura umana che si esprime
attraverso le manifestazioni fiduciarie o facendo riferimento alle
«narrazioni».
Tutto sembra filare liscio, e tutto è sembrato filare liscio fino
al crollo del sistema bancario americano, quando il mercato è
sorretto dalla fiducia. Così, mossi dalla fede nella bontà del
sistema, migliaia di risparmiatori hanno investito i propri soldi
in titoli spazzatura.
«Ma il capitalismo - avverte Akerlof - approfitta dell'eccesso di
fiducia e finisce per produrre ciò che la gente creda gli serva,
fosse magari anche l'olio miracoloso di serpente.»
Ma cosa succede quando la fiducia viene meno? Accade che la crisi
di fiducia diventa crisi del credito. La storia dell'economia ha
vissuto molti cicli di fiducia data e poi ritirata, solo che gli
economisti classici, quelli che hanno sempre creduto
nell'autoregolamentazione del libero mercato capitalistico, la
crisi non l'hanno per nulla prevista.
Per altro, lo stesso Akerlof ha ammesso al Festival di essere stato
«un po' lento nell'avvertire la gente che la crisi stava arrivando»
(mentre Heckman ha confessato di «non aver previsto la recessione -
vedi
articolo), ma occorre convenire con Tito Boeri,
direttore scientifico del Festival, e farsene una ragione perché
«la crisi è anche un'opportunità per gli economisti di capire
alcune cose».
Cosa occorre dunque capire, secondo Akerlof, di quanto è avvenuto e
cosa è auspicabile che accada?



Primo. Il ruolo dei governi non è solo quello di puntellare le
banche per ampliare il credito e non far saltare il sistema -
processo oltre modo costoso, - devono anche fare in modo che esse
siano solvibili. I governi possono anche finanziare direttamente le
imprese, ed è quanto si sta facendo in Usa, ma si tratta di una
soluzione estrema.
In questa fase due sono per Akerlof gli obiettivi che i governi si
devono porre a breve termine: puntare alla piena occupazione e
creare le condizioni affinché il credito sia concesso in modo
naturale alle imprese. Akerlof ha fatto riferimento alla situazione
americana, ma rispondendo ad una domanda del pubblico sulla
situazione di crisi che sta vivendo il settore manifatturiero
italiano ha affermato che «dovranno essere i consumatori e gli
investimenti delle imprese, più che la liquidità delle banche, a
portarci fuori dalla crisi».
Secondo. «I governi e la gente dovrebbero cercare di non pensare di
risolvere i problemi posti dalla crisi con ricette miracolistiche,
ma avere pazienza e dare credito agli interventi che si stanno
mettendo in atto, vedere se funzionano, e solo quando si ammette la
loro inefficacia modificarli, perché può essere che in futuro si
debbano promuovere azioni più drastiche.»
Un'indicazione concreta, e da attuare immediatamente, però c'è, ed
è mettere mano al diritto fallimentare per risolvere il problema
del crac delle banche.
Resta il problema delle regole e dei controlli.
«Il capitalismo - dice Akerlof - è come un bambino nel box: fino a
quando è dentro si sta tranquilli, ma quando il bambino esce ecco
che occorre controllare dove va e cosa fa.»
E se qualcuno avesse l'ardire di far ricadere tutta la colpa della
crisi sulla finanza creativa, sappia - parola del premio Nobel
Akerlof - che «la finanza creativa può aiutarci a farci uscire
dalla crisi».