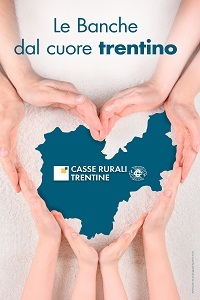Tema: «Boschi a terra. E ora?»
La seconda serata del Parco Adamello Brenta a Dimaro

>
Martedì sera si è svolta a Dimaro la seconda serata della rassegna «I Martedì del Parco» dal titolo «Boschi a terra. E ora?» promossa dal Parco Adamello Brenta per trattare un tema che, a distanza di ormai sette mesi dalla tempesta Vaia, è ancora sentito.
Ancor più fortemente dalla comunità di Dimaro, duramente colpita, anche dal dramma della morte di una giovane mamma, come ha voluto ricordare il sindaco Andrea Lazzaroni nei suoi saluti introduttivi.
Che il tema fosse sentito lo ha mostrato anche la sala conferenze del Municipio, affollata di cittadini e di amministratori, addetti ai lavori, tecnici, intervenuti con la consapevolezza che il recupero dei danni sia un’operazione da affrontare dialogando il più possibile.
Gli ospiti, moderati da Andrea Mustoni, responsabile del settore Ricerca scientifica ed educazione ambientale del Parco, sono stati Paolo Kovatsch dell’Agenzia Provinciale delle Foreste Demaniali, Alessio Giovannelli, ricercatore del CNR IRET di Firenze, e Piergiorgio Canella, comandante della Stazione di Dimaro Folgarida.
Attraverso le varie relazioni si è cercato di affrontar il tema dei danni conseguenti alla tempesta Vaia in modo olistico.
Sono stati aperti ragionamenti per offrire una visione eco sistemica del bosco, non limitandosi a parlare in termini di perdita di metri cubi di legname o di svalutazione del prezzo di vendita.
Il bosco è stato quindi osservato nella sua complessità anche come habitat di diverse specie animali e vegetazionali, come freno di possibili calamità e, con una visione romantica, per le sensazioni che sa suscitare in chi lo frequenta.
Tra gli interrogativi posti ci si è chiesti che ruolo possa avere la ricerca scientifica per prevenire altre situazioni analoghe, dal momento che sembra condivisa nella comunità scientifica l’idea che i cambiamenti climatici in atto ci porteranno in futuro ad assistere sempre più frequentemente a fenomeni atmosferici come Vaia.

A rispondere è stato Alessio Giovannelli che proprio con il CNR IRET a fine ottobre aveva la propria area di studio a Lavazzè.
I sensori con cui Giovannelli monitorava, da remoto, temperatura, umidità e vento sono riusciti a registrare il prima il durante e il dopo del momento in cui la foresta è stata spazzata via.
Vaia ci ha sorpresi con pioggia e vento di portata eccezionale dopo un periodo di siccità prolungato.
Sono state avanzate molte spiegazioni per interpretarne poi gli effetti. Tra queste, per esempio, si è pensato che con un suolo asciuttissimo, la pioggia abbia agito come un lubrificante e abbia favorito il sollevamento delle radici.
Ad oggi, non si può ancora confermare che un’ipotesi sia più accreditata di altre, certo è che per arrivare preparati ad eventi simili si dovranno studiare porzioni di bosco sempre più ampie e diverse possibili.
Paolo Kovatsch a sua volta ha confermato che, grazie alle ricerche scientifiche del passato, ora sappiamo che dobbiamo aspettarci l’arrivo del bostrico con ulteriore perdita di legname.
La Provincia sta quindi lavorando per evitare danni peggiori. Kovatch ha descritto l’impatto della tempesta Vaia a livello provinciale, con particolare riguardo al Trentino orientale, e ha fornito una classificazione del fenomeno inquadrandolo rispetto a quanto è accaduto in altri territori in Italia e in Europa negli ultimi anni.
Di grande interesse e, in un certo senso, anche consolatorio, l’intervento di Piergiorgio Canella con cui si è chiusa la serata.
Canella ha affrontato il tema della sicurezza che ci può garantire il bosco, facendo anche un excursus storico delle varie modalità gestionali adottate proprio in Val di Sole dal 1600 in avanti.
«La situazione è decisamente migliorata rispetto ad un tempo» ha sottolineato Canella.
«Un tempo l’industria del bosco per la produzione di legname destinata a tanti utilizzi lasciava le nostre montagne deforestate con tutte le conseguenze del caso, tra cui le migrazioni di caprioli e cervi. A partire dal dopoguerra, la montagna è stata riforestata e sono state fatte scelte di conservazione della natura grazie alle quali oggi possiamo avere versanti più sicuri e boschi più sani e vivi.»
Pur partendo da un evento drammatico, l’intervento di Canella ha riaperto una visione positiva.
La montagna a rischio zero non esiste eppure non deve tramontare l’idea che l’uomo sia in grado di trovare le soluzioni per dare alle future generazioni ciò che abbiamo avuto noi in eredità, migliorandolo anche un po’.