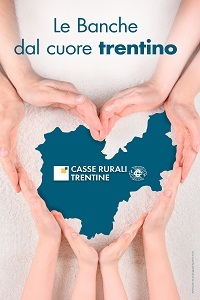Ad Arco il Giorno del Ricordo è stato particolarmente intenso
La storica Maria Luisa Crosina ha tenuto a Palazzo dei Panni una conferenza sulle testimonianze letterarie del dramma delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata

>
Sabato 10 febbraio il Comune di Arco ha celebrato la solenne ricorrenza del Giorno del Ricordo, a memoria dei massacri delle foibe e dell’esodo giuliano dalmata, con una intensa conferenza della storica Maria Luisa Crosina a Palazzo dei Panni, incentrata sulle testimonianze letterarie del dramma delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata, con l'applauditissimo accompagnamento musicale di Monica Maranelli (al pianoforte), giovane musicista arcense di grande talento.
Dopo il saluto e il benvenuto dell’assessore alla cultura Guido Trebo, la prof.ssa Crosina ha ripercorso i tragici fatti accaduti dopo il 25 aprile 1945, data che in Italia diede il via alla liberazione dal nazifascismo e alla fine di vent’anni di dittatura fascista, di occupazione nazista e di cinque di guerra, ma per le popolazioni di Trieste, Gorizia, Fiume, dell’Istria e della Dalmazia segnò l’inizio di un periodo terribile di violenza e martirio.
Un periodo di arresti, sparizioni e uccisioni di migliaia di persone, trucidate, impiccate, torturate, gettate in mare o fatte precipitare ancora vive nelle foibe (inghiottitoi carsici che si aprono nel terreno con ingresso a strapiombo), dove trovarono la morte, spesso dopo una lunga agonia, italiani giuliano-dalmati, oppositori politici croati e sloveni, donne, bimbi, membri del Comitato di liberazione nazionale, ebrei appena tornati dai campi di sterminio.
«La tipologia delle vittime fu quindi assai varia -ha spiegato la prof.ssa Crosina- non solo personalità legate al partito nazionale fascista, ma anche ufficiali, funzionari e dipendenti pubblici, insegnanti, impiegati bancari, postini, sacerdoti, parte dell’alta dirigenza, italiani contrari sia al comunismo sia al fascismo, esponenti delle organizzazioni partigiane o antifasciste, autonomisti fiumani e semplici cittadini con la sola colpa di essere italiani».
Altro capitolo drammatico di quelle vicende, l’esodo giuliano dalmata: l’emigrazione forzata della maggioranza dei cittadini di nazionalità e di lingua italiana dalla Venezia Giulia (comprendente il Friuli orientale, l'Istria e il Quarnaro) e dalla Dalmazia, nonché di un consistente numero di cittadini italiani di nazionalità mista, slovena e croata, che portò all’abbandono di interi villaggi.
Secondo le stime, tra il 1945 e il 1956 fuggirono dalla loro terra tra le 250 e le 350 mila persone.

La prof.ssa Crosina ha arricchito la puntuale narrazione storica con le testimonianze, intense e toccanti, di scrittori che vissero quel dramma: Carlo Sgorlon (Cossacco, 1930-Udine, 2009), i cui romanzi parlano delle due guerre mondiali, delle foibe, della difficile convivenza delle varie etnie linguistiche; Guido Miglia (Pola, 1919-Trieste, 2009), giornalista e insegnante a Trieste che aveva lasciato la sua terra a seguito del trattato del 1947, che ha raccontato l'esodo in «Dentro l'Istria. Diario 1945-1947»; Enzo Bettiza (Brazza, 1927- Roma, 2017), giornalista, scrittore e politico che nel 1996 ha vinto il premio Campiello con «Esilio», romanzo autobiografico sulla sua vicenda si esule dalmata; Nelida Milani (Pola, 1939, sposata Kruljac), scrittrice diventata la voce della minoranza croata e slovena, autrice assieme alla giornalista e scrittrice Anna Maria Mori (Pola, 12 aprile 1936) di «Bora», romanzo autobiografico sulle tormentate vicende della terra istriana viste attraverso gli occhi di un’esule, Anna Maria Moro, e di una persona che è rimasta, lei; e Fulvio Tomizza (Materada, 1935-1999), scrittore che fu esule con la famiglia e la cui esperienza vissuta permea la sua produzione letteraria, soprattutto la trilogia che comprende i romanzi «Materada» (1960), «La ragazza di Petrovia» (1963) e «Il bosco di acacie».
Nella conferenza, anche una breve incursione nella poesia, quella dolente di Lina Galli (Parenzo, 1899-Trieste, 1993), della quale la prof.ssa Crosina ha proposto la struggente «Esuli».
«Per molti decenni, troppi, su questo dramma scese il silenzio -ha concluso Maria Luisa Crosina- le cui ragioni furono politiche e ideologiche.
«E, accanto al silenzio, arrivò perfino il negazionismo. Solo con gli anni Novanta si ritornò a parlare di queste terribili vicende e solo dopo sessant’anni, nel 2004 con la legge 92, si riconobbe ufficialmente questa vicenda, istituendo il Giorno del Ricordo, il 10 febbraio di ogni anno.»