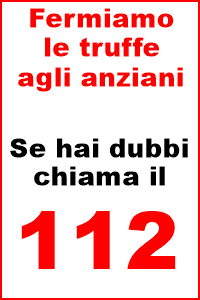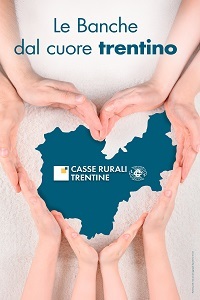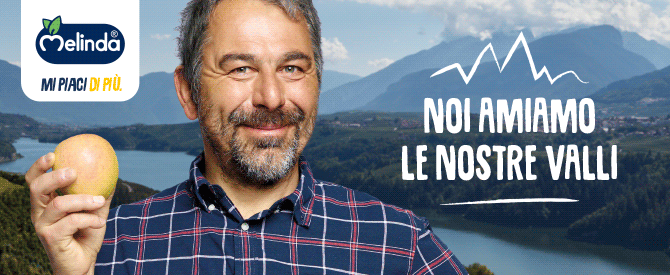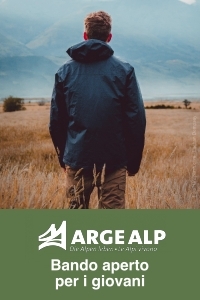La moda maschile a Rovereto, Sec. XVII–XVIII in un volume UCT
Moda e fogge vestimentarie dei patrizi roveretani raccontate da Liliana De Venuto. - Autrice Giuliana Izzi, psicopedagogista
«La toilette è contemporaneamente
scienza, arte, abitudine, sentimento» così diceva Hnorè de Balzac
nel Trattato della vita elegante mentre Georg Simmel nel
suo libro La moda sostiene che essa si fonda su due poli
opposti: da una parte l'imitazione, dall'altra la tendenza del
gruppo dominante ad escludere intrusioni di estranei al suo
interno.
Così ci racconta la storica Liliana De Venuto nel
suo volume La moda maschile a Rovereto. Secoli XVII e
XVIIII e lo fa seguendo un filo logico che conduce il
lettore a una visione completa e articolata della Rovereto di quei
tempi dimostrandoci appunto che l'abito è rappresentazione dello
spirito del tempo, ma soprattutto dell'uomo.
Non è solo la vanità che spinge ad indossare abiti eleganti ma
anche il desiderio di pia-cere alle persone dell'altro sesso;
inoltre agiscono come mezzo di comunicazione e inte-razione
sociale. Oggi la moda è considerata dagli storici non più
manifestazione di futilità ma anche espressione di valori e
pullulano mostre di abiti d'epoca che ci illuminano sul nostro
passato più o meno remoto. Si potrebbe dire: ad ogni epoca la sua
moda, ma come nella storia Giambattista Vico ci dice che ci sono i
corsi e i ricorsi storici, capita che a distanza di tempo la moda
si ripeta e sia pure aggiornata. L'autrice con certosina pazien-za
ha spulciato archivi, biblioteche per trovare poi soprattutto negli
inventari notarili quali fossero gli indumenti indossati da nobili,
prelati, bambini, vestiti che nel tempo cambiava-no nome e
rendevano la ricerca difficile.
Questi inventari sono una parte importante del libro e servivano
nel caso di insolvenza, di lasciti testamentari perché il vestiario
era considerato un patrimonio e con occhio indiscreto ci mostrano
che questi patrizi avevano un guardaroba eterogeneo con abiti lisi,
altri rivoltati e toppe ben nascoste. Anche gli ecclesiastici
avevano un guardaroba niente male e non ubbidivano agli ordini di
una maggiore semplicità. Le stoffe venivano da varie parti del
mondo e ci fanno pensare a una globalizzazione ante litteram.
Alcuni ritratti del Museo Civico ci mostrano le fogge, gli
ornamenti, le parrucche che queste persone indossavano. Lo sfoggio
avveniva per le vie cittadine in lunghe passeggiate dove si
scambiavano chiacchiere perché tutti si conoscevano, nei caffé,
nelle farmacie allora luoghi di ritrovo e infine nel teatro di
nuova costruzione per venire incontro ai loro desideri.
La moda nel Settecento cambiò e quella del Seicento così retorica e
fastosa lasciò il posto, in un clima che voleva essere più poetico,
a un modo di vestire più semplice che rendesse la persona più
disinvolta, più naturale. Liliana De Venuto ci rende edotti dei
vari indumenti che ricoprivano le membra di siffatti signori anche
se qualche dubbio riguarda la biancheria perché si ignora se
indossassero le mutande che ben poco sono citate negli inventari.
Comunque l'autrice ci consegna con stile brillante un quadro
completo della Rovereto di allora non mancando informazioni sul
commercio, sull'artigianato che fioriva intorno a questi lussuosi
guardaroba.