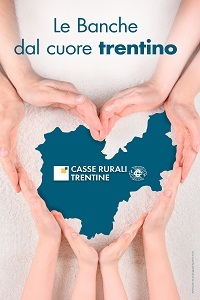«Sanatorium» a Palazzo Trentini – Di Massimo Parolini
Inaugurata dal presidente Dorigatti la mostra che indaga il rapporto tra arte e malattia

«Quella che inauguriamo oggi è una mostra d’arte d’avanguardia: il tema è il dolore e le opere degli artisti indagano il rapporto complesso esistente tra arte e malattia, con un occhio critico sulla società d’oggi. I lavori esposti non suggeriscono terapie, pongono solo il problema. Gli strumenti adoperati sono interessanti: viene esposta un’arte che in gran parte non ha mercato poiché punta a far riflettere e a lanciare un messaggio forte alla politica per spingerla ad un intervento più incisivo di aiuto sociale.»
Sono parole del Presidente del Consiglio provinciale Bruno Dorigatti intervenuto ieri pomeriggio all’inaugurazione della mostra «Sanatorium» nella sala espositiva di Palazzo Trentini.
Sono esposte opere, oggetti, lavori di sei artisti: Fulvio de Pellegrin, Paolo Dolzan, Piermario Dorigatti, Adriano Eccel, Paolo Facchinelli, Capitan Giduglia.
Il tema che funge da collante delle opere è, per l’appunto, il rapporto tra arte e malattia, arte e terapia. Paolo Dolzan ha esposto, in brevis, la poetica dell’evento, costretto in una camicia di forza in dotazione all’ex manicomio di Pergine e venendo interrotto ripetutamente da pozioni di semolino propinategli da un infermiere.
Il concetto che il paziente Dolzan voleva esporre era questa: finora si è considerata l’arte come un’azione di facchinaggio. L’artista è stato considerato un terapeuta che dona il placebo che pulisce la coscienza (del malessere) sociale, esorcizzandone i mali, gli incubi.
«In realtà l’arte ha aumentato il malessere (Munch non guarì né fece guarire, con la sua arte).»
Basti pensare ad artisti come Goya (malato di encefalopatia), Michelangelo (colpito da lunga depressione), Munch (angoscia), Van Gogh (allucinazioni e crisi epilettiche), Pollock (alcool e psicofarmaci), Louis Wain (il pittore inglese dei gatti, psicotico), Rothko (depressione), Camille Claudel (depressione con manie di persecuzione), solo per citarne alcuni (ma anche personaggi politici quali Robespierre, Napoleone Bonaparte e Winston Churchill furono affetti da malattia maniaco-depressiva, disturbo bipolare).
Come ci ricorda un diciassettenne Rimbaud, il poeta (e ci aggiungiamo l’artista) deve «rendere l'anima mostruosa: alla maniera dei comprachicos, insomma! Immagini un uomo che si pianti e si coltivi le verruche sul viso».
Ecco che nel volto-scultura che Dolzan ha inserito in mostra (come nei suoi precedenti lavori sulla famiglia, con lo scotch da pacco) mutilazioni e innesti vengono esibiti.
«Tutte le forme d'amore, di sofferenza, di follia; cerca egli stesso, esaurisce in sé stesso tutti i veleni, per conservarne soltanto le quintessenza. Ineffabile tortura nella quale ha bisogno di tutta la fede, di tutta la forza sovrumana, nella quale diventa fra tutti il gran malato, il gran criminale, il gran maledetto, e il sommo Sapiente!»
Altro che placebo riparatoria delle «brutture» sociali.
Ma forse anche questa (ormai) stereotipata visione psichiatrica (divenuta luogo comune) della contiguità tra genio e follia non piace ai «Sanatorium».
Forse la tesi più intrigante risulta quella di Artaud, espressa nel saggio polemico «Van Gogh il suicidato della società», in cui l’artista diventa un essere superiore perseguitato da una società tarata.
Come scrive Streiff Moretti (recensendo il libro su L'Indice) «L'artista geniale percepisce ondate massicce di odio, le stesse che Artaud sentiva già nel manicomio di Rodez. Colui che gli psichiatri chiamavano schizofrenico accusa ora il delirio collettivo di una società malata che non ammette e non tollera l'esistenza di un altro da sé.
«Non c'è posto, dice Artaud, per una personalità non scissa come quella di Van Gogh quando la mediocrità della massa fa appello agli psichiatri per gelosia verso il genio nel quale vede sempre un nemico: non appena un genio del calibro di Van Gogh (o di Artaud) riesce a trovare il posto del proprio io tra spirito, corpo e carne, accingendosi ad aggredire le contraddizioni di cui si nutre e si avvelena la società, quest'ultima si vendica facendo irruzione in lui per ucciderlo.
«La follia suicida è questo irrompere del mondo esterno che riesce a far scoppiare l'involucro dell'io sotto la pressione delle idee collettive.»
Malattia, morte, consunzione, medicalizzazione: i lavori di Sanatorium creano uno spazio in-sano inquietante, fatto di quadri votivi mariani, materassi rosa e falci sul letto, flebo-clisi di pomodori e barattoli (stuzzichini od organi?) in saldo a 1 €, lastre di crani e vesciche (ove una mente mal-sana paraeidolica potrebbe rinvenire il viso del Dux), camice di forza con lunghissime maniche (Nati con la camicia, Giduglia), omaggi ai rivoluzionari dell’arte novecentesca (il pappagallo di Duchamp è il vaso di urina dell’ospedale poggiato su un attaccapanni) e via di seguito (opere di Dolzan e Capitan Giduglia).
Dolzan non rinuncia tuttavia alla tela, che ne ha fatto negli ultimi anni uno degli artisti più apprezzati (tra i residenti) nel nostro territorio: spiccano due grandi opere.
«L’uomo nero» (con Giduglia), un’ombra-corvo che stringe un uomo-vittima e la «Venere andata a male», la riproposizione anti-classica di uno stereotipo rovesciato (la bellezza come fine) in un nudo espressionista che rinvia all’art brut.
Homuncoli paracelsiani e micro maschere funebri (Giduglia) rimandano a memento mori e memento posthominum, mentre le foto rielaborate di Eccel rinviano a teste scultoree in apertura di meccanismi e a composizioni (quasi) dadaiste di ripetizione modulare.
Anche De Pellegrin usa foto ritoccate proponendo i suoi «Homines», scheletri clericali dalla cripta palermitana dei cappuccini o uno scheletro di uccello. La sua foto che personalmente ci è piaciuta di più è La palla malata, un pallone (di cuoio?) violaceo cucito e tagliato posto su tela candida ricamata, oggetto familiare eppure diverso (dal color del melograno cristologico), quindi un-heimlich, perturbante.
Incontriamo quindi i «Virus» del contatto e della contaminazione di Facchinelli (plexiglass con pigmenti) e le tele (dal colore vagamente sutherlandiano) espressioniste di Dorigatti che rimandano – nelle titolazioni – alla nascita e alla fisiognomica: nello spazio (para) sacrale dell’evento medicamentoso una croce dipinta con schizzi di magenta, ove i petali luterani son sostituiti dai guanti in lattice, è forse un (para e soft) eco di nitsch-iana memoria.
Curato da Tommaso Decarli e Paolo Dolzan, l’evento si concluderà il 14 aprile, in sala Aurora, con una conferenza sul rapporto arte-terapia e la presentazione del catalogo.

PALAZZO TRENTINI – Via Manci, 27 – Trento
«SANATORIUM» a cura di Tommaso Decarli e Paolo Dolzan
Dal 14 marzo al 14 aprile-tutti i giorni dalle 10 alle 18 (eccetto la domenica)