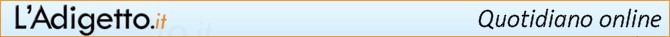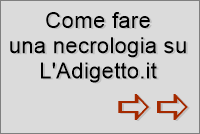Davide Susanetti, «La via degli dei» – Di Daniela Larentis
L’autore del saggio sulla sapienza greca, misteri antichi e percorsi di iniziazione a breve sarà ospite della VI Biennale FIDA Trento – L’intervista

>
La VI Biennale FIDA Trento verrà inaugurata nel centro storico cittadino sabato 14 settembre 2019, alle ore 18.30, negli splendidi spazi di Torre Mirana.
All’importante manifestazione sono collegati una serie di prestigiosi eventi, fra questi segnaliamo la conferenza dal titolo «Incantesimi dell’anima|Simboli del cosmo» a cura di Davide Susanetti, uno degli ospiti d’onore invitati dalla Presidente dell’associazione Barbara Cappello.
L’incontro si terrà a Trento lunedì 23 settembre, presso la Sala Falconetto di via Belenzani 20 alle ore 18.00.
Professore di Letteratura greca all’Università di Padova, Davide Susanetti si occupa di teatro antico, di filosofia greca e di tradizioni esoteriche.
Davvero lungo l’elenco delle sue pubblicazioni: è autore del volume intitolato «La via degli dei. Sapienza greca, misteri antichi e percorsi di iniziazione», edito da Carrocci.
Per lo stesso editore ha pubblicato tra l’altro: «Catastrofi politiche. Sofocle e la tragedia di vivere insieme»; «Euripide. Fra tragedia, mito e filosofia»; «Sofocle. Antigone»; «Il teatro dei Greci. Feste e spettacoli, eroi e buffoni»; «Atene post-occidentale. Spettri antichi per la democrazia contemporanea»; «Euripide. Baccanti»; «Favole antiche. Mito greco e tradizione letteraria europea».
Per Bompiani è in uscita il volume intitolato «La luce delle Muse».
«La via degli dei» è un viaggio davvero appassionante nel mondo della sapienza greca. Il volume è composto da sette capitoli, non è certo facile presentarlo in poche righe, il nostro invito è quello di leggerlo, si verrà condotti passo dopo passo, come è indicato nel testo, «dagli antichi misteri di Eleusi al fuoco divino della teurgia, dagli incantesimi dell’eros alle porte solstiziali dell’antro cosmico, da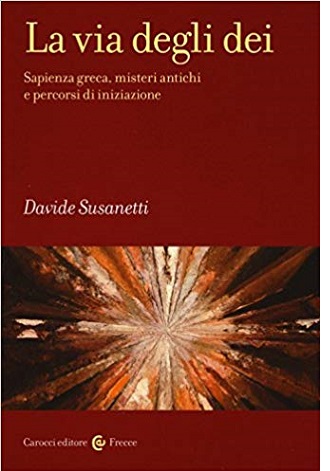 lle discese nell’Ade ai viaggi astrali dell’anima, dall’uovo degli orfici al serpente degli alchimisti, dalla caverna platonica alle visioni di Ermete.»
lle discese nell’Ade ai viaggi astrali dell’anima, dall’uovo degli orfici al serpente degli alchimisti, dalla caverna platonica alle visioni di Ermete.»
Solo qualche rapida osservazione su alcuni brevi passaggi che abbiamo trovato particolarmente significativi, prima di passare all’intervista.
Nel primo capitolo del saggio, attraverso le parole di Cicerone l’autore fa intuire come le iniziazioni misteriche abbiano trasformato l’esistenza dell’uomo facendola evolvere.
«Grazie alle iniziazioni misteriche – afferma ancora Cicerone – «noi abbiamo conosciuto i principi della vita nella loro vera essenza, abbiamo appreso a vivere con gioia e a morire con una migliore speranza».
L’iniziazione ai misteri, come si legge, è «un’esperienza di morte, o, meglio, è l’emozione stessa del morire e di ciò che accade dopo quell’istante» sottolinea Susanetti.
«Essere iniziati significa davvero subire la propria fine […], significa anticipare la morte, mentre si respira e si vive, affrontando l’incognita dell’oltre».
Il capitolo secondo intitolato «Folgorazioni arcaiche, tra Pitagora ed Empedocle» è dedicato a uomini illuminati il cui sapere era accessibile a pochi iniziati; vengono qui menzionati anche alcuni frammenti eraclitei di particolare suggestione.
Nel frammento 18 (che recita «se uno non spera l’insperabile giammai lo troverà»), Eraclito sembrerebbe far intendere che la vera vita è dopo la morte.
Sottolinea Susanetti, riferendosi al frammento, che «chi nulla si attende e spera non potrà mai intraprendere alcuna ricerca».
Il desiderio e la speranza sono costitutivi del nostro essere, il dovere dell’uomo sembra essere questo, sperare l’insperabile. Un tema, quello della speranza, che non può che rimandare a Socrate.
Susanetti dedica un intero capitolo al grande filosofo, il capitolo quarto, tratteggiandone la singolare sapienza attraverso i dialoghi platonici.
È proprio Socrate nel suo ultimo giorno di vita, per nulla turbato dalla fine imminente, come narra Platone nel Fedone, a ricordare agli amici che il vero filosofo non si cura altro se non di quel destino di morte che lo attende; la filosofia è da intendersi quindi come un esercizio di vita autentica, la «musica più grande», un’armonia nel più alto significato del termine.
Nel Fedone la riflessione greca sul tema della morte tocca il suo vertice; la morte viene considerata non come un male ma probabilmente il bene migliore per l’uomo, Socrate ha «ferma speranza» che per i morti ci sia qualcosa, non solo, ma che questo qualcosa, come dicevano gli antichi (in un richiamo alla dottrina orfica), sia migliore per i buoni che per i cattivi.
La morte non sarebbe altro che la liberazione dell’anima dai vincoli corporei e il cercare la verità in questa vita non sarebbe che un esercizio di purificazione per quel passaggio.
L’anima con Socrate assume un nuovo significato, ma se l’anima è immortale, «non tutte le anime sono immortali allo stesso modo».
Parlando di Socrate, e non solo, Susanetti sembra richiamare a un senso di responsabilità della vita che si sta vivendo. Tutto è in fondo funzionale a questa vita, il significato ultimo sembra essere la nostra responsabilità in ogni istante della nostra esistenza.
Desiderosi di saperne di più, gli abbiamo rivolto alcune domande.
Come è nata l’idea di scrivere la «La via degli dei» e a che pubblici si rivolge?
«Ho voluto proporre ai miei lettori un viaggio che parte dal centro sacro di Eleusi, famoso nella Grecia per i suoi rituali misterici. Tappa dopo tappa, il percorso attraversa il mondo degli antichi sapienti dell’età arcaica, da Eraclito a Parmenide, da Pitagora e Empedocle, per giungere nel cuore di Atene, nella scuola di Platone, e da lì procedere verso l’Egitto ellenistico e il tardo antico, per esplorare le prime formulazioni dell’alchimia, dell’ermetismo nonché della magia e della teurgia.
«Alla base del viaggio vi è l’idea, che credo essenziale anche per l’uomo d’oggi, di un’esperienza fondamentale che le antiche iniziazioni proponevano a chi si accostasse ad esse: un’esperienza di trasformazione, di morte e di rinascita, di vera e propria rigenerazione, che portasse ciascuno al cuore di sé e insieme al cuore del cosmo.
«Un’esperienza che, per così dire, perfeziona la vita, la rende cosciente e consapevole, destando facoltà e percezioni altrimenti sopite e inavvertite.
«È come squarciare un velo, una coltre di nebbia, che circonda l’esistenza quotidiana, ottundendo il pensiero e l’anima. Uno squarcio che permette finalmente di vedere con occhi nuovi la realtà, di conoscere quel nucleo sacro e divino che riposa al centro di ognuno di noi. Un nucleo sacro che deve essere portato alla luce, purificato e fatto splendere, perché ognuno, ogni anima è un frammento dell’Anima del mondo.
«Il libro si rivolge a tutti quei lettori che stanno cercando o elaborando, nella propria quotidianità, delle vie per risvegliarsi e desiderano, in tale ricerca, confrontarsi con le pratiche, le immagini e i simboli che la tradizione antica ci ha trasmesso.»
Che cosa intendevano i Greci per «iniziazione misterica»? Qual era il momento culminante del cammino iniziatico?
«La parola greca per iniziazione è telete, che si connette a telos, fine, compimento. Il percorso iniziatico è questo: un portare a compimento, un condurre a perfezione la natura del soggetto che ad esso si sottopone.
«È un cammino, in altre parole, di integrazione perché tante sono le cose, le risorse e i poteri, che dormono all’interno di noi e neppure sappiamo di avere. Diventare integri, interi, nella verità della propria essenza. Nella formulazione più rigorosa, iniziazione è un processo che conduce a un cambiamento dello status ontologico del soggetto.
«Detto in termini più semplici, diventare tutto ciò che non sapevamo di essere, attivare la splendida interezza della nostra natura. Ma per far questo, occorre, prima, nella traiettoria del rito, morire a se stessi, morire a tutto quel plesso di abitudini, opinioni, reattività, attaccamenti e piccole storie con cui siamo soliti identificarci, senza sapere che tutto ciò è solo un involucro esterno, un guscio che nasconda qualcosa di molto più prezioso.
«E gli antichi avevano ben sottolineato questa necessità di questo oltrepassamento nel rito e nella pratica di sé: teleté, dicevano, rinvia anche nel suono della parola a teleute, a morte. Bisogna uccidere il proprio piccolo io e rinascere ad un livello superiore di coscienza.»
E i sapienti arcaici che Lei evoca come s’inseriscono in questo percorso? Anch’essi parlano di riti?
«I frammenti dei cosiddetti filosofi presocratici, così come ci sono stati trasmessi dalla tradizione, sono abbaglianti schegge di una sapienza che si addentra nel cuore invisibile e riposto della realtà: il fuoco di Eraclito, le radici divine di Empedocle, il numero di Pitagora, la rotonda verità di Parmenide sono altrettante immagini, altrettanti modi di additare a un oltre, a un fondamento dell’essere e del divenire, a un’origine prima da cui tutto scaturisce.
«Nei testi si usa il termine physis, “natura”, ma non si tratta della natura visibile che cade sotto i nostri sensi, così come siamo soliti incontrarla. Si tratta appunto di quell’origine da cui la vita del tutto germoglia per legge arcana.
«Questi sapienti non parlano esplicitamente di pratiche rituali o iniziatici, ma il loro logos, il loro discorso promana da quella che Giorgio Colli chiamava vissutezza, un’esperienza fondamentale di apertura, di modificazione di sé e dello sguardo.
«Non è un caso che, nell’evocare, per immagini e simboli, la trama invisibile della natura, essi ricorrano a termini propri dell’iniziazione e a momenti del percorso misterico. A partire dall’epopteia, quella visione suprema che, nei misteri, costituiva il momento culminante: lo squarcio, di cui parlavo prima, in cui si coglie la realtà e se stessa al di là delle umbratili apparenze, in cui si esperisce il cuore pulsante e indistruttibile della vita.
«L’età moderna è stata l’età del disincanto, della razionalità calcolante, della discontinuità digitale. Questi testi ci insegnano, a partire dall’evento di un’esperienza di verità e di visione, a re-incantare il mondo.
«Il che non significa immergersi in fantasticherie o sprofondare nell’irrazionalità. Significa divenire coscienti e connessi della sacralità del cosmo, capaci di percepire se stessi e le cose come parti di un grande tutto, la cui natura, appunto, è tutt’altra da quelle ombre e da quelle illusioni che scambiamo per oggettività.»
Potrebbe accennare al concetto di «antro» di cui parla nel capitolo «Il respiro astrale dell’anima»?
«Per la tradizione antica, antri e caverne erano luoghi sacri, simboli del cosmo. Quelli spazi chiusi e pieni di ombra, scavati nella solidità della roccia e pervasi di umidità rinviavano alla forma e alla natura dell’universo sensibile in cui le anime scendono nel tempo della loro incarnazione.
«Pietra, oscurità e umidità suggerivano la consistenza greve della materia, la sua opacità e insieme quell’elemento fluido e acqueo che è necessario alla vita dei corpi. Ma le pratiche rituali, che negli antri spesso si svolgevano, miravano appunto a insegnare il modo per uscire dalla caverna, per trapassare la materia spessa, per sciogliere la caligine oscura, per rendere l’anima secca come fuoco anziché umida e impregnata dei fluidi della natura sensibile.
«Non è un caso che Platone nella Repubblica abbia descritto il percorso di liberazione dell’uomo come l’uscita da un antro. L’origine dell’immagine e del mito sta tutta nella connessione tradizionale con questi luoghi che, ben prima di Platone, già a Creta, erano luoghi di iniziazione.
«Chi riesce a evadere, sia pur per brevi momenti dall’antro, sperimenta una dilatazione della coscienza e del pensiero: il respiro di un’anima che si dispiega e si libra al di sopra e al di là del corpo, nel cielo e nell’invisibile delle dimensioni superiori dell’essere.»
Nel capitolo citato lei descrive il celebre «antro di Trofonio», discepolo di Socrate, il quale voleva capire cosa fosse il demone che guidava il filosofo; a un certo punto il candidato veniva condotto presso il fiume Ericina in attesa di scendere nell’aldilà, i sacerdoti lo conducevano presso le due sorgenti dove l’iniziando doveva bere prima l’«acqua di Lete» e, in un secondo momento, dalla sorgente opposta l’acqua della «Memoria», scendendo poi nel fondo della voragine e passando per un angusto pertugio, che lei più avanti paragona a una sorta di «utero di una seconda rinascita».
Potrebbe spiegarci il significato profondo di questo rito?
«Mi soffermo su questo luogo, celebre per gli antichi, proprio perché la descrizione del rito, offertaci dei testi, esibisce, in modo paradigmatico quella traiettoria di morte e rigenerazione di cui si parlava.
«Dopo intense pratiche di purificazione, l’acqua di Lete, l’acqua dell’oblio veniva fatta bere al candidato perché si staccasse dalla vita precedente, da tutto quel plesso di eventi e anche di preoccupazioni con cui egli si identificava.
«Svuotare la mente, sciogliere i confini ordinari della personalità, dimenticare tutte le proprie opinioni e credenze abituali, perché un diverso nucleo di sé e della realtà potesse emergere.
«L’acqua della Memoria, per converso, serviva a fissare e rendere permanente la verità e il significato di quell’esperienza, spaventosa e insieme esaltante, che nell’antro si compiva, con una transizione dal buio completo alla luce trasparente del divino.
«Va detto che, per gli antichi, la memoria non è un semplice serbatoio o archivio di dati e informazioni. Memoria, nella sua forma divina, è una potenza che consente di ricongiungersi all’essere e agli dei. Memoria è lo stato di intensità di una coscienza che si attivata ed espansa al suo massimo grado.»
Lei dedica a Socrate un intero capitolo e lo cita anche in diversi altri passi del libro. Che cosa lo rendeva, in breve, così diverso dagli altri uomini?
«Il Socrate su cui mi soffermo è il Socrate che parla e dialoga in quel grande teatro filosofico che è, nel suo insieme, l’opera di Platone. Un teatro dell’anima ove Socrate non cessa di invitare i suoi interlocutori alla “cura di sé”, ad una pratica quotidiana in cui si ci impegnare a esaminare se stessi e la propria vita, ci si impegna a osservarsi, divenendo, forse per la prima volta, consapevoli di tutto ciò che di sé si ignorava. A partire da quel vuoto d’essere, a quella mancanza di verità e di coscienza, che così spesso ci abita.
«Il dialogo con cui il Socrate platonico impegna i suoi amici e conoscenti non è tanto, o non è solo, lo svolgersi metodico di un ragionamento su un tema di indagine, quanto piuttosto l’accadere di un evento in cui ciascuno si rende conto di tutte le illusioni, di tutte le pretese e le vane opinioni, di cui la sua mente e l’esistenza sono gravati.
«È un momento in cui ci si vergogna di se stessi, perché si scopre che non si è affatto quello che si pensava di essere. E non è cosa che faccia piacere: dialogare con Socrate è una tortura, come talora i testi rilevano, perché egli costringere ciascuno ad ammettere la propria insufficienza e la propria inconsapevolezza.
«È un momento in cui il falso io, la personalità sociale si sgretola, aprendo il cammino a qualcosa di totalmente diverso. La possiamo chiamare verità o anima. Perché prima di ogni sistema e di ogni teoria, anima è il nome di quella vita che siamo e non sappiamo di essere.»
Socrate raccontava di una voce interiore che lo accompagnava fin da bambino, il cosiddetto «daimon», da lui considerata di natura divina. Come si può intendere questo misterioso «daimon»?
«Forse la spiegazione più semplice è quella che alcuni autori della tradizione platonica antica hanno dato: daimon è il vertice del nostro stesso essere, quella facoltà intuitiva e sovrarazionale che ci consente di connetterci con il tutto e con la dimensione profonda e invisibile dell’essere. “Daimon” è il nostro nous: si suole tradurre questo termine con intelletto, ma occorre fare attenzione che esso nulla ha a che fare con l’accezione moderna di intellettualità.
«Non si tratta di ragione discorsiva o di capacità dialettiche né tanto meno di un particolare forma di sapere. È mera luce di un’intuizione che si accende nell’anima come fuoco che si sprigiona da una scintilla, per usare un’immagine di Platone.»
La filosofia può essere intesa come pratica di vita?
«Deve essere intesa come pratica di vita. Per gli antichi, dall’età arcaica fino al tardo antico, l’amore della sapienza — perché questo vuol dire “filosofia” prima di diventare una disciplina accademica o intellettuale — è un modo di lavorare su se stessi incessantemente, così come si lavora una pietra per ricavarne una bella statua, una forma di perfetta bellezza, secondo un’immagine proposta da Plotino, su cui nel volume mi soffermo.
«Leggere, dialogare, studiare sono tratti complementari di questa pratica, ma l’essenziale, come tutti i sapienti hanno in vario modo ripetuto, è la melete, l’esercizio quotidiano, con cui si plasma e si trasforma se stessi.»
Nel libro Lei si sofferma sul valore dei simboli e sulla pratica della teurgia. Ci vuole dire qualcosa al proposito?
«La dimensione del simbolo è essenziale per lo sviluppo del percorso iniziatico così come per la ricerca della sapienza. Il simbolo è un’immagine carica di energia: è un dato visibile che si connette, per sua natura, all’invisibile.
«Può essere una pietra, una pianta, un animale, una figura geometrica, un numero o un racconto mitico: in tutti questi casi, per chi sa usarne con sapienza, il simbolo dischiude una porta ad un piano diverso dell’essere, a una dimensione non ordinaria della coscienza. Il simbolo, ancora, rende disponibile, a chi se ne serva in forma rituale, quella forza e quella potenza cui esso rinvia.
«Solo i simboli ci consentono di entrare in relazione con l’armonia invisibile del cosmo e con il divino. La teurgia, o azione divina, insegna a utilizzare tale potenza racchiusa nel simbolo per attivare, come dicevo, una connessione con un livello differente. Adoperare teurgicamente i simboli non vuol dire solo conoscere, ma anche, e soprattutto, poter fare, poter agire sulla realtà e su di sé con una modalità totalmente diversa dall’agire ordinario dell’uomo non risvegliato.
«Nel libro mi soffermo diffusamente sulla natura di tali pratiche e sulle loro implicazioni, così come vengono descritte o suggerite dai testi di età imperiale, dagli Oracoli caldaici ai grandi maestri del neoplatonismo.»
Tra le immagini alchemiche descritte, potrebbe spiegarci la simbologia dell’uovo?
«I simboli non sono qualcosa che si spiega. Sono qualcosa che si intuisce. Possiamo in ogni caso dire che l’uovo — tanto presso gli Orfici quanto negli alchimisti greci — è immagine dell’unità primigenia da cui tutto il molteplice della manifestazione sarebbe scaturito. Chi penetri il segreto dell’uovo — e lo sappia nel proprio laboratorio riprodurre — è in grado di invertire il processo della natura e di riattingere, al di là delle determinazioni finite dei singoli corpi e delle singole materie, a quella sostanza divina totipotente che può diventare qualsiasi cosa perché sta al fondo di ogni cosa.
«Uova in greco si dice oa, ovvero omega e alpha, la fine e il principio. Bisogna partire dalla fine, dal molteplice, dai corpi, per tornare all’alpha del principio. E se lo si fa, si può trasformare se stessi.»
Il teologo e filosofo Vito Mancuso nel suo libro «L’anima e il suo destino» scrive che «il dogma cristiano della risurrezione della carne ha un senso sostenibile solo se lo si intende non tanto nel significato letterale di una vita che continua in un corpo di carne, quanto nel significato speculativo della permanenza della personalità, del principio personale dell’Io» (starebbe a significare l’«immortalità» dell’anima intellettiva, la conservazione della personalità). In questa prospettiva dichiarare l’immortalità dell’anima equivarrebbe a sostenere, come sottolinea il teologo, anche la risurrezione del corpo (se per corpo si intende non la carne materiale ma l’Io e la sua personalità).
Potrebbe condividere con noi un pensiero a riguardo?
«Non sono la persona più adatta a entrare in questioni di teologia cristiana e di dogmatica. La formulazione di Mancuso, per quanto stimolante, è in qualche misura una sorta di prudente compromesso filosofico, speculativo appunto, come egli stesso dice.
«Non credo che permanga alcuna personalità né alcun io. Personalità e Io sono legate a una storia finita, alla forma di una vita particolare, a una singola traiettoria. Ciò che perdura, al di là della contingenza, è un nucleo sovratemporale: un nucleo dotato di una funzione e di un’energia che gli sono proprie, e che torna finché non è terminata la sua stessa funzione o finché è necessaria, nei piani inferiori, la manifestazione di quella vibrazione di energia.
«Ma in questo non vi è nulla di umano o di antropomorfo, nei termini in cui di solito si immagina o si spera. Ogni anima, se vogliamo usare questo termine, ha una sua specificità e una sua funzione, ma, al momento del distacco del corpo, essa si distacca anche da tutta la storia e da tutta l’identità che in quel corpo si sono espressi.
«Plotino diceva che l’anima buona è obliosa, perché, appunto, si dimentica della vita mortale cui è stata legata, per essere solo se stessa, la propria funzione e il proprio essere in seno al tutto. Ma quell’essere non sono “Io” nella mia forma e nella mia identità storiche.
«Ad un altro livello perdura, per contro, una memoria delle vite vissute, la traccia di percorsi e di esistenze, ed è quello che Plotino chiamava il “simulacro”, cioè appunto l’immagine di una vita con le azioni e gli eventi che l’hanno segnata.
«Ma al sapiente non interessa restare attaccato al simulacro, interessa ascendere nel puro regno della luce. Ma è un discorso troppo lungo e complesso per essere sviluppato in questa sede…»
Verità e bellezza sono esperienze primordiali della vita di ogni uomo; anticamente si riteneva che la bellezza scaturisse dalla verità, avvicinandosi al reale ci si avvicinava alla verità. Gli studi relativi al mondo classico che valore possono assumere in una società individualista come quella in cui viviamo?
«Hanno il valore di creare una discontinuità con la corrente del pensiero comune, con la mentalità ordinaria, aprendo la possibilità non solo di esplorare differenti modalità di essere e di vivere, ma anche, e soprattutto, di sperimentarle su se stessi.
«Il postmoderno, in cui ora viviamo, registra un nuovo e fecondo interesse per l’antico e per l’arcaico, scoprendo come il tesoro della Tradizione perenne abbia produttivi ed essenziali aspetti di contatto con le punte più avanzate di un certo pensiero scientifico.
«Ciò che occorre è una nuova sintesi che integri queste dimensioni per disegnare l’orizzonte di una nuova coscienza e segnare una nuova tappa evolutiva del cosmo.»
Progetti editoriali futuri?
«È in uscita per Bompiani un mio nuovo libro, La luce delle Muse, in cui esploro la magia della parola e il potere della poesia nella tradizione sapienziale greca e nei contesti rituali in cui essa si esprimeva e si fruiva.
«Un percorso che va da Orfeo a Omero, dalla lirica arcaica a Platone, in cui le Muse rimandano a una precisa dimensione della mente, legata alla visione dell’essere e alla creatività.
«Al contempo, sto scrivendo un volume che svilupperà alcune questioni de “La via degli dei” soprattutto in rapporto al neoplatonismo. Si intitolerà Il simbolo nell’anima.
«Ma per questo ci vorrà ancora tempo.»
Daniela Larentis – [email protected]