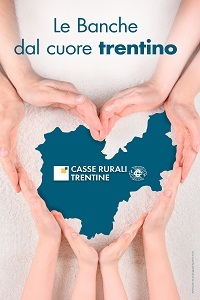Il Concilio, quando l’Europa si diede appuntamento in città
Il Concilio di Trento. Un avvenimento storico che ha cambiato il corso della nostra città, e del quale non si sa mai abbastanza
|
Nel corso della
presentazione del libro «Il Concilio a Trento - I luoghi della
memoria», i relatori hanno espresso l'idea la nostra gente non
sappia molto del Concilio. Eppure si è trattato di un evento
europeo della massima importanza, ma soprattutto che giocò un ruolo
fondamentale alla crescita della nostra città. Basti pensare che
Trento contava dai sei agli ottomila abitanti e che gli ospiti
giunsero quattromila, un po' da tutta Europa. |
La Riforma Protestante è il nome dato al movimento religioso, con risvolti politici rivoluzionari, che ha interessato la Chiesa cattolica nel XVI secolo e che ha portato alla nascita del Protestantesimo.
L'origine del movimento è da attribuire al monaco agostiniano Martin Lutero, ma altri protagonisti importanti lo imiteranno, come Giovanni Calvino, Ulrico Zwingli e altri ancora.
Proprio come molti altri avvenimenti storici, la Riforma Protestante ha una data di inizio ufficiale, che coincide con l'affissione delle 95 tesi da parte di Martin Lutero sulla porta della chiesa di Wittenberg, il 31 ottobre 1517.
La riforma protestante riuscì ad affermarsi, diffondersi e imporsi in alcune aree d'Europa perché, diversamente dai movimenti ereticali medievali, ebbe l'appoggio politico ed economico di molti principi, che ne fecero la religione di stato.
Il peculiare momento storico in cui Lutero predicò fu fondamentale per la nascita delle chiese protestanti in Europa.
La Controriforma, invece è un movimento nato per bloccare, se non ostacolare, la riforma luterana. Questo movimento, chiamato appunto «Controriforma», che trova nel Concilio di Trento il suo atto fondamentale, nasce dall'«alto» della gerarchia cattolica.
La controriforma indicherebbe politicamente quel processo di «ri-cattolicizzazione» dei territori caduti in mano al protestantesimo. Per questo furono spese le energie degli ordini religiosi più forti in un'intensa opera di evangelizzazione.
Il Concilio di Trento o Tridentino (svoltosi dal 1545 al 1563) è considerato dalla Chiesa cattolica il XIX Concilio ecumenico, anche se il suo ecumenismo è stato contestato perché si tenne a lungo senza i vescovi tedeschi. Con questo concilio si definì la reazione alle dottrine del calvinismo e luteranesimo e la riforma della Chiesa. Alla fine non vennero condannate delle persone, ma solo le singole Riforme diverse da quelle codificate dalla Chiesa nel corso del Concilio e nei tempi immediatamente successivi.
Il primo ad appellarsi ad un concilio che dirimesse il suo contrasto col papa fu proprio Lutero, già nel 1518. La sua richiesta incontrò subito il sostegno di numerosi tedeschi, soprattutto di Carlo V, che in esso vedeva un formidabile strumento non solo per la riforma della Chiesa, ma anche per accrescere il potere imperiale. Infatti per questi medesimi motivi la richiesta si scontrò con la ferma opposizione di papa Clemente VII che, oltre a perseguire una politica filo-francese e ostile a Carlo V, da un lato vi vedeva i rischi di una ripresa delle dottrine conciliariste, dall'altro temeva di poter essere deposto (in quanto figlio illegittimo).
L'idea di un concilio riprese quota sotto il pontificato del successore di Clemente VII, papa Paolo III (1534 - 1549), che nel 1536 convocò prima a Mantova e poi a Vicenza un'assemblea di vescovi, abati e di numerosi principi dell'impero, ma senza ottenere alcun effetto a causa del conflitto in corso tra Francesco I e Carlo V.
Dopo il fallimento dei colloqui di Ratisbona del 1541, tuttavia, la sua convocazione fu giudicata improrogabile. Per quanto riguarda la sede, dapprincipio si sarebbe dovuto tenere a Vicenza, ma si scoprì che la famiglia appartenente al ceto aristocratico che si era proposta ad allestire l'evento fosse troppo legata all'imperatore, per cui fu abbandonato il progetto. Già nel successivo 1542 si stabilì che venisse celebrato a Trento poiché, pur essendo una città italiana, era entro i confini dell'Impero ed era retta da un principe-vescovo. Dopo la pace di Crepy, Paolo III poté finalmente emanare la bolla di convocazione nel novembre 1544 e il Concilio si aprì solennemente a Trento il 13 dicembre 1545, terza domenica di Avvento, nella cattedrale di San Vigilio.
Il Concilio contò inizialmente pochissimi prelati, quasi tutti italiani, e fu quasi sempre controllato dai delegati pontifici. Furono presenti anche alcuni prelati legati al cosiddetto evangelismo, come il Cardinale Reginald Pole. Venne trattata una parte dogmatica, sugli argomenti controversi del tempo, che portò a delle definizioni contrapposte a quelle luterane. Non fu quindi possibile risolvere con un accordo il problema con la religione riformata, che nel frattempo era stata tollerata nell'impero con l'Interim di Augusta.
Venne riconosciuta come ufficiale la versione della Bibbia detta Vulgata, evitando l'uso del volgare per le Sacre Scritture nel culto. Tra le deliberazioni più importanti dal punto di vista disciplinare ci fu l'obbligo di residenza dei vescovi nelle loro diocesi. Avveniva infatti che i benefici ecclesiastici e i vescovati venissero assegnati generalmente ai nobili, senza che corrispondesse effettivamente l'obbligo di residenza e lo svolgimento dell'incarico.
Tra i cardinali di recente nomina pontificia, l'ala prevalente era quella riformista. L'ultima parte del Concilio fu tuttavia dominata dalla figura di San Carlo Borromeo, che divenne arcivescovo di Milano e che era nipote del papa regnante durante gli ultimi anni del Concilio, Pio IV.
Al termine del Concilio diverse questioni che non erano state trattate vennero demandate al papa e alla curia romana, che negli anni successivi emise altri importanti documenti sulla riforma della chiesa. Fra questi le revisioni del Breviario e del Messale, con la conseguente uniformità liturgica della chiesa occidentale con l'adozione universale del rito romano, con l'unica eccezione del rito ambrosiano per la diocesi di Milano, e la conseguente scomparsa di tutti gli altri riti occidentali. Furono inoltre pubblicati in seguito il Catechismo Tridentino e l'Indice dei libri proibiti (Index librorum prohibitorum).
La Pace di Augusta firmata dall'imperatore Carlo V del 1555, e quindi in pieno svolgimento del Concilio di Trento, pose fine agli scontri bellici tra cattolici e luterani, introducendo il principio del «cuius regio eius religio» (ognuno segua la religione del proprio re) e stabilendo che i luterani potevano rimanere in possesso dei territori ecclesiastici secolarizzati fino al 1552 con la pace di Passau.
Tuttavia vari problemi rimasero aperti. Oltre al fatto che la pace era considerata, specialmente dai luterani, solo una tregua temporanea, i termini del trattato prevedevano l'adesione, da parte dei principi, al credo cattolico o a quello luterano, con esclusione di ogni altro credo, incluso il calvinismo, che andava diffondendosi rapidamente in varie aree della Germania.
Dopo di allora, i primi scontri di carattere religioso si verificarono nel Sacro Romano Impero a causa del reservatum ecclesiasticum, una norma contenuta nella Pace di Augusta che stabiliva che le autorità ecclesiastiche convertite al protestantesimo dovessero lasciare i propri territori. La questione si presentò quando il principe-arcivescovo di Colonia si convertì al calvinismo; poiché l'arcivescovo di Colonia era anche un principe elettore, si sarebbe venuta a creare una maggioranza protestante nel collegio elettorale. A tale prospettiva i cattolici risposero scacciando con la forza l'arcivescovo e ponendo al suo posto Ernesto di Baviera. In seguito a questo successo cattolico, la regola del cuius regio eius religio fu applicata più duramente in vari territori, costringendo i protestanti ad emigrare o ad abiurare.
Un nuovo scontro religioso si ebbe nel 1606 nella città di Donauwörth, in cui i protestanti tentarono di impedire ai residenti cattolici di organizzare una processione, provocando aspri tumulti e un pesante intervento armato per ripristinare l'ordine.
Questa serie di eventi fece sì che, specialmente tra i calvinisti, si prospettasse l'idea di un «complotto» cattolico per estirpare il protestantesimo. A tale presunta minaccia essi risposero creando, nel 1608, l'Unione Evangelica, sotto la guida di Federico IV del Palatinato, che possedeva uno dei territori che erano fondamentali alla Spagna per garantirsi l'accesso all'Olanda. I cattolici tedeschi risposero creando a loro volta nel 1609 la Lega Cattolica, sotto la guida di Massimiliano I di Baviera.
A questo punto la situazione politica in Germania era pronta per uno scontro confessionale. E di conseguenza militare. L'Europa sarebbe presto andata in fiamme con la Guerra dei Trent'anni.
La Guerra dei Trent'anni fu una lunga serie di conflitti armati che dilaniarono l'Europa dal 1618 al 1648 e può essere definito come il primo vero conflitto europeo, paragonabile alle guerre mondiali che sconvolsero l'Europa nella prima metà del XX Secolo.
I combattimenti si svolsero inizialmente soprattutto nei territori dell'Europa centrale appartenenti al Sacro Romano Impero Germanico, ma coinvolsero successivamente la maggior parte delle potenze europee, con le considerevoli eccezioni di Inghilterra e Russia.
Nella seconda parte del periodo di guerra, i combattimenti si estesero anche alla Francia, ai Paesi Bassi, all'Italia del nord ed alla Catalogna. Durante questi trent'anni, la guerra cambiò gradualmente natura e oggetto. Iniziata come conflitto religioso fra cattolici e protestanti, si concluse in lotta politica per l'egemonia tra la Francia e l'Austria.
Per concludere con un ragionamento più esteso, se l'Impero Turco aveva provato ad approfittare della spaccatura del Mondo Cristiano causata da Riforma e Controriforma, nel corso della Guerra dei Trent'anni se ne guardò bene dal mettersi in mezzo. Quando il conflitto cessò, allora provò a tentare una nuova conquista dell'Europa, all'apparenza stremata.
Ma aveva commesso un grosso errore di valutazione. Trent'anni di conflitti senza quartiere avevano forgiato una nuova mentalità militare negli eserciti europei. L'Europa era diventata moderna, la Turchia era rimasta medievale. Sconfitta, sarebbe uscita di scena, per cominciare il suo lento declino.
G.d.M.