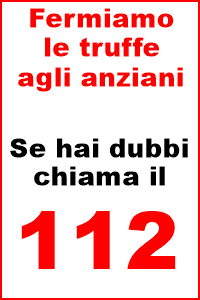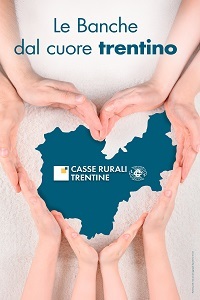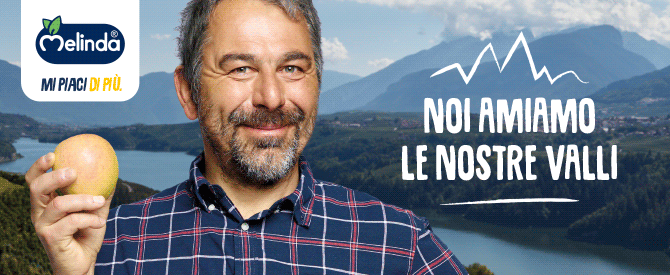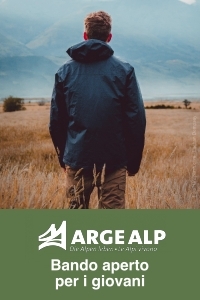Visita guidata alla Pieve di San Lorenzo di Vigo Lomaso
Sabato 13 agosto ci sarà anche il concerto d'archi del quartetto Rigotti

Maestosa, severa e solenne, fuori dal centro abitato la chiesa di Vigo Lomaso racchiude un immenso tesoro di arte, di cultura, di storia e di religione.
Dopo la recente settimana di analisi e approfondimento da parte del gruppo di studio guidato dal Prof. Cavada l'interesse per questa chiesa è notevolmente aumentato.
Dedicata al patrono S. Lorenzo, è costruita su un luogo di culto antico: lo testimoniano alcuni reperti e le piccole are trovate in zona e dedicate a divinità precristiane.
Indubbiamente è la prima pieve delle Giudicarie Esteriori ed è l'unica chiesa trentina con battistero esterno.
Siamo sicuri della sua antichissima origine, ma non abbiamo ancora date certe: il riscontro di «eleganti resti ornamentali» conferma un ruolo importante della chiesa in epoca longobarda.
Il portale ha degli elementi sicuramente altomedievali e probabilmente era preceduto da un piccolo nartece.
Si parla poi di una ricostruzione carolingia ad aula unica nel X secolo.
Un riscontro documentale certo è del 1207.
Nel XIII secolo prese forma la chiesa romanica, a capanna, a tre navate, col tetto a capriate che poggiava direttamente sulle colonne e sui muri perimetrali.
Facile immaginare le fattezze della originaria chiesa romanica, la quale doveva corrispondere alla parte in pietra a vista e con contrafforti digradanti, e che ben si differenzia dal resto della facciata facente parte del successivo ampliamento.
Non sappiamo quando fu costruita la volta della chiesa, in forme gotiche, in sostituzione delle capriate: si ipotizza la seconda metà del sec. XV, probabilmente in concomitanza ai restauri dopo il terremoto del 1457.
La nuova abside gotica, in sostituzione di quella romanica, è del 1497.
Nello stesso periodo si operò un ampliamento, come documentato da una targa nel presbiterio.
Si presume che i lavori siano avvenuti per volere del principe vescovo Udalrico IV di Liechtenstein e di Giovanni Weinach capitano di Castel Stenico, come testimoniato dagli stemmi posti in facciata.
Nel XVI secolo la chiesa fu ampliata con la costruzione di ulteriori due navate laterali.
Nello stesso secolo si operò anche una decorazione a fresco della chiesa, ma poco se ne sa e comunque non ne rimane traccia. Il campanile è stato ricostruito nell'Ottocento.
Gli altari lignei, nominati negli atti visitali, furono tutti sostituiti nel corso degli anni dagli attuali altari marmorei.
Particolarmente bello doveva essere l'altar maggiore, che nel 1633 era «assai pregevole e ornato».
All'interno della chiesa, sopra la porta centrale c'era una vecchia cantoria in legno con organo a 36 registri.
Nella ristrutturazione del 1924 cantoria ed organo vennero rimossi e all'esterno della facciata venne realizzato, quale monumento ai caduti della prima guerra mondiale, il nuovo rosone con i dipinti di Carlo Donati di Verona.
Dello stesso pittore e dello stesso periodo sono gli affreschi interni, compresi quelli dell'abside.
Autentiche sorprese riserva la visita al battistero. A forma ottagonale, è l'unico battistero, già ad immersione, superstite del Trentino.
Addossato alla chiesa è sorto, a quanto sembra, sull'area di un tempio pagano, ad opera di maestranze comacine nel XII secolo.
Conserva molte reliquie romane fra cui l'ara dedicata al dio Silvano da Lucio Settimio (appartenente alla tribù Fabia di Brescia) e una pietra con il rilievo di un soldato con bipenna (attribuito al II sec. d. C.).
L'altare di pietra è ornato da un antipendio scolpito a tecnica piatta (intreccio e simbolo cristiani d'arte paleoromanica), proveniente probabilmente da S. Martino.
Notare anche il trittico tardo-gotico di legno scolpito e dipinto (XVI sec.), il crocifisso ligneo (sempre da S. Martino) e la predella dell'ancona proveniente dalla vicina chiesetta di S. Silvestro. Al centro il battistero di pietra datato 1519.
Nel 1927 il portale romanico del sec. XIII è stato ricostruito fedelmente con gli elementi ritrovati da scavi adiacenti ed il pavimento, che probabilmente recava al centro una vasca utilizzata per il battesimo ad immersione, è stato rifatto in cotto
Dal 1400 al 1702 il Battistero fu anche oratorio della Confraternita dei Disciplini.
All'interno, dove i confratelli si riunivano per i loro esercizi di preghiera e penitenza, c'erano delle pitture, cancellate verso il 1870 perché deteriorate, con «diavoli e maschere», che probabilmente rappresentavano i Disciplini in nere cappe in atto di impugnare il flagello della disciplina.