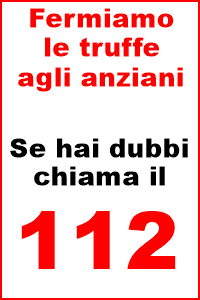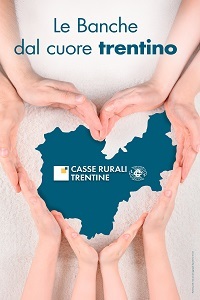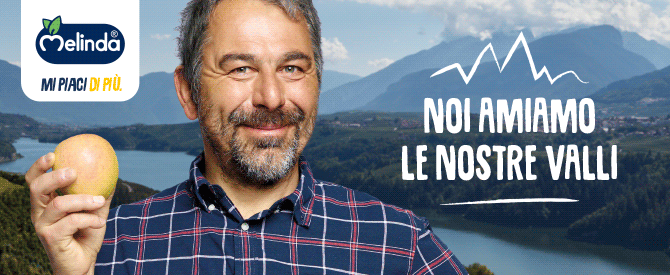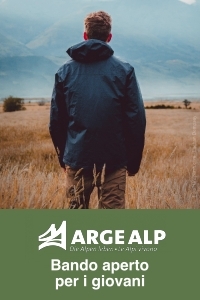Quei mitici spaghetti al pomodoro – Di Giuseppe Casagrande
Chi ha inventato la pasta secca, simbolo della cucina italiana, piatto proposto in mille ricette? Lo racconta lo storico bolognese Massimo Montanari

>
Chi ha inventato gli spaghetti? Chi ha inventato la pasta secca, alimento simbolo della cucina italiana? Chi ha inventato i mille formati di pasta proposti in mille ricette? Dalle più semplici alle più elaborate fino alle pietanze gourmet?
La storia della pasta è antica quanto l'uomo.
Lo racconta Massimo Montanari, tra i più autorevoli storici dell’alimentazione, autore del prezioso volume sugli spaghetti al pomodoro. Un'opera enciclopedica dedicata ad un simbolo che sintetizza alla perfezione la complessità gastronomica dell’Italia e degli italiani.
Un piatto che unisce il BelPaese da Nord a Sud, ma che rappresenta anche la capacità di integrazione del made in Italy.
La pasta secca di formato lungo forse è di origine persiana, ma furono gli arabi fra IX-XI secolo a diffonderla in Italia, precisamente in Sicilia dove nel XII secolo per la prima volta compare un’industria pastaria.
Alla pasta si affianca subito il formaggio grattugiato che per molti secoli rimane il suo condimento principale.
La salsa di pomodoro è una preparazione americana che gli italiani importano dalla Spagna nel Seicento e solo due secoli dopo viene provata sulla pasta.
Dapprima affianca il formaggio, poi diventa il suo condimento principale, ed è solo a questo punto che nel nostro piatto compaiono l’aglio e la cipolla, prodotti antichissimi, ma inadatti ad accompagnare il formaggio.
Al pomodoro poi si affianca un altro prodotto, lui pure di origine americana: il peperoncino. Poi arrivano il basilico e, buon ultimo, l’olio di oliva.
Gli spaghetti al pomodoro sono molto di più di una delle nostre ricette, di origine meridionale, più famose al mondo, un’icona che evoca il tricolore fin dalla  vista: arrotolarli nella forchetta, è un gesto che rappresenta la nostra identità.
vista: arrotolarli nella forchetta, è un gesto che rappresenta la nostra identità.
E se, nelle nostre parodie, Totò si è ispirato ad una scena realmente accaduta nella sua vita nel divorarne una pirofila con le mani in «Miseria e Nobiltà», e Alberto Sordi in «Un americano a Roma» li ha resi per sempre immortali al cinema, grazie a Nando Moriconi, giovanottone di borgata con la fissa dell’America, vestito alla James Dean, che non riesce a resistere alla provocazione dei «Macarò» con una buona bottiglia di Lambrusco, insegnandoci a godere del piacere del buon cibo e del buon vino, anticipando così una passione tutta contemporanea, uno dei maggiori storici italiani, il cattedratico emiliano Massimo Montanari ha scelto di dedicare a questo piatto un libro «Il mito delle origini, storia degli spaghetti al pomodoro» (Editori Laterza, pagine 120, prezzo di copertina 9 euro). Non solo la storia, ma i tanti miti che riguardano questo piatto.
Alle origini di ogni cosa c’è solo un inizio: per cercare l’identità serve tutta la storia, fatta di incontri, incroci, mescolanze. Accade anche per gli spaghetti al pomodoro. Il mito delle origini è quello che ci fa pensare che esista un punto magico della storia in cui tutto prende forma, tutto comincia e tutto si spiega.
Il punto in cui si cela l’intimo segreto della nostra identità. Ma perché quello delle origini è solo un mito?
Il fatto è che le origini, di per sé, spiegano poco: l’identità nasce dalla storia, da come quelle origini si sviluppano, crescono, cambiano attraverso incontri e incroci spesso imprevedibili. Basta un piatto di spaghetti al pomodoro per spiegarlo.
Seguendo le tracce del nostro piatto identitario per eccellenza, Montanari risale a tempi e luoghi distanti, dall’Asia all’America, dall’Africa all’Europa, dalle prime civiltà agricole alle innovazioni medievali, fino a vicende di qualche secolo fa, o dell’altro ieri.
Scopriamo, così, che ricercare le origini della nostra identità (ciò che siamo) non ci porta quasi mai a ritrovare noi stessi (ciò che eravamo) bensì altre culture, altri popoli, altre tradizioni, dal cui incontro e dalla cui mescolanza si è prodotto ciò che siamo diventati.
Dopo quanto è successo per l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica, non sarebbe male riflettere, come fa il grande storico bolognese con la sua autorevolezza, ma anche con estrema chiarezza, sulla nostra identità e sul significato di unità nazionale ed integrazione, che anche un semplice piatto di spaghetti al pomodoro riesce ad emanare.
«Radici e identità sono parole pericolose, da maneggiare con cura – spiega Montanari – frequentemente le si vedono fraintese e confuse, mentre è  importante distinguerle. Le radici abitano il passato: sulla linea del tempo - se vogliamo raccontare la nascita, la crescita, lo sviluppo di qualsiasi realtà - stanno all’inizio, e nello spazio si allargano per trarre alimento da ogni fonte raggiungibile (la metafora botanica, affinché sia utile, va usata fino in fondo).
importante distinguerle. Le radici abitano il passato: sulla linea del tempo - se vogliamo raccontare la nascita, la crescita, lo sviluppo di qualsiasi realtà - stanno all’inizio, e nello spazio si allargano per trarre alimento da ogni fonte raggiungibile (la metafora botanica, affinché sia utile, va usata fino in fondo).
Massimo Montanari.
«All’altro capo della linea del tempo stanno le identità, che invece abitano il presente - un presente mobile, sempre teso a proiettarsi nel futuro diventando esso stesso passato.
«In qualsiasi punto della linea cronologica, le identità sono un punto d’arrivo: spazi mentali e materiali ben delimitati le caratterizzano, ma sempre instabili e mutevoli, come è proprio di tutto ciò che vive. Perdere di vista questa vitalità significa precludersi uno sguardo veramente storico attorno al tema delle identità e delle radici da cui esse provengono, ossia le loro origini.
«Significa pensarle immutabili rispetto al futuro, preoccupandosi non di tenerle in vita - con gli opportuni adattamenti - ma di congelarle, codificarle, musealizzarle.
«Significa pensarle immutate rispetto al passato - un passato che a questo punto diventa puro mito e colossale mistificazione. È l’idolo delle origini che rispunta, contro ogni evidenza, contro ogni logica.
«Ma lo storico si illude che il semplice racconto dei fatti possa aiutare a far luce sul senso delle parole e delle cose. Soprattutto quando le cose sono aspetti della vita con cui ci confrontiamo quotidianamente. Per esempio il cibo, i prodotti alimentari, le ricette di cucina.
«È possibile sedersi a tavola di fronte a un piatto di spaghetti al pomodoro e riflettere sul senso delle radici, delle identità, delle origini? – Si domanda in conclusione Montanari – È quanto ho provato a fare in queste pagine.»
Giuseppe Casagrande – [email protected]