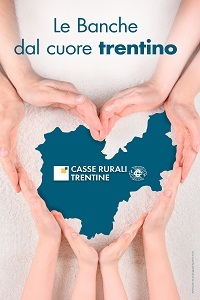Il 4 novembre di 90 anni fa finiva la Grande Guerra
I ritardi di Diaz - Terza battaglia del Piave - Il proclama di Caviglia - La vittoria sul Grappa - L'ambiguità degli alleati - L'invenzione di Vittorio Veneto

La seconda grande battaglia del
Piave, detta «del Solstizio» perché si era svolta dal 15 al 24
giugno (vedi nostro
servizio), era stata la prima grande vittoria tutta
italiana di una grande battaglia (e per qualche critico storico è
stata anche l'unica). Certo si potrebbe dire che la Grande Guerra
fosse finita lì, ma purtroppo i combattimenti continuarono ancora
per mesi, portando con sé altre decine di migliaia di soldati
uccisi. All'indomani della vittoria del Solstizio, tuttavia, non
solo il nostro esercito ma anche l'intera nazione poterono rialzare
la testa per la prima volta dopo Caporetto.
Gli alleati non erano mai stati ottimisti sulle sorti di quella
battaglia, tanto vero che avevano sollecitato i nostri comandi di
ritirarsi sulla linea del 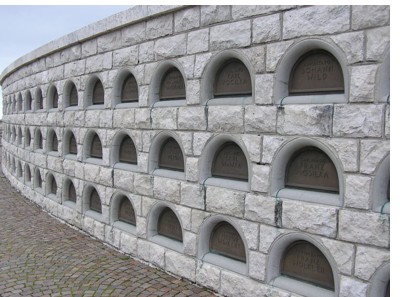 Mincio. Adesso era tutto cambiato e si cominciò a discutere
su tutto, sia dal punto di vista militare che politico, sia a
livello interno che interalleato.
Mincio. Adesso era tutto cambiato e si cominciò a discutere
su tutto, sia dal punto di vista militare che politico, sia a
livello interno che interalleato.
Già quando la battaglia del Solstizio finì, i nostri politici
domandarono a Diaz per quale motivo avesse sospeso i combattimenti,
dato che le sorti stavano volgendo a nostro favore. Ma il comando
italiano aveva fatto più che bene a fermarsi, soprattutto in ordine
al fatto che anche per noi sarebbe stato un problema passare il
Piave in piena e battere il nemico. Ma già un mese dopo Diaz
avrebbe dovuto attaccare a tutti i costi, perché le informazioni
che continuavano ad arrivare sul suo tavolo mostravano
inequivocabili segni di cedimento e disgregazione da parte degli
Imperi Centrali, tanto che D'Annunzio arrivò a pronunciare la
famosa frase «c'è fetore di pace nell'aria».
Diaz invece volle attendere, forse perché la possibilità di un
fiasco era ancora in agguato. Di certo però non aveva la visione
politica che invece in quel momento avevano i suoi colleghi
alleati. Attese dunque troppo.
Era accaduto che il 18 luglio Ludendorff e Hindenburg avevano
ufficialmente preso atto che «la guerra non poteva concludersi
favorevolmente per la Germania». La scelta era se perdere la guerra
a tavolino o sul campo di battaglia. Contrariamente a quello che
avrebbe fatto Hitler nella Seconda Guerra, a Berlino decisero di
tentare la via negoziata. Si mossero le varie diplomazie ma, per
quanto lavorassero in maniera assolutamente segreta, era sulla voce
di tutti i governi che ormai era solo questione di tempo.
L'imperativo era dunque quello di ottenere i massimi risultati
militari sul campo, in modo che al tavolo della pace ci fossero già
dei risultati acquisiti.
Questo ovviamente era noto anche al Governo e al Re d'Italia, i
quali spinsero Diaz a prendere subito l'iniziativa senza altro
attendere.
 Gli alleati, che fino a quel momento avevano insistito
affinché Diaz scatenasse l'offensiva, adesso erano del tutto
contrarti all'azione. Al massimo avrebbe potuto «sferrare un
attacco sugli altipiani», dove nessuno dei due eserciti aveva
possibilità di battere l'altro.
Gli alleati, che fino a quel momento avevano insistito
affinché Diaz scatenasse l'offensiva, adesso erano del tutto
contrarti all'azione. Al massimo avrebbe potuto «sferrare un
attacco sugli altipiani», dove nessuno dei due eserciti aveva
possibilità di battere l'altro.
Si arrivò a metà ottobre, quando l'imperatore d'Austria cominciò ad
avviare a sua volta iniziative tese a salvare il salvabile. Invitò
le popolazioni soggette a raggrupparsi sotto le rispettive
nazionalità, informando Wilson che - aderendo ai suoi 14 punti -
avrebbe «sgomberato le terre invase». In Valsugana si ammutinarono
alcuni reggimenti ungheresi. Nelle retrovie cominciavano i
saccheggi dei magazzini militari. Vittorio Veneto era stato
abbandonato undici giorni prima che gli Italiani sferrassero
l'attacco.
Alle 3 di mattina del 24 ottobre, a soli dieci giorni dalla firma
dell'armistizio, Diaz diede ordine di attaccare su tutto il fronte.
La IV Armata attaccò sul Grappa con impeto e generosità, ma
incontrò un'imprevedibile resistenza a oltranza da parte avversa.
In effetti lo sfondamento del fronte avrebbe provocato il crollo
dell'intero sistema difensivo austriaco e forse proprio per questo,
nonostante i nostri eroici attacchi, le posizioni vennero
conquistare e perse, riconquistate e riperse. Ma l'attacco
durissimo delle nostre truppe provocò quantomeno il trasferimento
di unità austriache dalla pianura al Grappa, invitando così le
nostre VIII e X Armata a passare il fiume. Ma la piena restava
violentissima. I nostri genieri gettano ponti, le nostre truppe
passano il Piave, poi la piena travolse i ponti e il tutto si
fermò, col rischio di perdere le teste di ponte insediate al di là
del Piave.
Sul Grappa furono addirittura gli Austriaci a contrattaccare
furiosamente. I combattimenti, pure accaniti, non ottennero
risultati.
Il 28 ottobre, a 7 giorni dall'armistizio, sembrava ancora tutto in
bilico, con i nostri soldati allo stremo delle forze e con gli
Austriaci galvanizzati 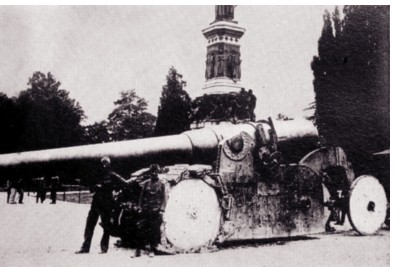 dalla consapevolezza di combattere per la vita o la
morte. A mezzogiorno di quel 28 ottobre, il generale Caviglia mandò
un proclama alle truppe. «Tutto il popolo italiano ci guarda in
questo momento - scrisse nel messaggio fatto leggere su tutta la
linea del fronte. - La storia dell'Italia del prossimo secolo
dipenderà dalle prossime 24 ore.»
dalla consapevolezza di combattere per la vita o la
morte. A mezzogiorno di quel 28 ottobre, il generale Caviglia mandò
un proclama alle truppe. «Tutto il popolo italiano ci guarda in
questo momento - scrisse nel messaggio fatto leggere su tutta la
linea del fronte. - La storia dell'Italia del prossimo secolo
dipenderà dalle prossime 24 ore.»
Fu davvero «il giorno più lungo», ma fu anche l'ultimo. Sotto lo
slancio dei nostri soldati, la linea di difesa austriaca, sfondata,
crollò di colpo. Sconfitti sul campo, sconvolti dalla fame,
annichiliti dalle notizie dlla patria, moralmente abbandonati, gli
Austriaci si disgregarono.
L'indomani, 29 ottobre, le nostre armate passarono il Piave,
finalmente placato anche lui.
Quella stessa mattina del 29 ottobre, alle ore 10, il comando
austriaco diramava l'ordine di dar corso alle trattative per
l'armistizio immediato, disponendo all'esercito di ritirarsi dietro
le linee delle vecchie frontiere.
Alle ore 10 e qualche minuto, a Serravalle il capitano di stato
maggiore Ruggera usciva dalle trincee con una piccola bandiera
bianca (nella foto in
alto). Recava un messaggio del generale Walter Webenau
(datato venti giorni prima…!) che desiderava trattare per un
armistizio immediato.
Il comando italiano rimase interdetto da tanta solerzia e da tanto
ritardo, e cercò di guadagnare tempo. «Sembra che le credenziali
non siano in regola»…
Il 30 ottobre sarà il generale Webenau in persona a recarsi alla
trattativa, in modo che non ci siano più scusanti. Se mancasse
qualcosa, lui era titolato a firmare i documenti necessari. Venne
fatto salire in automobile e accompagnato a pochi chilometri da
Padova, dove sorge Villa Giusti.
Si intrecciò un fitto scambio di comunicazioni tra il Comando di
Parigi dove si trovava il nostro Presidente del Consiglio Orlando,
il quale diede disposizioni affinché venisse stesa un'ipotesi di
armistizio. Diaz incaricò Badoglio alla trattativa, affiancandolo
con un capitano a fargli da interprete. Si chiamava Trenner,
cognato di Cesare Battisti.
Alle presentazioni, il generale Webenau dice «Battisti?
Conosciamo questo nome…».

L'armistizio venne firmato il 3 novembre, destinato però a entrare
in vigore alle ore 15 dell'indomani 4 novembre. In questa maniera
le nostre truppe potevano entrare a Trento e a Trieste, cosa che
fecero senza colpo ferire nella giornata del 3 novembre.
Ma le diplomazie alleate avevano già mosso le loro carte per
impedire che l'Italia «vincesse troppo». Se un mese prima avrebbero
festeggiato a vedere gli Italiani che entravano a Vienna, adesso
volevano ci arrestassimo appena al di là della linea del Piave.
Diaz si rese conto solo a livello istintivo che la sua vittoria
stava per essere mutilata, e decise di far convergere le truppe
vittoriose a Vittorio Veneto. Non ci fu alcuna battaglia a Vittorio
Veneto, lo fu solo nell'anima di Armando Diaz, che volle a tutti i
costi sigillare la sua vittoria nell'immaginario del Paese e,
soprattutto, nel suo.
Certo è che tuttora sui libri di scuola si legge che la Grande
Guerra non finì sul Grappa, come accadde in realtà, ma a Vittorio
Veneto, come non accadde mai.
Alle ore 15.00 del 4 novembre 1918, dopo 3 anni, 5 mesi e 10 giorni
di assurdi combattimenti, finiva la Grande Guerra. L'Italia aveva
vinto la guerra, e perso 600.000 ragazzi.
G.d.M.
Nelle foto,
dall'alto: Sotto il titolo, il particolare delle scritte
Presente! a Redipuglia; l'Ossario del Grappa; il maggiore
Ruggera si presenta per trattare l'armistizio; un cannone italiano
in Piazza Dante a Trento; i cavalleggeri arrivano a Trento. Qui
sotto: il 4 novembre 1918 in Piazza Duomo e in Via Belenzani a
Trento.