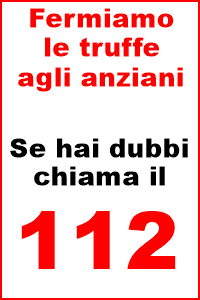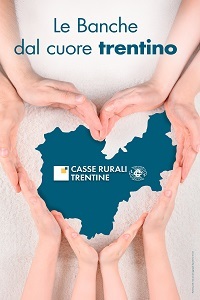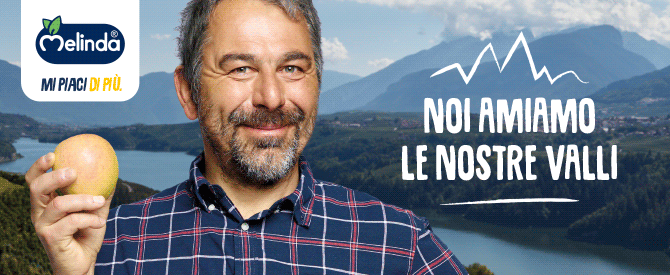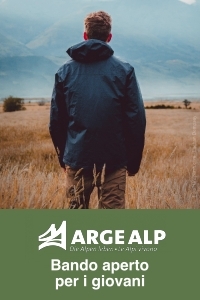Osservazioni del FAI, Fondo Ambiente Italiano
Il Palazzo delle Albere di Trento e il progetto del Planetario

>
In merito al dibattito in corso sulla prospettata realizzazione nel quadrante nord-est del parco del Palazzo delle Albere di Trento, per iniziativa del MUSE, di un planetario a tre sfere in tensostruttura di tessuto plastico, e più in generale riguardo alla destinazione da assegnare al Palazzo stesso, la Delegazione di Trento del FAI, Fondo Ambiente Italiano, desidera proporre alcuni suggerimenti con l’auspicio che questi concorrano a una migliore comprensione della questione e all’adozione di scelte amministrative conseguenti.
Semi-abbandonata per secoli, la villa suburbana cinquecentesca voluta dai Madruzzo in riva all’Adige aveva trovato, nella seconda metà del secolo scorso, degna riqualificazione quale polo cittadino del MART, il Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto, con la specifica vocazione di custodire, raccontare e trasmettere alle generazioni a venire la pittura e la scultura dell’Ottocento e del Primo Novecento trentini.
È questa una grande stagione artistica che ha portato il nome di Trento fuori dai confini nazionali e che ha introdotto nel nostro contesto le novità dell’epoca: Francesco Hayez (veneziano che realizzò su committenza trentina la bellissima Venere che scherza con due colombe), Bartolomeo Bezzi, Luigi Bonazza, Tullio Garbari, Eugenio Prati, Umberto Moggioli, Andrea Malfatti sono i maggiori autori le cui opere di immenso valore, acquisite negli anni, appartengono alla città di Trento per clausola di donazione. Un vero patrimonio di bellezza in cui la città può riconoscersi e che oggi tuttavia è in massima parte lasciato a languire nei depositi.
Dopo la chiusura al pubblico a fine 2010 e in concomitanza con la costruzione, a pochi passi, dell’imponente Museo delle Scienze - il MUSE che sembra quasi soffocarlo con la sua mole - i già incerti destini del Palazzo delle Albere sono stati oggetto di discussione per lo più affidata a frettolose dichiarazioni dei politici, spesso prive di una visione d’insieme e dei necessari approfondimenti.
Anziché pensare a percorsi di promozione e di rilancio, sono emerse ipotesi di utilizzo alternativo del Palazzo che non sempre sono parse all’altezza del suo valore artistico né rispettose di quei principi di preservazione e di fruizione dei beni culturali coerenti al paesaggio che li ospita, principi questi che costituiscono una delle ragioni d’essere e di agire del FAI.
Si è parlato negli anni di trasformare il Palazzo in una specie di «portale del Trentino», cioè in una vetrina più o meno virtuale dedicata alla promozione turistica della nostra Terra (anche dei prodotti enogastronomici), di considerarlo un’anticamera di rappresentanza del MUSE, di ricavarne un «Museo dell’Autonomia» su modello di Castel Tirolo sopra Merano oppure, da ultimo, di farne sede di un singolare «Museo dello sviluppo del pensiero scientifico».
Il FAI ritiene che per capire quale potrebbe essere la destinazione più consona al Palazzo delle Albere non si possa prescindere da una valutazione attenta dell’originaria funzione assegnata a questa splendida villa-fortezza, voluta dal cardinale Cristoforo Madruzzo quale sua residenza fortificata, fuori ma non staccata dalla città cui si congiungeva per il tramite di un suggestivo rettilineo alberato.
Il Palazzo era luogo di rifugio e di riposo dalle fatiche ordinarie del Principe Vescovo, una sorta di «Buonconsiglio estivo» destinato a quell’otium latino tutto volto a ritemprare lo spirito nutrendosi del bello.
Se questa è la genesi del Palazzo, non sono condivisibili alcune considerazioni portate a sostegno dell’installazione «a tre sfere» che occuperebbe buona parte del giardino del Palazzo, prima fra tutte quella dell’asserita irreversibile compromissione del disegno urbanistico originario del Cinquecento e poi lo stato di abbandono in cui versano le «barchesse», i due storici edifici di servizio del Palazzo oggi al di là della linea ferroviaria.
Quanto alla prima questione basta osservare una fotografia aerea per rendersi conto di come resti salvo e pienamente riconoscibile l’asse viario voluto dai Madruzzo che da via Santa Croce conduce alle Albere: l’Arco dei Tre Portoni che anticipa visivamente le due eleganti serliane sormontate, aperte nella facciata della villa. Un rettilineo con una doppia funzione di comodità e passaggio dalla città alla campagna, dal negotium all’otium, dalla calura alla frescura, che merita di essere non certo cancellato ma valorizzato e restituito ai cittadini che già numerosi lo affollano per raggiungere il quartiere progettato da Renzo Piano.
Così facendo quindi - mantenendo cioè libero il prato verde del parco nella sua interezza senza cedere all’horror vacui, a quel terrore del vuoto che si vuole riempire con strutture, orti, installazioni e arredi vari - oltre a preservare un’importante pagina di storia e di identità tridentina si agevolerebbe la fruizione del nuovo quartiere che, a dispetto di tanti e a volte disordinati sforzi, stenta a decollare.

Le barchesse, colpevolmente considerate dei ruderi ingombranti, senza identità, quasi in impaccio, vanno prima capite nella loro originaria funzione di strutture di servizio tipiche delle nobili residenze di campagna e poi recuperate in modo che concorrano a rivalutare l’assetto originario della zona e, a un tempo, gli diano nuovo slancio e nuova vita.
Le barchesse compongono, con la villa e con il parco, una struttura architettonica unitaria di matrice palladiana tipicamente rinascimentale.
Dalle barchesse delle Albere, una volta restaurate, si potrebbero ricavare spazi pubblici per mostre, eventi, convegni oppure locali affidati ai privati perché siano adibiti al commercio.
Senza risvolto economico forse nessuna riqualificazione merita gli sforzi che richiede, ma senza rispetto della storia ogni intervento, oltre a depauperare lo spirito dei luoghi e di chi li abita, è destinato ad avere vita breve, come altri esempi recenti della nostra Trento dimostrano.
Si afferma poi che il progetto del planetario, con le sue sfere istallate in uno dei quadranti del giardino del Palazzo, non altererebbe in alcun modo la fisionomia del luogo.
Oltre a non tenere in conto l’aspetto estetico complessivo, ciò è frutto di un ragionamento che prescinde dalla conoscenza della città.
In un intervento organico di risistemazione e di destinazione del Palazzo, infatti, per le sfere non ci sarebbe collocazione peggiore di quella oggi ipotizzata: i quattro quadranti del giardino del Palazzo, sgombri da installazioni avventizie, dovrebbero dialogare idealmente con i quattro campi di cui ciascun quadrante del nostro pregevole e poco conosciuto Cimitero Monumentale si compone. Un dialogo agevolato, connesso dalle barchesse finalmente ristrutturate.
Se il Palazzo delle Albere tornasse ad ospitare l’arte dell’Ottocento e la Gipsoteca di Andrea Malfatti, come il FAI auspica, perché non pensare a circuiti turistici che dal Palazzo portino, appunto, al Cimitero Monumentale - che del Malfatti ospita moltissime opere - e da qui al centro storico, altro campo di azione privilegiato dallo scultore? Sarebbe un modo intelligente per coniugare turismo di qualità, rispetto dell’identità cittadina e urbana e sostenibilità economica e ambientale.
Oppure perché non partire dal Palazzo delle Albere e dai suoi affreschi interni per diffondere la conoscenza della civitas picta, cioè di quel patrimonio di case e di palazzi affrescati che rende Trento un unicum fra le città dell’arco alpino?
Realizzato dai Madruzzo entro un ameno paesaggio, circondato da alti pioppi (le albere), riccamente affrescato e decorato (fra tutti, da Marcello Fogolino), il Palazzo delle Albere è stato dunque voluto come un contenitore di bellezza aperto al verde e alla ruralità. E questo deve rimanere, a beneficio di tutta la cittadinanza.
Il Palazzo ad avviso del FAI deve tornare ad ospitare principalmente le collezioni di arte visiva moderna non contemporanea possedute dal MART: la Pinacoteca dell’Ottocento e del Primo Novecento e l’allestimento della strepitosa gipsoteca - atelier di Andrea Malfatti.
Alcuni spazi della villa, inoltre, potrebbero essere destinati alla presentazione, anche virtuale e multimediale, dei principali percorsi artistici del Trentino (la dinastia dei Baschenis, la Scuola pittorica di Fiemme, il barocco lagarino, le tracce del sacro) oppure a laboratori dedicati agli artisti nell’ambito di una rete di realtà associative cittadine, una «Casa della Cultura» in dialogo con la contemporaneità.
Il Palazzo delle Albere non può essere invece destinato a mera appendice del MUSE.
A nostro parere questa soluzione, oltre a mortificare esteticamente il Palazzo come sarebbe nel caso della realizzazione del gigantesco planetario lì dove è stato pensato, risponde a quella logica, opportunamente definita monoculturale, di accorpamento per materie delle istituzioni culturali, logica semplificativa di cui sono figlie le varie «città della scienza» e «città d’arte» che, seppur nate per meritevoli scopi, hanno avuto e ancora hanno l’effetto di appiattire (forse per assecondare un certo turismo di massa) la ricchezza e la varietà culturale e gli intrecci fecondi tra arte e scienza, di cui ogni città e borgo d’Italia è testimone.
Il FAI non è in alcun modo contrario alla realizzazione in città di un planetario né, più in generale, alle iniziative del MUSE che è senz’altro uno dei migliori musei scientifici d’Italia e che svolge una meritoria opera divulgativa, con ricadute fondamentali anche dal punto di vista economico.
Più semplicemente ma con estrema convinzione il FAI vuol far notare che scienza e arte possono convivere fianco a fianco e senza sovrapporsi, con due grandi poli espositivi cittadini autonomi e dialettici, nell’ottica di rafforzare e diversificare l’offerta culturale per i flussi turistici e di preservare per il futuro l’identità del tessuto urbano tridentino.
Lasciamo libero il parco del Palazzo delle Albere: altri luoghi più adatti per un planetario, anche nelle immediate vicinanze della sede del MUSE, non mancano.
Basta cercare e volere.