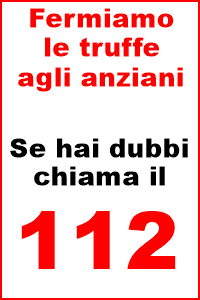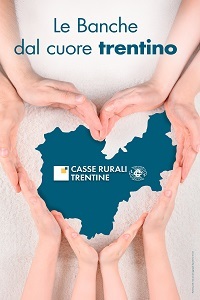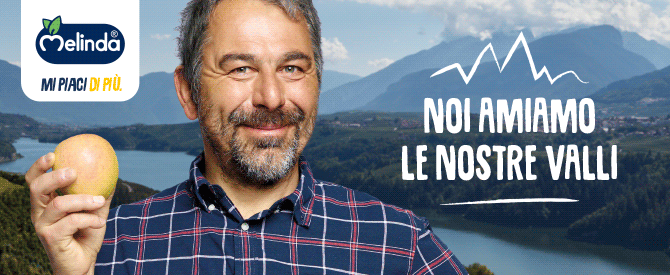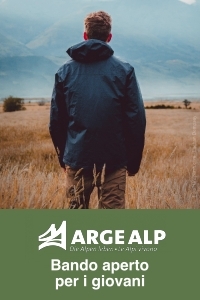L’abito nuovo della Casa della SAT di Trento
Iniziate le opere di restauro della facciata di palazzo Saracini-Cresseri di proprietà SAT

L’8 aprile scorso sono iniziati, con il montaggio dei ponteggi (foto), i lavori di restauro della facciata di Palazzo Saracini-Cresseri di proprietà della Società degli Alpinisti Tridentini.
L’opera di restauro, che ha un costo complessivo di 154.074,78 euro, è finanziata dalla Provincia Autonoma di Trento per il 50% della spesa ammessa.
Inoltre data la valenza dal punto di vista storico, architettonico e urbanistico dell’edificio, per il territorio trentino e la sua comunità, il Fondo Comune delle Casse Rurali Trentine, in rappresentanza di tutte le Casse Rurali della Provincia, ha voluto sostenere il restauro con un importo pari al 30% della parte rimanente dei costi a carico della SAT.
Il progetto, autorizzato dalla Soprintendenza per i Beni Culturali della Provincia, è stato affidato all’architetto Giorgia Gentilini che cura anche la direzione lavori, mentre l’impresa che si è aggiudicata l’appalto per la realizzazione è il Consorzio ARS di Trento.
I lavori proseguiranno per tutta l’estate e si concluderanno il 31 ottobre 2019, con una serie di iniziative di valorizzazione, sia del palazzo, che dell’opera di restauro, le quali culmineranno in una cerimonia di restituzione alla città di uno dei più importanti e frequentati palazzi storici di pregio dell’antica «Via lunga».
È una storia blasonata quella del palazzo che oggi ospita: a piano terra l’ufficio tesseramento e lo Spazio Alpino SAT, al primo piano gli uffici di presidenza, di direzione, la sede della sezione di Trento e della SUSAT, al secondo piano la sala Consiglio, l’Archivio Storico, la Biblioteca della Montagna e all’ultimo piano la sede del Coro della SAT.
Il palazzo è infatti attribuibile al XVI secolo (su preesistenze medievali) e agli interventi di rinnovamento della città in vista del Concilio di Trento voluti dal Principe-Vescovo Bernardo Clesio.
In particolare alla riqualificazione urbana del collegamento tra il Magno Palazzo del Castello del Buonconsiglio e il Duomo, che portò alla sistemazione e all’allargamento delle Contrade Larga (l’odierna via Belenzani) e Lunga (l’attuale via Manci).
La renovatio urbis, voluta da Bernardo Clesio si basava su nuovi caratteri edilizi dal punto di vista delle dimensioni e stile architettonico, il modello adottato era quello del palazzo rinascimentale dove spiccano simmetria, proporzione e decoro.
Il rinnovamento proseguì per i successivi due secoli portando alla successione di palazzi affacciati sulle odierne via Belenzani e via Manci, in sostituzione dei precedenti edifici impostati sul lotto gotico, molti dei quali presentano facciate decorate con affresco, così che venne attribuita alla città la denominazione di «urbs picta».
Inizialmente, nel XVI secolo, il Palazzo fu di proprietà della famiglia Saracini documentata a Trento nel 1286, un casato che vantava un console della città nel 1424 e nel 1431 nella persona del notaio Guglielmo Saraceno, figlio di ser Paolo di Trento.
I Saracini furono una famiglia potente nella scena trentina tanto da ottenere, il 24 giugno 1699, in feudo pignoratizio Castel Belfort a Spormaggiore, di cui ottennero anche il predicato di Belfort nel 1780.
Nel Settecento risulta di proprietà di un'altra famiglia importante del Trentino, i Cresseri, provenienti da Vermiglio in Val di Sole, ma originari del bergamasco, che si stabilirono a Trento nel 1623.
Al palazzo di Trento sono noti per i lavori di ristrutturazione e la creazione del passaggio «androne Cresseria» sul confine con palazzo Trentini.
Nel 1777, nel palazzo, vi morì il duca Guglielmo Enrico di Glocester, fratello di Giorgio III, re d’Inghilterra, a testimonianza rimane all’interno una lapide in pietra.
A metà dell’800 l’edificio passò alla famiglia Pedrotti che lo abitò fino al 1954, anno in cui viene acquistato alla SAT – Società Alpinisti Tridentini.
Nel corso dei secoli l’edificio ha subito diversi interventi di modifica e di restauro.
«Quel che si vede oggi della facciata di palazzo Saracini-Cresseri– illustra l’architetto Giorgia Gentilini – è una riconfigurazione ottocentesca che segue il progetto del 1862 redatto dall’ingegnere Saverio Tamanini. Nel 1922 viene redatto dall’ingegnere Scotoni il progetto per l’inserimento delle vetrine a piano terra. Successivamente, nel 1986 è stato presentato da parte dell’architetto Pietro Marconi un progetto per il restauro del prospetto decorato su via Manci eseguito dalla restauratrice Maria Pia Tamanini, che prevedeva il ripristino degli affreschi e il risanamento conservativo delle parti lapidee della facciata eseguite quest’ultime dall’impresa di restauro RWS di Vigonza (Pd). Oggi dopo 33 anni dall’ultimo intervento è possibile intervenire con tecniche specialistiche mirate – prosegue Gentilini – in particolare dove tutta la superficie pittorica sembra presentare la diffusione di un materiale protettivo che mostra segni evidenti di alterazione cromatica, mentre le superfici lapidee presentano fenomeni di dilavamento, sollevamento, formazione di croste nere per l’intradosso dell’arco dei portali doppi. L’ispessimento sopra gli architravi piani dei portali doppi ha in buona parte perso la sua funzione di far scivolare l’acqua e si presentano oltre che depositi superficiali anche dei licheni.»