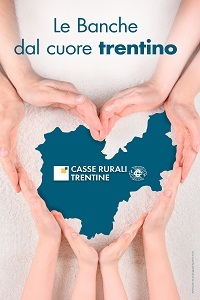Terrorismo e instabilità del Corno d'Africa/ 9 – Di Marco Di Liddo
Nona puntata – Il traffico di armi e di esseri umani
>
Il traffico di armi e di esseri umani
La terza grande criticità di sicurezza che affligge il Corno d’Africa è il traffico di armi e, soprattutto, di esseri umani. Nessuno dei cinque Paesi della regione è immune a questo fenomeno e, in misura differente, ognuno contribuisce alla sua cronicizzazione. Innanzitutto, occorre sottolineare quelle che sono le caratteristiche generali del traffico di persone nell’Africa Orientale.
Dal punto di vista demografico, circa l’80% delle vittime è composto da donne e bambini, utilizzate come manodopera a basso prezzo nelle industrie, nelle campagne, come assistenti domestici in stato di semi-schiavitù o nel mercato della prostituzione.
Una percentuale inferiore, soprattutto per quanto riguarda i minori di sesso maschile, viene reclutata dai movimenti terroristici e di guerriglia, aumentando la piaga dei bambini-soldato.
Per quanto riguarda i luoghi di destinazione, oltre la metà del traffico di esseri umani avviene all’interno dell’Africa orientale, mentre un terzo è diretto verso il Medio Oriente.
I principali punti di destinazione sono lo Yemen, l’Arabia Saudita, il Kuwait, il Qatar e Israele.
Soltanto una percentuale residuale di clandestini si dirige verso il Nord Africa e poi, verso l’Europa. Si stima che, ogni anno, circa 100.000 persone siano coinvolte nel traffico di esseri umani, di cui 35.000 con direzione Medio Oriente ed Europa.
La 42 grande maggioranza degli emigranti è di nazionalità somala ed eritrea. Tuttavia, le recenti crisi in Sud Sudan e Repubblica centrafricana potrebbero costituire un fattore di crescita del flusso di rifugiati e emigranti. Non è da escludere che, nei prossimi mesi, un numero tra le 10.000 e le 15.000 persone possa fuggire verso il Sudan e l’Etiopia, alimentando sia il traffico interno alla regione sia quello diretto verso Medio Oriente ed Europa.
Migliaia di donne e bambini somali ed eritrei raggiungono queste tre destinazioni per poi essere impiegati come braccianti agricoli, sottoproletariato urbano o per alimentare il mercato della prostituzione.
In particolare, la tratta delle donne è molto sviluppata a Gibuti e nel Kenya, dove negli ultimi anni si è consolidato un lucroso business legato al turismo occidentale.
Le limitate capacità di assorbimento dell’immigrazione da parte del sistema economico di questi Paesi agevola il reclutamento dei clandestini da parte delle organizzazioni criminali e dei movimenti terroristici.
Ad esempio, nella regione orientale etiope dell’Ogaden, nei sobborghi di Nairobi e Mombasa e nei grandi campi profughi di tutto il Corno d’Africa i giovani e le donne somale vengono reclutati e rapiti da al-Shabaab e dalle bande di pirati.
Nell’ultimo biennio, il traffico di donne legato al business della prostituzione è divenuto una voce di bilancio importante sia per i pirati sia per i miliziani jihadisti somali, entrambi alle prese con un massiccio ridimensionamento delle rispettive precedenti fonti di finanziamento.
Per quanto riguarda il flusso al di fuori del Corno d’Africa, esistono tre differenti rotte: una per l’Europa e due per il Medio Oriente.
I migranti che vogliono raggiungere i Paesi del Golfo possono farlo sia via mare che via terra.
La rotta marittima, gestita da scafisti yemeniti e somali, molti dei quali appartenenti al network delle bande piratesche, parte da Gibuti o dai porti settentrionali della Somalia e del Puntland e si dirige in Yemen e Arabia Saudita.
La rotta terrestre parte dalla città eritrea di Tesseney, punto di aggregazione per i migranti somali ed eritrei, e prosegue a Wadi Sharifay o Sitau Ashrin, due ex campi profughi in Sudan, dove giungono anche gli emigranti etiopi.
A gestire questa tratta sono i trafficanti Rashaida, un’etnia nomade stanziata lungo il confine tra Sudan ed Eritrea. In molte occasioni, i Rashaida, con la complicità della polizia sudanese, rapiscono i clandestini e chiedono alle famiglie esosi riscatti, che si aggirano intorno ai 40.000 dollari.
In caso di mancato pagamento, gli ostaggi, già torturati durante la detenzione, vengono uccisi, sfruttati per il traffico di organi o costretti alla prostituzione.
Una volta in Sudan, i migranti vengono caricati su camion che, attraverso le rotte desertiche, giungono nel nord del Paese.
A quel punto, i clandestini diretti in Europa virano verso il sud della Libia, dove vengono prelevati dai trafficanti di etnia Toubou e proseguono il viaggio verso le costa.
Al contrario, i clandestini diretti in Medio Oriente entrano illegalmente in Egitto e poi proseguono verso il Sinai.
Il costo del viaggio è di circa 3.000 dollari a persona, una cifra enorme se si considera che nel Corno d’Africa la maggior parte della popolazione vive con poche decine di dollari all’anno. Come se non bastasse, la rotta e i convogli in direzione egiziana vengono utilizzati anche per il traffico di armi.
Infatti, per non far intercettare gli armamenti dai satelliti, questi vengono nascosti sotto i migranti e così riescono ad arrivare nei mercati di destinazione (Nord Africa e Penisola Arabica) bypassando i controlli ai valichi di frontiera.
Il Paese maggiormente colpito dal fenomeno dell’emigrazione clandestina è l’Eritrea, dove, inoltre, il governo svolge una funzione determinate nel controllo e nella gestione del traffico di esseri umani.
Dei circa 941.000 emigrati dagli anni Settanta (pari al 18% della popolazione totale) oltre 25.000 sono partiti negli ultimi tredici anni.
Ad oggi, i rifugiati eritrei sono circa 252.000, di cui quasi 62.000 vivono nei campi profughi in Etiopia, Gibuti e Yemen.
Dal momento che Asmara conduce controlli strettissimi sulle procedure per lasciare il Paese e limita il rilascio di passaporti e visti in uscita, gli eritrei che desiderano emigrare sono costretti a farlo clandestinamente.
Dunque, l’emigrazione è divenuta un lucroso business per il regime del Presidente Afewerki.
Secondo i rapporti del 2012 e del 2013 delle Nazioni Unite su Somalia ed Eritrea, i signori del traffico di esseri umani sono il Generale Teklai Kifle «Manjus», il Colonnello Fitsum Yishak e Kassate Ta’ame Akolom, membro di spicco dei servizi segreti.
Tuttavia, anche quando riescono a stabilirsi all’estero, gli eritrei continuano ad essere oggetto dell’attenzione dal regime.
Il Governo centrale, infatti, impone un prelievo del 2% sui redditi degli emigrati, la cosiddetta «tassa sulla diaspora»: questa, introdotta a partire dal 1995 con la legge n. 67 (Diaspora Income Tax Proclamation), è nata con l’intento di raccogliere fondi per la ricostruzione del Paese in seguito alla guerra con l’Etiopia, ma in realtà è stata utilizzata per finanziare il regime ed i suoi affiliati, senza che l’uso di tale denaro possa essere tracciato.
Il pagamento di questo contributo è necessario per ottenere documenti, visti e qualsiasi altra prestazione da parte dell’Ambasciata e, se non viene pagata, i familiari degli eritrei residenti all’estero sono soggetti a persecuzioni e vessazioni.
Oltre al traffico di esseri umani, anche il contrabbando di armi rappresenta una sensibile problematica per la regione africana orientale.
Anche in questo caso, il regime di Afewerki ha un ruolo fondamentale. Infatti, il trasferimento illegale di armamenti ed equipaggiamento rappresenta una importante voce di bilancio per il governo di Asmara, soprattutto da quando, nel 2009, le Nazioni Unite hanno imposto l’embargo.
Gli uomini che gestirebbero questo traffico sarebbero il generale eritreo Kifle, già leader occulto del business delle emigrazioni clandestine, e due ufficiali dell’Esercito di Asmara, i fratelli Borhame e Yesef Hadegu.
L’embargo totale proibisce la vendita e la fornitura di armi, materiali, parti tecniche, nonché vieta la somministrazione di assistenza nella formazione e nell’addestramento alle Forze Armate Eritree.
Il regime, tuttavia, riesce ad aggirare le sanzioni attraverso l’importazione di sistemi dual-use, che possono essere destinati sia a scopi civili che militari.
Le armi e i sistemi dual-use, provenienti da Cina e Iran, una volta giunti al porto di Massaua, vengono stoccate ad Asha Golgol, a circa 9 km dall’aeroporto internazionale di Asmara. Una volta in Eritrea, i carichi di armi vengono destinati al Sudane e, soprattutto ai miliziani di al-Shabaab.
I traffici di esseri umani e armi dall’Eritrea hanno gravi ripercussioni sulla stabilità e la sicurezza non soltanto del Corno d’Africa, ma anche dell’Unione Europea, della Penisola Arabica e di Israele, per ragioni legate al terrorismo e all’immigrazione clandestina.
Secondo le autorità di Tel Aviv, dei circa 58.000 i richiedenti asilo in Israele dal 2006 al 2012, 32.000 (56,5%) provenivano dall’Eritrea; dal 2009 al 2011 sono arrivati in Israele, attraverso il Sinai, circa 60.000 immigrati clandestini.
Le autorità israeliane compiono arresti arbitrari per effettuare controlli sugli eritrei e dal 2010 hanno avviato la costruzione di nuovi centri di accoglienza per i migranti.
Per arginare il flusso migratorio, in un quadro di sicurezza sensibilmente peggiorato a causa dell’instabilità dell’Egitto e dell’aumento delle violenze in Sinai, Israele ha inoltre deciso di inasprire, dal 2012, le misure di respingimento alla frontiera e di rendere più difficile le procedure per la richiesta di asilo politico.
Anche per l’Arabia Saudita i traffici provenienti dall’Eritrea causano diversi problemi di stabilità e sicurezza e per questo la monarchia ha appoggiato le sanzioni ONU contro il regime di Afewerki. Riyadh, infatti, accoglie numerosi emigrati eritrei, che vengono impiegati per i lavori più umili.
Costretta dalle agitazioni interne a promuovere la nazionalizzazione dei posti di lavoro per diminuire la disoccupazione della popolazione autoctona, Riyadh ha avviato una vasta operazione di rimpatrio di immigrati sprovvisti di permesso di soggiorno nei loro Paesi di origine, soprattutto Eritrea, Etiopia e Sudan.
Anche lo Yemen si trova a fronteggiare una vasta immigrazione, dal momento che ospita circa 250.000 tra eritrei e somali.
Sono numeri che destano preoccupazione se si considera che gli emigranti si trovano spesso senza documenti e senza lavoro e per questo alcuni potrebbero dedicarsi ad attività criminali o, nella peggiore delle ipotesi, costituire un ipotetico bacino di reclutamento per al-Qaeda nella Penisola Arabica (AQAP).
Marco Di Liddo (Ce.S.I)
(9 – Continua)
(Precedenti)
Foto: Wikipedia.