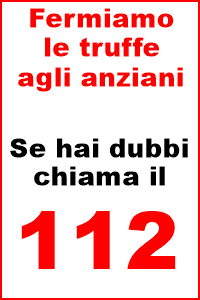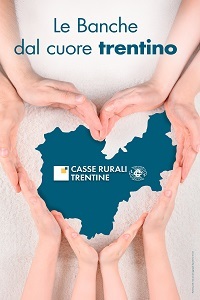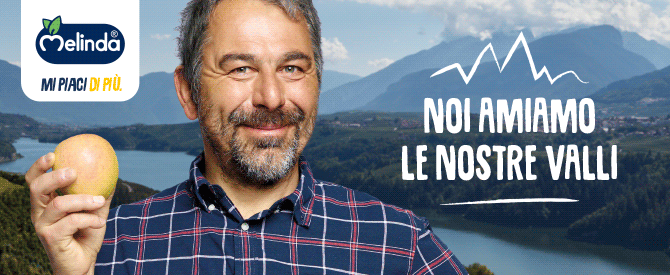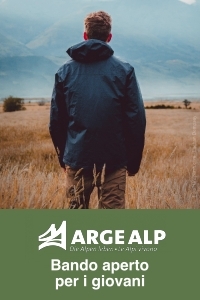Mercoledì 24 gennaio «L’autodeterminazione di Woodrow Wilson»
L’incontro-dibattito è organizzato dalla Biblioteca Archivio del CSSEO con la Biblioteca comunale di Trento – Intervengono Roberto Toniatti e Davide Zaffi
| La Biblioteca Archivio del CSSEO in collaborazione con la Biblioteca comunale, organizza a Trento, mercoledì 24 gennaio 2018, alle ore 17.30, nella «Sala degli Affreschi» della Biblioteca comunale (Via Roma 55), l’incontro-dibattito «L’autodeterminazione di Woodrow Wilson». Intervengono Roberto Toniatti e Davide Zaffi. Introduce Fernando Orlandi. |
Lo scorso 8 dicembre alla commemorazione degli Schützen a San Paolo di Appiano, per il 53esimo anniversario della morte del terrorista Sepp Kerschbaumer, è stato dato particolare rilievo al principio di autodeterminazione.
Dopo la messa, al cimitero il giornalista tedesco Reinhard Olt lo ha rivendicato, il sostenendo che l’attuale autonomia del Trentino-Alto Adige è da considerarsi una soluzione provvisoria.
Il principio di autodeterminazione (di nazionalità) è legato al presidente americano Woodrow Wilson; ai “14 principi” enunciati solennemente giusto cento anni fa, l’8 gennaio 1918, al Senato americano.
Wilson, in carica dal 1912 al 1920, alla pari di Lincoln, era dotato di una ispirata retorica e come Lincoln si profilò come l’annunciatore di ideali nei quali era impossibile non riconoscersi.
Pochi presidenti americani, forse nessuno dopo Lincoln, ha più profondamente inciso sul ruolo e sull’immagine della massima funzione pubblica del proprio Paese quanto il democratico Wilson.
La non comune energia del presidente Wilson si traeva dalla sua profonda religiosità che, in maniera tipica per il cristianesimo protestante, gli faceva intravedere pochi, se non pochissimi, principi fondamentali e ad un tempo la possibilità di costruire attorno a quelli l’intero rapporto col mondo.
Wilson non aveva teorie da offrire ma attitudini da condividere.
Così la sua immagine dell’uomo come essere moralmente autonomo sottostava alla sua immagine del cittadino consapevole, il quale partecipa su base democratica alle scelte piccole e grandi del suo Paese (al riguardo coniò la felice formula della democracy through debate) e, per una rigida consequenzialità di principio, all’immagine di un ordine internazionale costituito da popoli autodeterminati.
Nessuna di queste immagini conteneva indicazioni su cosa andasse concretamente scelto, ma stabiliva senza possibilità di scarto i criteri della scelta.
Se si rivelava portatrice di conseguenze in armonia con i criteri adottati, la scelta era valida, in caso contrario, andava rivista.
Eletto in maniera rocambolesca nel 1912, Wilson si occupò durante il suo primo mandato esclusivamente della politica interna statunitense.
Durante il secondo mandato, inaugurato nel 1916, manifestò l’ambizione di porre le fondamenta per un ordine mondiale capace di garantire la pace perpetua.
Prima dichiarò guerra alla Germania, poi partecipò in prima persona ai negoziati per i Trattati di pace.
Qui Wilson manifestò, sul piano politico, la dimensione totalizzante del suo credo.
Nei numerosi discorsi che Wilson, letteralmente infaticabile, tenne nel biennio 1918-1919 il mondo intero ascoltò una parola laica e mondana di redenzione. L’autodeterminazione ne era ad un tempo il mezzo e la realizzazione.
Prima di entrare in guerra, Wilson aveva coltivato l’ambizione di dimostrare l’influenza globale degli Stati Uniti, dapprima cercando ripetutamente di esercitare un ruolo di mediatore.
Ma i futuri alleati non volevano un mediatore: volevano le truppe americane al loro fianco, per uscire dallo stallo della Grande guerra.
Nella primavera del 1917, dopo l’abdicazione dello zar Nicola II, Wilson offrì tramite il suo ambasciatore David Francis, alla Russia un ingente credito affinché restasse belligerante. Wilson era consapevole che la Russia non avesse nulla da guadagnare da quanto accadeva sul fronte occidentale, sua unica preoccupazione.
Severo il giudizio di George Kennan, uno degli architetti della politica estera statunitense del secondo dopoguerra: «Ci si può chiedere se il governo degli Stati Uniti, in compagnia di altri Alleati occidentali, insistendo sul proseguimento dello sforzo bellico da parte della Russia e facendo di questa domanda il criterio per il suo sostegno, in realtà non ha accelerato e facilitato il fallimento del Governo Provvisorio.
«Nel chiedere simultaneamente ai capi del Governo Provvisorio di consolidare il loro potere politico e far rivivere e continuare la partecipazione alla guerra, gli Alleati stavano chiedendo l'impossibile.»
Nei Trattati di pace il principio di autodeterminazione (di nazionalità) fu applicato in modo discontinuo e arbitrario, contribuendo non poco alla graduale destabilizzazione e al definitivo sovvertimento dell’ordine di Versailles.
Ad esempio, quasi tutta la Posnania e la Prussia occidentale, il territorio di Memel e l’Alsazia-Lorena furono staccate dalla Germania senza interpellare le rispettive popolazioni, spesso in maggioranza germanofone.
I Sudeti passarono alla Cecoslovacchia insieme alla maggioranza ungherese del sud della Slovacchia: dalla distruzione del multinazionale Impero austro-ungarico se ne creava uno in miniatura.
Insomma, un bilancio non propriamente positivo e una serie di decisioni che si dimostrarono tragiche negli anni a venire.
Resta il principio di autodeterminazione, che nel corso del Novecento ha conosciuto diversi sviluppi. Ma che ancora oggi deve trovare una definizione compiuta e codificata.
Ad esempio il soggetto titolare del diritto all'autodeterminazione è il popolo come soggetto distinto dallo Stato.
Ma in nessuna norma giuridica internazionale c'è la definizione di popolo.
Questa ambiguità irrisolta non è casuale, gli Stati non sono disposti a riconoscere ai popoli una propria soggettività giuridica internazionale.
Di questi temi e di queste vicende ne discutono Roberto Toniatti e Davide Zaffi nell’incontro-dibattito «L’autodeterminazione di Woodrow Wilson», organizzato dalla Biblioteca Archivio del CSSEO, che si terrà a Trento mercoledì 24 gennaio 2018, alle ore 17,30, nella “Sala degli Affreschi” della Biblioteca comunale (Via Roma 55).