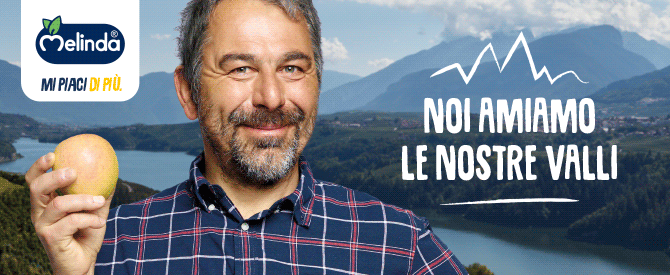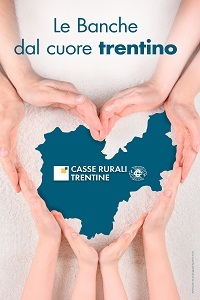Dopo 40 anni, stretta di mano tra le vedove di Pinelli e Calabresi
Grande commozione per l'incontro al Quirinale nel «Giorno della memoria» per ricordare le vittime del terrorismo. - Scritta una pagina di storia
La stretta di mano tra le vedove di
Pinelli e Calabresi non ha solo commosso il Presidente della
repubblica Giorgio Napolitano, ma anche la maggior parte di coloro
che 40 anni fa erano dei ragazzi.
Chi non c'era forse fa fatica a comprendere il clima che si era
creato in quegli anni che, lo ricordiamo, divennero «di piombo»
solo nei successivi anni '70, frutto di un '68 che aveva solo
esasperato gli animi e non certamente sopito la voglia che i
ragazzi avevano di rompere con il passato sanguinoso della prima
metà del '900.
La guerra era finita da più di vent'anni, ma l'inizio della
democrazia sembrava rappresentata solo da un semplice allentamento
delle morse del potere, perché le tradizioni religiose, culturali e
morali tenevano ben saldo un modo di vita che era rimasto intatto
da ben prima del ventennio e che non apparteneva più alle nuove
generazioni.
Il '68 lo ha fatto tutta la nostra generazione, tutti i ragazzi di
allora, indipendentemente dalla fede politica che potevano nutrire.
Col passare degli anni, le sinistre si appropriarono della
paternità della nostra rivoluzione generazionale, ma in
realtà la volevamo tutti. Eravamo «solo» dei ragazzi che volevano
tagliare con il passato, che volevano cambiare tutto. E subito.
L'incredibile era che le generazioni che ci avevano preceduti
volevano invece tener duro per salvare qualcosa che, risultati alla
mano, non valeva assolutamente essere conservato ma, al contrario,
citato come esempio da non seguire. Predicavano il valore della
famiglia, della patria, della fede. Tutti valori indiscutibili, ma
che venivano impiegati sostanzialmente per farci fare quello che
non volevamo.
Tutti noi, nati nel dopoguerra, avevamo il destino prestabilito dai
nostri genitori fin da quando eravamo nati. Cultura e lavoro
sarebbero stati per sempre quelli della famiglia in cui si nasceva.
Dovevamo vestire sobri, portare giacca e cravatta fin dalle scuole
medie, anche coi pantaloni corti. Dovevamo dimostrare quel timore
di Dio che gli stessi genitori avevano sempre avuto, estrema
garanzia per mantenere lo status quo. Dovevamo ubbidire ciecamente
allo Stato per la semplice ragione che era lo Stato a volerlo.
Dovevamo trovare un lavoro dipendente e conservarlo per
tutta la vita. Tornare a casa con la monotonia ritmica del pendolo
di Foucault. Sposarci, fare figli, insegnare a loro quegli stessi
valori, invecchiare, morire e andare in paradiso. O almeno in
Purgatorio.
Come si può immaginare non era permesso tenere i capelli lunghi
come i Beatles (che, a ben guardare con l'occhio di oggi, proprio
lunghi non erano…), perché erano espressione della ribellione e le
cui canzoni non venivano assolutamente messe in onda dalla Rai. I
Beatles venivano dall'Inghilterra, paese che aveva vinto la guerra
e perso la pace. Da lì era partita la protesta semplicemente perché
non era stata impedita. Poi si dilatà con la forza di uno tsunami,
perché il sentire era comune di tutta la nuova generazione del
Mondo Occidentale e le vie di comunicazione giovanili, per quanto
primitive, erano ormai inarrestabili.
L'unica libertà nasceva dal matrimonio. Trovare un lavoro e
lasciare casa significata uscire dallo schema e trovare la vita, il
contrario di oggi, dove i bamboccioni stanno benone a
casa, sostanzialmente perché la libertà in casa la trovano.
Allora la morale apparente doveva essere rispettata nella maniera
più assoluta. L'ipocrisia dei bordelli, per cui i maschi potevano
scopare mentre le donne dovevano restare caste, con la Beat
Generation scomparve. Se 40 anni fa la figlia tornava a casa
incinta, per la famiglia era una tragedia. Oggi, se la figlia torna
a casa aspettando un bimbo, si fa festa…
Ma la cosa che più ci dava fastidio stava nel fatto che la
democrazia, alla barba della Costituzione più bella del mondo, non
esisteva. La volontà della maggioranza veniva regolarmente
disattesa, come se tra popolo e governanti ci fosse una sorta di
impenetrabile filtro…
Ci viene da ridere oggi a scoprire che i giovani non sentono di
condividere il pensiero della maggioranza, quando ai nostri tempi
la gente non riusciva a esprimere la maggioranza che voleva.
Comunque sia, avevamo pochi elementi con cui protestare. Alle
scuole superiori avevamo scoperto le prime forme di sciopero con
l'assassinio di Kennedy, per il quale nessuna autorità si era
sentita di prendere provvedimenti. Da allora scoprimmo molte
ragioni per fare scioperi, da quelle più banali come l'aumento
della benzina (quando eravamo pochissimi ad avere la patente e
nessuno con l'auto), agli esperimenti atomici degli USA, dell'URSS
e della Francia.
Ma con l'università, fondata a Trento nel 1962 e maturata
nel 1966, le cose cambiarono. Avevamo ormai 20 anni e cominciavamo
a sapere cosa volevamo. Al diavolo tutto e tutti, la vita era
nostra e ce la saremmo gestita noi. La protesta si fece
generalizzata, senza confini di cultura, di classe e di fede, e in
breve ci si trovò in piazza ogni secondo momento per qualsiasi
buona ragione. In certe occasioni alcuni tiravano cubetti di
porfido, altri si limitavano a osservare dall'esterno l'evolversi
dei fatti, qualcuno scriveva gli slogan che altri portavano a
spasso con gli striscioni o esponevano con i tazebao. Qualcuno le
pensava, altri le facevano. Qualcuno studiava e a volte studiava
anche per altri…
Qualcuno invocava la rivoluzione di Marx, Mao e Marcuse, altri
volevano solo cambiare le cose. Qualcuno combatteva la sua
rivoluzione con le parole. Ricordo uno studente cattolico (poi
divenuto parlamentare) che ascoltava attentamente le prediche del
parroco del Duomo. Una volta il prete parlò dei soliti «cristiani
assassinati dal regime sovietico» e il ragazzo balzò in piedi e si
portò dal predicatore: «Ma cosa dici, disgraziato! -
gridò, indicando i fedeli. - Questa gente ti crede!»
Ovviamente lo scandalo fece l'effetto di una bomba, perché nessuno
prima di allora avrebbe mai osato mettere in discussione la parola
del parroco. Cambiarono tante cose da allora...
Era scoppiata la rivoluzione ed eravamo certi di cambiare tutto,
anche se non sapevamo nella maniera più assoluta dove volevamo
andare.
Di sicuro c'era solo il fatto che le cose sarebbero cambiate.
La polizia e i carabinieri (ben lontani dalla grande riforma che lo
stesso capo della polizia di allora Coronas aveva avviato per
avvicinarli al popolo) caricavano indiscriminatamente tutto e
tutti. Colpevoli e innocenti, facinorosi e secchioni, rivoluzionari
e democratici, credenti e miscredenti. Ma non eravamo soli, in
tutta l'Europa la lotta si era fatta dura ed era divenuta cruciale,
perché era in quel momento che si voleva scrivere la fine del mondo
che aveva generato le due guerre mondiali.
In mezzo a tutto questo accaddero dei fatti gravissimi, che ci
inseguirono e perseguitarono per decenni. Il 12 dicembre del 1969
accadde la strage di Piazza Fontana. Un attentato che lasciò tutti
inebetiti. Non c'era nessuna ragione affinché una parte o l'altra
dello Stato fosse giunta a ordire un delitto così odioso e senza
logica. Nulla c'entrava con la nostra protesta, ma soprattutto
mancava il «cui prodest», cioè a chi giovava un attentato contro
inermi cittadini.
La polizia fece subito una retata di anarchici, al solito i primi
sospettati. Tra questi c'era Giuseppe Pinelli, nato a Milano il 21
ottobre 1928 (20 anni prima dei ragazzi del '68…). Era un
ferroviere che aveva militato anche nella Resistenza, come
staffetta nelle Brigate Bruzzi Malatesta. Nel mese di novembre del
1966, già militante anarchico, diede appoggio a ragazzi del giro
dei cosiddetti «capelloni» per stampare le prime copie della
rivista Mondo Beat nella sezione anarchica «Sacco e
Vanzetti» di via Murilio.
Pinelli morì il 15 dicembre 1969 (tre giorni dopo l'attentato di
Piazza Fontana) precipitando da una finestra della questura di
Milano, dov'era trattenuto per accertamenti in quanto sospettato di
qualche responsabilità.
Le circostanze della sua morte, ufficialmente attribuita a un
malore, hanno destato profondi sospetti a causa di alcune
coincidenze legate ai momenti del tutto eccezionali vissuti nel
capoluogo lombardo a seguito della strage. Una parte dell'opinione
pubblica avanzò il sospetto che Pinelli fosse stato assassinato e
che le indagini fossero state condotte con metodi poco ortodossi.
Tuttavia, l'inchiesta conclusa nel 1975 dal giudice istruttore
Gerardo D'Ambrosio, ha escluso l'ipotesi dell'omicidio,
giudicandola «assolutamente inconsistente».
Se l'opinione pubblica aveva «avanzato dei sospetti», noi del '68
non avevamo dubbi. E l'arresto «sine-die» dell'altro anarchico
Valpreda ci convinse che i due avevano subito la stessa sorte
riservata in America agli anarchici italiani Sacco e Vanzetti nel
1927.
Intonavamo a Pinelli la cantilena popolare a suo tempo dedicata
alla strage del Generale Bava Beccaris. «Ma che caldo, che
caldo faceva… tu Lograno apri un po' la
finestra… una spinta… e Pinelli va giù».
La polemica politica si intrise di vibrante animosità, tanto da
parte di coloro che sostenevano la tesi dell'omicidio, quanto da
parte delle autorità, e fu impossibile isolare la polemica
riguardante questo caso dal Terrorismo in genere dalla cosiddetta
Teoria della strategia della tensione, dal cosiddetto
stragismo di stato alla repressione dei circoli anarchici
italiani, all'assassinio del commissario Calabresi.
E qui ci allacciamo al tema in questione.
Dobbiamo confessare che allora tutti i giovani avrebbero
virtualmente ucciso Calabresi, che era l'immagine di
quello Stato che volevano cambiare e che lui invece difendeva a
tutti i costi, anche a costo della vita. Della vita che poi ha
dato, da eroe. La propaganda e la cultura di sinistra erano
riuscite a convincerci che le cose erano andate in quella
maniera.
Il tempo è passato, gli indagati sono cambiati, tutti i processi
sono andati in fumo.
I cosiddetti «anni di piombo», uniti al cambiamento graduale ma
inarrestabile dello Stato, ci convinsero a prendere le distanze da
tutto ciò che non apparteneva alla normale evoluzione democratica
del nostro Paese.
Si arrivò alla fine degli anni '80, quando noi del '68 eravamo
entrati nel tessuto della nostra società. Allora riuscimmo davvero
a cambiare tutto il sistema dall'interno. Un esempio per tutti: in
una notte cadde il Muro di Berlino.
Il passato era da dimenticare e il futuro era nelle nostre
mani.
Ma il passato, quello reale, non se ne va mai del tutto.
Quanto vennero catturati i responsabili dell'omicidio Calabresi, ci
accorgemmo che non era stato un sogno, o peggio un incubo, quello
da cui ci eravamo liberati. Calabresi era stato ucciso davvero e i
suoi assassini avevano preso corpo.
Allora ci accorgemmo che la realtà di allora era stata dura e
indelebile.
Tutti ci sentimmo in colpa per quell'omicidio che avevamo
irresponsabilmente sostenuto in qualche modo con l'appoggio morale,
o meglio immorale. Forse tutto il Paese avrebbe dovuto consegnarsi
per concorso morale? No, perché in realtà eravamo stati noi quelli
raggirati. Era quel terribile clima culturale che ci aveva fatto
sostenere cose che non potevamo neanche valutare.
Quel senso di colpa che ultimamente provavamo sia nei confronti
della famiglia Calabresi che della famiglia Pinelli continuava a
rodere le basi del nostro orgoglio di aver fatto il
Sessantotto.
Per questo, quando abbiamo visto il Presidente della Repubblica
mettere insieme le due vedove Pinelli e Calabresi, abbiamo avuto un
senso di profonda commozione, forse più intenso di quello
dimostrato dallo stesso Giorgio Napolitano, quando si sono
incontrate per la prima volta dopo quarant'anni Licia Rognini,
vedova di Giuseppe Pinelli e Gemma Capra, vedova del commissario
Calabresi: «Finalmente, dopo 40 anni, possiamo stringerci la mano e
guardarci negli occhi. Finalmente due famiglie si ritrovano».
Gemma Capra, vedova del commissario Calabresi, si china sorridente
verso Licia Rognini, vedova di Giuseppe Pinelli, pochi istanti
prima che inizino le celebrazioni del «Giorno della memoria» per
ricordare le vittime del terrorismo.
Licia Pinelli non si alza, vista l'avanzata età, ma ricambia il
sorriso e risponde: «Fingiamo che non siano passati tutti questi
anni».
Il Presidente, che rappresenta ognuno di noi Italiani, è riuscito a
fare quello che ognuno di noi, Italiani del Sessantotto, avrebbe
dovuto fare nel quarantesimo anniversario del nostro «sostegno
immorale».
Lui ci è riuscito e per questo gli dobbiamo grande riconoscenza,
perché ha chiuso una brutta pagina della nostra storia.