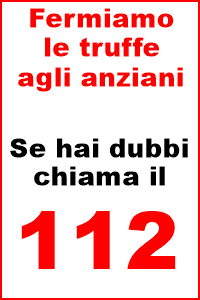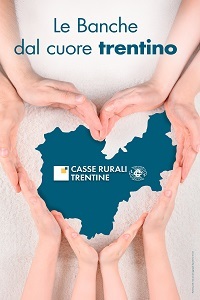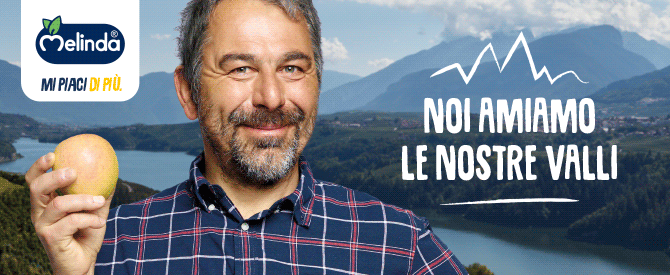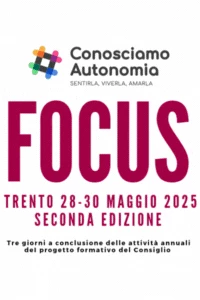Al Festival dell’Economia il convegno organizzato da FEM
Bioeconomia circolare, come chiave di competitività e resilienza nel nuovo scenario globale

>
Il Trentino è un esempio virtuoso di bioeconomia circolare grazie alla sinergia tra enti come la FEM, in prima linea nella promozione di progetti di ricerca e sviluppo, e numerosi consorzi e realtà che operano nel mondo agricolo, agroalimentare e agroindustriale, che hanno scommesso sulla circolarità dei processi produttivi, e in particolare, nel recupero e nella valorizzazione degli scarti di trasformazione e lavorazione.
Occorre però migliorare le interazioni tra le filiere produttive, individuare soluzioni trasferibili anche alle piccole aziende di montagna, valorizzare localmente le biorisorse facendo incontrare domanda e offerta. Inoltre, è necessario investire in formazione per far conoscere le potenzialità di questo nuovo modello di sviluppo, dal quale non è possibile prescindere se si punta ad una transizione verde.
La bioeconomia circolare come chiave di competitività e resilienza nel nuovo scenario globale è il tema al centro dell’incontro organizzato da FEM che si è svolto, oggi, alla Fondazione Caritro nell’ambito del Festival dell’Economia di Trento.
Con la moderazione di Antonio Larizza, giornalista de Il Sole 24 Ore, sono intervenuti Mario Bonaccorso, direttore del Cluster italiano della bioeconomia circolare SPRING, Diana Lenzi presidente della Farming for Future Foundation, Raffaele Farella, dirigente del Ministero dell'Economia e delle Finanze e Silvia Silvestri, ricercatrice responsabile dell’Unità di Bioeconomia della Fondazione Edmund Mach.
Mario Bonaccorso ha definito la bioeconomia un’economia che usa le risorse biologiche rinnovabili come materia prima per la produzione industriale, energetica, alimentare e mangimistica. Nella sua declinazione circolare impiega scarti, residui e sottoprodotti, legandosi strettamente alle aree locali.
«Paradigma economico e sociale, leva fondamentale per mitigare il cambiamento climatico, resiliente» perché consente di affrancarsi dall’importazione di fonti fossili dall’estero assumendo perciò un chiaro valore geopolitico. In Italia il valore della produzione della bioeconomia era nel 2023 di 437,5 miliardi di euro, con 2 milioni di occupati (fonte Rapporto sulla Bioeconomia 2024 di Intesa Sanpaolo). «Oggi investire in bioeconomia -ha evidenziato Bonaccorso- significa per le imprese investire in innovazione e accrescere la propria competitività, ma per supportare questo settore occorre un quadro regolatorio stabile e coerente».
Diana Lanzi ha evidenziato gli obiettivi della Fondazione Farming for Future e le dieci azioni promosse per un’agricoltura circolare, sostenibile e moderna, ma al tempo stesso ha identificato una grande criticità: il livello di investimenti a cui deve far fronte un’azienda per mettere in piedi un modello di questo tipo.
In questo contesto, ha affermato Raffaele Farella, la bioeconomia circolare non sembra costituire ancora un ambito di policy del tutto riconosciuto e riconoscibile, ma i suoi diversi ambiti applicativi sono incorporati trasversalmente all’interno dei variegati e numerosi programmi e incentivi a sostegno allo sviluppo sostenibile.
«Il quadro logico e di policy nel quale muovono però questi interventi risulta ancora frammentario e non vede al momento la dimensione economica e di mercato della bioeconomia adeguatamente valorizzata e riconosciuta».
Silvia Silvestri ha evidenziato che la FEM sta lavorando alla definizione di un «modello» di bioeconomia circolare su scala locale, che prevede oltre alla produzione di energia rinnovabile, il recupero di sostanza organica e di carbonio per il mantenimento della fertilità dei suoli, la riduzione dell’uso di fertilizzanti di sintesi, all’interno di un quadro territoriale ambientale fatto di ecosistemi, biodiversità e di paesaggi che devono essere monitorati, tutelati e valorizzati.
«Tutto questo - ha sottolineato - grazie alla mappatura delle aziende del settore primario e della trasformazione, alla quantificazione e caratterizzazione delle biomasse residuali, alla determinazione delle potenzialità energetiche delle principali matrici, alla stima della quantità di nutrienti quali azoto e fosforo che possono essere recuperati e contribuire così alla riduzione dell’impatto ambientale, alla tutela della qualità del suolo e dell’acqua».