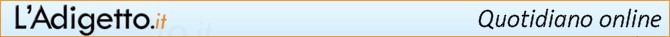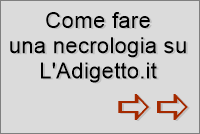Alice Viaggiatrice, Capitolo 5 – Racconto di Astrid Panizza
Alice nel paese dei colori: dopo l’esperienza traumatica con Asia, vola nella terra verde e gialla del Brasile, dove i bambini non smettono mai di sognare e di ridere

>
Link alla puntata precedente.
Capitolo 5: Alice nel Paese dei colori
Henrique corre veloce sulla strada sabbiosa che divide casa sua dalla scuola. Saluta la mamma con un urlo da lontano, sventolando in aria la mano, nell’altra invece una cartelletta gialla e verde, i colori del Brasile.
Dentro ci sono due quaderni sgualciti e una penna, persa tra i fogli chissà dove.
I suoi due piedini scuri si muovono senza paura sul terreno, abituati a stare liberi senza la costrizione delle scarpe.
Appena girato l’angolo eccola là, la scuola, un edificio bianco e di media grandezza che si riconosce subito tra le baracche di cartone e lamiera che la circondano.
Quello è il mio primo giorno di volontariato in Brasile, nella città di San Paolo, spesso erroneamente scambiata dagli stranieri per la capitale, che invece è Brasilia e si trova a migliaia di chilometri più a Nord.
Grazie al corso fatto in Università su lingua e cultura portoghese, sono riuscita a partecipare, e a vincere, un bando di concorso per poter sfruttare la possibilità di svolgere un tirocinio all’estero, in un Paese di lingua portoghese.
Ho scelto il Brasile perché mi sono sempre sentita legata a quella terra colorata, che ospita migliaia e migliaia di emigrati europei che hanno trovato in essa una patria calorosa e amorevole.
Avevo bisogno di fare un viaggio per allontanarmi dalla realtà in cui mi ero persa con Asia e quindi, appena mi fui ripresa dal brutto momento, mi misi a compilare scartoffie e a fare le valigie per affrontare un’avventura in un Paese del terzo mondo, scelta che mi sembrava più giusta per me in quel momento, per ritrovare un equilibrio interiore che forse non avevo mai avuto.
Sono stata accettata in una scuola per bambini poveri e di strada della favela più grande di San Paolo, Heliopolis, in italiano «Città del sole», nome forse non troppo adatto che richiama alla prosperità, mentre invece la prosperità qui è inversamente proporzionale alla presenza di cani randagi per le strade.
Alle otto di mattina di un caldo 7 marzo, mi trovo in piedi sulla porta della scuola «Santa Mãe dos peregrinos», letteralmente «Santa Madre dei pellegrini», pronta a parlare con la direttrice della scuola, con cui avevo avuto un precedente scambio di mail, per chiederle quali sarebbero stati i miei compiti durante i 3 mesi che avrei trascorso lì.
Ma a quell’ora trovo tutti, tranne la direttrice.
Un bambino con la pelle scura e gli occhi grandi e neri mi sfreccia accanto, si ferma e torna indietro.
«Allora sei tu quella nuova maestra che arriva oggi», – mi apostrofa con tono canzonatorio e in un portoghese veloce e a me quasi incomprensibile.
Mi ci vuole qualche frazione di secondo per decifrare il messaggio, ma rispondo che sì, sono io e che se non avesse fatto il suo dovere di bravo studente non gli avrei mostrato i miei trucchi di magia, che nascondevo nel mio zaino.
Lui ride e si mette una mano davanti alla bocca.
«No, non ci credo, i maghi hanno il cilindro e ci tirano fuori un coniglio! Io non vedo nulla di più grande di un quaderno, nel tuo zaino. Altrimenti potrei essere un mago pure io, – dice alzando in alto la sua cartelletta gialla e verde. – Ciao io sono Henrique.»
Mi saluta e sfreccia dentro la scuola, veloce come l’avevo visto arrivare.
Lo seguo lentamente, quasi senza speranza di trovare la direttrice. L’arrivo in Brasile è stato traumatico perché da subito ho visto una povertà ai livelli estremi che mai avrei pensato.
Dentro di me continuo a ripetermi che forse facevo meglio a starmene a casa, e più mi addentro per i meandri della scuola, più mi convinco che arrivare in Brasile non è stata affatto la scelta adatta.
Trovo la direttrice che cammina in corridoio, una piccola donna sulla quarantina, paffuta ma con un viso molto simpatico.
Mi viene incontro un po’trafelata: «Allora Alice, bene bene sono contenta di conoscerti, ma che bella ragazza che sei! Mi fa un immenso piacere che tu rimanga per un po’nella nostra scuola a darci una mano.»
Il suo saluto è veloce e sbrigativo e senza tanti convenevoli passa ad elencarmi le situazioni dei bambini difficili, praticamente tutti, che avrei trovato nella classe in cui avrei insegnato.
«C’è Ramon che non ha i genitori e vive con i fratelli sulla strada, poi Lucia che anche non ha i genitori ma l’hanno presa in carico gli zii e quindi almeno ha un tetto sopra la testa, Felipe invece ha appena perso il fratello, – si mette un dito davanti alla bocca. – Quindi per favore non parlare di fratelli con lui che appena solo si sfiora l’argomento impazzisce.»
Se stessi leggendo un libro, o guardassi un film, questo sarebbe il momento in cui il protagonista si mette le mani nei capelli e scappa a gambe levate.
Invece io rimango, non perché sia felice di affrontare la situazione o perché l’istinto da crocerossina mi abbia conquistato, affatto, semplicemente perché questo è il mio tirocinio e senza l’attestato di frequenza posso dire “sayonara” alla mia Laurea.
Seguo la direttrice lungo i corridoi bui e senza fine della scuola, come persa in un labirinto da cui non potrò mai uscire.
Arriviamo di fronte ad una porta di legno chiaro, vecchia e di un materiale scadente, carta velina praticamente, con tanti buchi che fanno penetrare la luce del sole che si trova nella stanza.
La direttrice si appresta ad aprire la porta ed io respiro profondamente sperando che non si senta che invece di prendere solo ossigeno, vorrei gonfiarmi come una mongolfiera e volare via.
La luce nella stanza è talmente forte che per un attimo strizzo gli occhi, non abituata a tutto quel bagliore.
Quando finalmente li riapro, per prima cosa mi colpiscono i mille colori della stanza, non solo i cartelloni appesi, ma proprio le pareti, colorate probabilmente dagli studenti, in cui intravedo infantili tentativi di dipingere una casa e un’altalena, un cane e un casco di banane.
I bambini sono seduti sulle loro sedie, la maggior parte a cavalcioni o con una gamba sotto il sedere, altri praticamente sdraiati sul banco, curiosi di vedere questa nuova maestra.
Fortuna vuole che non debba occuparmi da sola di tutta la classe, 36 bambini tra i 7 e i 9 anni, ma ci sia una maestra che li segue da qualche anno, conosce bene la vita di ogni bambino e soprattutto, parla portoghese madrelingua, mentre io invece mi barcameno facendo attenzione ad ogni singola parola per non perdere il filo del discorso.
Il primo bambino che si alza e mi viene incontro è Henrique, il morettino che avevo incontrato all’entrata, seguito da una decina tra maschi e femmine, che tra uno spintone e l’altro cercano di toccarmi per vedere se sono vera sul serio.
La direttrice chiude la porta dietro di sé e la maestra, Cleusa, cerca di riportare l’ordine in classe, con scarso successo.
Decidiamo allora che per un po’lasciamo che i bambini mi conoscano meglio e mi chiedano qualsiasi cosa vogliano sapere sulla mia vita in Italia.
Una delle prime domande che mi fa una bambina dalla pelle chiara e i boccoli biondi che le incorniciano il viso (tipologia di persona che mai avrei creduto possibile incontrare in Brasile e invece ce ne sono davvero tanti), è se io viva in una casa vera, come la scuola, grande, con i muri e con il tetto.
Avvicinandosi sorridente alla finestra mi indica un punto indefinito sulla collina piena di baracche dicendo orgogliosa «Perché sai, qui tutti viviamo in baracche di legno, la mia è quella lassù, con la bandiera.»
Mi sento in quel momento come se tutta la mia vita fosse presa e gettata al vento, le lacrime comincino ad annebbiarmi gli occhi ma cerco di trattenere l’emozione per non piangere davanti ai bambini.
Tutto quello che avevo sempre dato per scontato, i vestiti, il cellulare, Internet, e addirittura il cibo e la casa, per loro è invece un sogno, un’utopia probabilmente, perché chi nasce in una favela, difficilmente riesce ad uscirne.
Quel primo giorno è stato solo l’inizio di un turbinio di emozioni, che se in un primo momento hanno sembrato solo smuovere in me compassione e tristezza, da lì a qualche tempo mi hanno fatto capire che la vera natura dei bambini (e in generale di tutti i brasiliani) con cui ero entrata in contatto, è quella di trasmettere felicità, di ballare e cantare anche al di fuori dell’ora di musica, perché è giusto così e basta.
Adesso che è arrivato l’ultimo giorno, mentre faccio le valigie mi rendo conto di quanta gioia mi abbia lasciato quest’esperienza, che sembra passata in un battere di ciglia, così come è arrivata.
Me ne vado con i colori dei pennarelli sui fogli regalati dai bambini, con il ricordo dei sorrisi, oltre ai profumi e al ritmo della samba, che mi è rimasto nel sangue.
«Heliopolis, – ripenso… – Avevo sbagliato quando credevo non fosse il nome adatto, è invece proprio il nome che sceglierei ora per definirlo: la città del sole, perché qui non esistono nuvole e il volto si volge sempre verso il cielo con un sorriso.»
Astrid Panizza
(Continua)