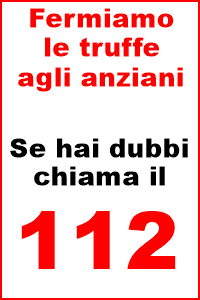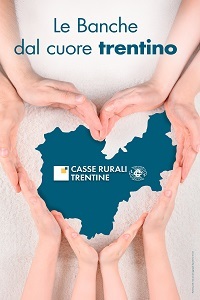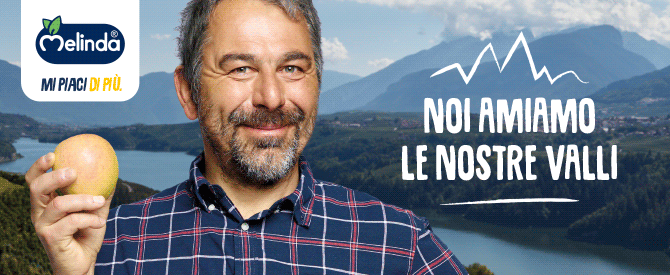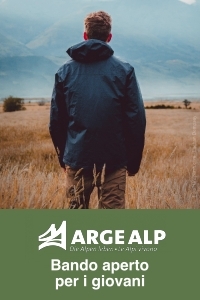Storie di donne, letteratura di genere/ 480 – Di Luciana Grillo
Maria Rosa Pagnani, «Donne da raccontare - Isabella e le altre» – Le vite difficili di 6 donne che hanno combattuto per affermare i loro diritti e la loro dignità

Titolo: Donne da raccontare - Isabella e le altre
Autrice: Maria Rosa Pagnani
Editore: Buccinesi nel mondo, 2021
Genere: Letteratura femminile contemporanea
Pagine: 174
Prezzo di copertina: € 10
L’autrice si autodefinisce «archeologa di genere» e il suo testo risponde pienamente a questa etichetta: Maria Rosaria Pagnani scava fra documenti e vecchi libri, si immerge in mondi affascinanti, lontani fra loro nel tempo, e racconta le vite di sei donne «che volevano contare in famiglia, nella comunità…» ma erano state invitate o obbligate a farsi da parte, in un periodo in cui a contare erano solo gli uomini.
Eppure, nonostante abbiano rinunciato alle loro aspirazioni, sono riuscite ad arrivare fino a noi, con le loro storie di amore, morte, monacazione forzata, proprio grazie al lavoro certosino di una studiosa che, per uno strano intreccio di vicende, ha trascorso i primi anni della sua vita nella stessa casa dove abitò – dal matrimonio alla morte – Margherita Colonna Caracciolo, una delle sei «Donne da raccontare».
La prima è una poetessa lucana colta e affascinante, Isabella di Morra, vissuta nella prima metà del ’500, che pensa «per una vita intera ho avuto l’impressione che uomini e cose mi avrebbero accusata per l’eternità di essere una svampita, una sognatrice, una poco di buono che osa avvicinarsi al mondo della cultura riservato agli uomini. Una esaltata che trascorre molto del suo tempo a studiare e osa, addirittura, scrivere versi».
Parla di «una vita intera» ma la sua vita fu davvero brevissima: fu uccisa dai suoi fratelli a soli 26 anni!, una giovane donna che sognava soltanto di «essere: libera, agiata moglie e madre, disinvolta ospite, accorta amministratrice dei propri possedimenti…» e di poter studiare, scrivere, comporre poesie.
L’autrice torna indietro nel tempo per parlarci di Ponzia Postumina, vissuta nel I secolo dopo Cristo, amante di Ottavio Sagitta: di lei a Roma si chiacchierava molto, perché - dicevano - «non aveva alcun pudore a nascondere la sua tresca», trascurava il marito, «non si sedeva più a mensa… non si curava del bene della casa…». Riuscì a far sciogliere il suo matrimonio e rientrò nella casa paterna, rifiutando però con fermezza la proposta di nozze di Ottavio: «Ponzia assaporava il piacere di essere finalmente padrona di se stessa e del suo tempo… troppo presto era passata dalla tutela genitoriale a quella maritale e ora, da donna matura, poteva conoscere la libertà».
Era troppo moderna, troppo ribelle, Ponzia, e Ottavio le tolse la vita.
Nel 1600 visse Margherita Colonna Caracciolo, sposa di Francesco Caracciolo, Duca di Martina e Signore di Buccino: a raccontarne la storia è la levatrice – o vammana – che fu chiamata all’alba di un giorno freddo e nevoso per andare ad assistere donna Margherita, ormai prossima al suo primo parto.
La levatrice ne ripercorre la storia, il suo arrivo da Napoli, la sua generosità: «non distribuiva alle donne affamate solo pane, ma anche strumenti di lavoro, fusi, telai e lane in quantità», la notizia attesa della gravidanza, i primi mesi sereni, i preparativi del corredino, la visita a Palazzo del «dottore fisico Giovanni Amendola… per il dottore sono soltanto una strega e una buona a niente, è convinto che il controllo delle malattie sia riservato ai religiosi, ai ricchi e ai pochi medici fisici».
Le cose non vanno bene, nasce la piccola Isabella, ma il parto è difficile e doloroso, Margherita muore dopo aver espresso le sue ultime volontà, «mentre Francesco, cosparso il capo di cenere, vestito di un sacco, somigliante al saio del Santo di cui porta il nome, è rimasto chiuso in una stanza addobbata a lutto, senza voler vedere nessuno».
Pochi giorni dopo la mamma, morirà anche la piccola Isabella, «e il Palazzo cadde nel più grave sconforto».
Un’altra storia di donna vissuta nel 1700 è raccontata dal suo Angelo Custode: si tratta di Felicia, fin da bambina «arrendevole al volere del Signore nel rinserrarsi nella clausura…a rinunciare agli effimeri richiami della femminilità».
Aveva circa 10 anni quando morì il papà e fu affidata pima allo zio Giovanni, arciprete di Contursi, poi ad un altro zio, don Giovambattista, a Ripacandida dove Felicia volle creare un monastero di clausura, un conservatorio e un giardino, tra mille difficoltà.
Felicia diventò Suor Maria di Gesù della Santissima Trinità e tempo dopo la Priora, che raccolse intorno a sé molte giovani, spesso «fanciulle spaventate che fuggivano dal mondo».
L’Angelo Custode ha seguito e accompagnato la piccola Felicia, che aveva conservato la sua fede per tutta la vita, che aveva conosciuto Sant’Alfonso Maria de’ Liguori e San Gerardo Maiella, «fino al cospetto dell’Altissimo».
Era il 18 maggio 1803. Nel 2007 è stata avviata la fase anti-preparatoria della causa di canonizzazione.
Un figlio parla con infinita tenerezza di sua madre Graffia «che ha lottato venti anni contro la mala giustizia… quel 20 ottobre del 1441 mia madre, vedova di Tommaso Grempo, detto Masio, chiedeva la restituzione della terra, e i frutti di un anno, oltre al rimborso delle spese sostenute…a **** citato in giudizio perché quattro anni prima si era impadronito della nostra vigna».
Questo figlio, orgoglioso di aver ampliato le proprietà e di poter offrire alla madre una vecchiaia serena, ricorda quanto da giovane vedova sia stata criticata e sbeffeggiata perché, secondo i paesani, «una vedova onesta doveva rinunciare alle battaglie legali e alle spese inutili…».
La povera Graffia lavorava dalla mattina alla sera, coltivava le terre, lavava i pavimenti del convento, «andava a legna e a cicorie», tesseva il lino, faceva crescere i suoi figli con amore.
Dopo alcuni anni, la causa fu vinta e la vedova entrò in possesso di due botteghe, nella piazza del paese.
I figli le sistemarono e dotarono di banconi, ma Graffia, finalmente, decise di riposare e prese l’abitudine di sedersi davanti per vedere chi passava e per farsi vedere, con i capelli in ordine ed un bel vestito.
Avrebbe voluto raccontare ai passanti la sua storia, ma era trascorso tanto tempo, e non interessava più a nessuno!
Maria Rosaria Pagnani non si ferma neanche davanti a storie scabrose per i tempi in cui si svolsero: l’ultima protagonista che ci presenta è Emilia, vissuta nel 1400, figlia di una madre fragile e di un padre violento: «nessuna tenerezza per lei, abbandonata a se stessa… Così è cresciuta Emilia, accucciata in un angolo accanto al fuoco d’inverno e sull’uscio di casa in estate, fino alla pubertà».
Fu allora che iniziò a odiare se stessa e il suo corpo che mutava: e se fosse stata un maschio? «Forse avrebbe potuto tenere testa al padre e smorzare i suoi istinti bestiali».
Cominciò a fasciarsi il seno, si rase i capelli, con bioccoli di lana si costruì un pene.
Ma in paese si notò il suo comportamento strano, la madre ne parlò con il parroco, Emilia fu considerata una indemoniata, picchiata davanti alla chiesa perché «attraverso il sangue anche il Maligno trovasse la strada per lasciare la sua vittima», reclusa in casa, finché non si decise di farla sposare con un certo Antonio, «che sembrava un brav’uomo, di poche parole e di modi gentili».
Emilia decise di tacere. Dal matrimonio nacque Emilio… o forse fu Emilia finalmente a diventare Emilio.
Tutte queste storie non sono frutto di racconti orali, ma sono comprovate dalla descrizione di documenti dell’epoca che Pagnani ha letto, studiato e trascritto almeno in parte a conclusione di ciascuna storia, ad esempio quella di Ponzia è tratta dagli Annales di Tacito, mentre di Margherita e del suo testamento sono riportati i dati ripresi dai Protocolli notarili dell’Archivio di Stato di Salerno; quanto a Graffia e alla vicenda giudiziaria, l’autrice ha trovato le notizie nei Regesti delle pergamene di San Francesco da Eboli, mentre la vita della transgender Emilia è tratta dalla Descrittione del Regno di Napoli dello storico ed erudito Scipione Mazzella.
In conclusione, M. Rosaria Pagnani ci ha presentato le vite difficili di sei donne che hanno combattuto per affermare i loro diritti e la loro dignità. E dal momento che ne parliamo ancora, possiamo ben dire che hanno vinto!
Luciana Grillo – [email protected]
(Recensioni precedenti)