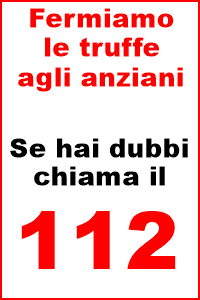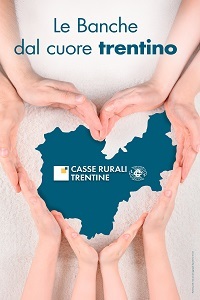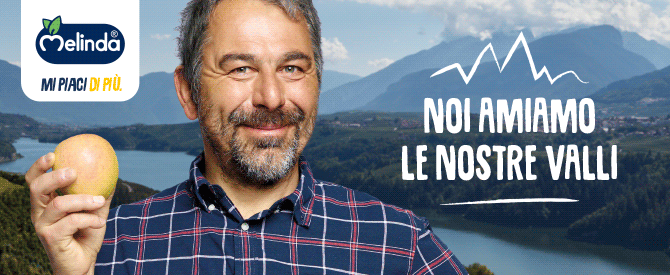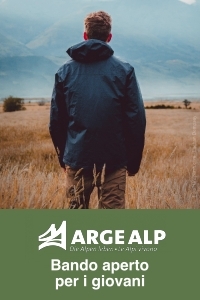Trento, conclusa la mostra su Bonazza – Di Daniela Larentis
Poesia, mito e memoria per l’evento collegato alla mostra su Luigi Bonazza a Palazzo Trentini: in sala anche la donna ritratta in «Verbena»

>
Tra gli appuntamenti più significativi che hanno accompagnato la mostra «A sessant’anni dalla morte. Luigi Bonazza. Trento, la montagna, il Circolo degli artisti» – curata da Roberta Bonazza e Nicoletta Tamanini e ospitata a Palazzo Trentini e alla Cappella Vantini dal 5 aprile al 16 maggio 2025 – venerdì scorso si è tenuto un evento denso di emozione e riflessione, che ha visto poesia e arte incontrarsi in un dialogo profondo nelle sale di Palazzo Trentini.
Il poeta Massimo Parolini ha proposto un’intensa lettura di versi poetici ispirati o collegati alle opere di Bonazza.
Tra questi, la poesia «Ritratto di Verbena», dedicata all’omonimo dipinto, ha assunto un significato particolarmente toccante grazie alla presenza in sala di Maria Elena Losco, la donna ritratta nel quadro eseguito nel 1950.
Ex campionessa italiana di pattinaggio artistico, figlia del proprietario del colorificio frequentato dal pittore, ha potuto rivedere, dopo oltre settantacinque anni, l’immagine di sé impressa sulla tela.
Accanto alle letture poetiche, le curatrici Roberta Bonazza e Nicoletta Tamanini hanno offerto una riflessione critica che ha permesso di contestualizzare la produzione dell’artista, il cui percorso formativo a Vienna e il radicamento a Trento alimentarono una visione artistica che, in molte sue opere, si espresse attraverso il simbolismo e l’allegoria.
Durante l’evento, l’architetto Roberto Codroico ha approfondito il significato dell’affresco di Bonazza al Palazzo delle Poste di Trento, offrendo al pubblico una lettura storica e artistica dell’opera.
Nel catalogo che ha accompagnato la mostra, Codroico – oltre a un saggio dedicato all’affresco del Palazzo delle Poste – ha firmato un ampio contributo sulla casa-atelier dell’artista alla Bolghera. L’abitazione, esternamente sobria e ottocentesca, fu completamente decorata da Bonazza nel corso di decenni, trasformandola in un’opera d’arte totale, espressione della sua personale visione simbolista e secessionista.
«Hortus conclusus in cui si chiuse per sognare», come la descrive Codroico, la casa è interamente dipinta da Bonazza, senza un ordine narrativo prestabilito, ma con immagini che esprimono vissuti emotivi e riferimenti colti.
Vi compaiono Orfeo con la lira, le Muse, Dafne, la Sfinge, Apollo e le Ore, insieme a raffigurazioni mitologiche e stagionali, in una decorazione continua che richiama la cultura classica e l’estetica dello Jugendstil viennese.
Non mancano citazioni scultoree, come la testa in gesso dello «Schiavo morente» di Michelangelo, collocata in una nicchia sopra una delle pitture murali.
Negli anni più bui della Seconda guerra mondiale, turbato dai bombardamenti su Trento, Bonazza arrivò a rimuovere parte delle sue pitture murali per proteggerle.
La casa, come osserva Codroico, «è una lettera d’amore per un tempo passato, ma ancora vivo», che l’artista stesso ha sigillato con parole struggenti lasciate poco prima della morte: «Chiudo dietro di me la porta della mia casa, solitaria / e la mia storia è finita».

Brevi cenni biografici
Luigi Bonazza.
Artista tra i più rappresentativi del primo Novecento trentino, inizia la sua formazione alla Scuola Reale Elisabettina di Rovereto, che frequenta tra il 1890 e il 1893.
Nel 1897 si trasferisce a Vienna, dove studia alla Kunstgewerbeschule: prima nel corso di Felician von Myrbach, raffinato illustratore che lo introduce all’incisione e all’acquerello, poi, dal 1898, con Franz von Matsch, pittore legato all’ambiente dei Klimt.
A Vienna affitta un atelier, collabora con riviste e riceve le prime commissioni.
Vince nel 1904 un concorso promosso dalla rivista milanese La Lettura, inizia la grande tela «La leggenda di Orfeo» e dà avvio al ciclo «Jovis Amores», una serie di incisioni mitologiche esposte alla mostra della Secessione e pubblicate su riviste come Die Kunstwelt, The Studio e The Graphic.
Nel 1911 inizia il ciclo delle «Allegorie del giorno».
L’anno seguente, nel 1912, torna stabilmente a Trento, ottiene la cattedra all’Istituto Tecnico ed è tra i fondatori del Circolo Artistico Trentino, del quale è primo presidente.
Nel 1914, poco prima dello scoppio della guerra, si rifugia a Milano; in estate lavora come disegnatore tecnico alle Officine Caproni di Vizzola Ticino, dove realizza acqueforti dedicate ai velivoli. Rientra a Trento alla fine del 1918 e riprende l’insegnamento. Nel 1930 gli viene affidata la decorazione del Palazzo delle Poste di Trento, dove realizza l’affresco «Dei tre cardinali al tempo del Concilio».
Negli anni Trenta esegue affreschi sacri per alcune chiese trentine e, tra il 1935 e il 1938, soggiorna a Torbole, dove dipinge paesaggi lacustri.
In questi anni si dedica principalmente alla pittura da cavalletto, alternando ritratti e paesaggi.
Il suo stile, segnato dal simbolismo e dalla cultura mitteleuropea, si esprime in affreschi, opere allegoriche, incisioni e vedute.
Collabora per tutta la vita con la SAT e la SOSAT, celebrando nelle sue opere la montagna come dimensione dell’anima.
Interrompe l’attività artistica all’inizio degli anni Sessanta per problemi alla vista.
Muore nella sua casa di Trento il 4 novembre 1965.
L’evento poetico ha così rappresentato una sintesi tra parola e immagine: un omaggio non solo a un artista, ma a una stagione culturale in cui l’arte seppe parlare anche con il linguaggio del mito, della natura e dell’interiorità.
Massimo Parolini
«Ritratto di Verbena»
Verbena nasce
dallo sfondo del quadro
e il soffio di luce
-diffuso e malinconico-
si impasta alle sue vesti
-parusìa iperuranica-
nel vibrare del chiarore
il volto inespressivo
ci porta fatalmente
a un ideale femminile
senza più spazio né tempo
verso l’orlo di un Altrove [ ( ) ]
Maria Elena Losco
figlia del colorificio
che dà il colore al pittore
da ora è una Vestale:
guardiana degli altari
ci offre il fiore
che le dà nome:
Verbena: scaccia pietre
cara a Venere
lacrima d’ Iside e di Era
cura ferite
sul Calvario
al Verbo che ha preso carne
[svuotando se stesso per farsi servo]
prima di porlo dentro al sudario
Verbena: musa dei Bardi
fiore delle spose
gioia delle culle
filtro magico d’amore:
amo vederti nei campi incolti
fra il botton d’oro
e l’aglio orsino
la borracina bianca
e il lampascione
il verbasco
e il millefoglio [ ]
Verbena: un nome
un fiore
un suono
da un’altra Soglia
Daniela Larentis – [email protected]